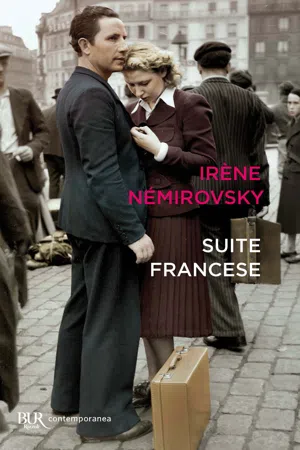![]() TEMPORALE DI GIUGNO
TEMPORALE DI GIUGNO![]()
1
LA GUERRA
Sarà dura, pensavano i parigini. Aria di primavera. Una notte di guerra, l’allarme. Ma la notte svanisce, la guerra è lontana. Quelli che non dormivano, i malati nei loro letti, le madri con un figlio al fronte, le donne innamorate con gli occhi sciupati dal pianto, sentivano il primo soffio della sirena, ancora solo un ansito profondo simile al sospiro che esce da un petto oppresso. In pochi istanti il cielo tutto si sarebbe riempito di clamori. Che venivano da lontano, dall’estrema linea dell’orizzonte – senza fretta si sarebbe detto. Quelli che dormivano sognavano il mare che spinge davanti a sé i ciottoli e le onde, la tempesta di marzo che scuote la foresta, una mandria di buoi che galoppano pesanti facendo tremare il suolo con gli zoccoli; ma il sogno finiva e socchiudendo appena gli occhi gli uomini mormoravano: «È l’allarme?».
Le donne, più ansiose, più pronte, erano già in piedi. Alcune, dopo aver chiuso imposte e finestre, tornavano a letto. Il giorno precedente, lunedì 3 giugno, per la prima volta dall’inizio della guerra, Parigi era stata bombardata; ma la popolazione non si era fatta prendere dal panico, benché le notizie fossero tutt’altro che buone. Nessuno riusciva a crederci. Così come nessuno avrebbe creduto all’annuncio di una vittoria. «Chi ci capisce qualcosa è bravo» diceva la gente. Le madri vestivano i bambini facendo luce con una pila. Poi alzavano di peso i piccoli corpi inerti e tiepidi: «Vieni, non aver paura, non piangere». È l’allarme. Si spegnevano tutte le luci, ma sotto quel cielo di giugno dorato e trasparente ogni casa, ogni strada era visibile. Mentre la Senna pareva concentrare in sé ogni sparso chiarore per poi rifletterlo, centuplicato, come uno specchio sfaccettato: le finestre non oscurate a sufficienza, i tetti che luccicavano nell’ombra leggera, le guarnizioni di ferro delle porte su cui ogni sporgenza brillava debolmente, qualche semaforo rosso che, chissà perché, durava più a lungo degli altri – la Senna li attirava, li catturava e li faceva danzare nei suoi flutti. Dall’alto, doveva sembrare un fiume di latte. “Guida gli aerei nemici” pensavano alcuni. Altri affermavano che era impossibile. In realtà nessuno sapeva niente. «Me ne resto a letto» mormoravano voci assonnate, «non ho paura.» «Basta una volta e siamo fritti» rispondevano voci più sagge.
Nei palazzi nuovi, attraverso le vetrate che proteggevano le scale di servizio, si vedevano scendere una, due, tre fiammelle: gli inquilini del sesto piano fuggivano da quelle altezze puntando davanti a sé le pile tenute accese in barba ai regolamenti. «Preferisco non rompermi il collo sulle scale, vieni, Émile?» Tutti, istintivamente, abbassavano la voce come se lo spazio si fosse d’un tratto popolato di sguardi e di orecchie nemici. Si sentivano sbattere le porte, che venivano richiuse una dopo l’altra. Nei quartieri popolari metropolitane e rifugi – nei quali stagnava ormai un gran lezzo di sporcizia – erano sempre affollati, mentre i ricchi si limitavano a fermarsi nelle portinerie dei loro palazzi tendendo l’orecchio agli scoppi e alle detonazioni che avrebbero annunciato la caduta delle bombe, attenti, tesi come animali trepidanti acquattati nei boschi quando scende la notte della caccia. Non è che i poveri fossero più impauriti dei ricchi o più attaccati alla vita, ma avevano, più di loro, la tendenza a vivere in gruppo, avevano bisogno gli uni degli altri e di sostenersi a vicenda, di piangere o di ridere insieme. Stava per spuntare il giorno; un riflesso pervinca e argento sfiorava le strade, i parapetti dei lungosenna, le torri di Notre-Dame. Sacchi di sabbia coprivano fino a metà altezza gli edifici più importanti, nascondevano le danzatrici di Carpeaux sulla facciata dell’Opéra, spegnevano il grido della Marsigliese sull’Arco di Trionfo.
In lontananza, echeggiavano colpi di cannone che via via si facevano più vicini, e i vetri tremavano, in risposta. Bambini nascevano dentro camere afose in cui le fessure delle finestre erano state sigillate per non lasciar trapelare la luce, e i loro pianti facevano dimenticare alle donne il fragore delle sirene e la guerra. Alle orecchie dei morenti le cannonate sembravano deboli e insignificanti, un rumore in più nel sinistro e vago brusio che accoglie l’agonizzante come un’onda. I piccoli, appiccicati al fianco caldo della madre, dormivano placidamente, le boccucce aperte in uno schiocco leggero, simile a quello dell’agnellino che succhia il latte. Abbandonati durante l’allarme, carrettini di frutta e verdura rimanevano in strada con il loro carico di fiori freschi.
Il sole, ancora tutto rosso, saliva in un cielo senza nuvole. Partì una cannonata così vicina a Parigi che tutti gli uccelli volarono via dalla sommità dei monumenti. Più in alto si libravano grandi uccelli neri, di solito invisibili, spiegavano sotto il sole le ali di un rosa argenteo, poi venivano i bei piccioni grassi che tubavano e le rondini, i passeri che saltellavano tranquillamente nelle strade deserte. Su ogni pioppo dei lungosenna c’era un nugolo di uccelletti scuri che cantavano frenetici. Nelle profondità dei rifugi arrivò infine un segnale remoto, attutito dalla distanza, sorta di fanfara a tre toni: il cessato allarme.
![]()
2
I Péricand avevano ascoltato alla radio il bollettino della sera in un silenzio sgomento, ma nessuno aveva commentato le notizie. Erano dei benpensanti; le loro tradizioni, la forma mentis, un certo retaggio borghese e cattolico, nonché i legami con la Chiesa (il figlio maggiore, Philippe Péricand, era stato ordinato sacerdote), tutto li portava a considerare con diffidenza il governo della Repubblica. Al tempo stesso, la posizione del signor Péricand, soprintendente di un grande museo nazionale, li rendeva partecipi di un regime che con i suoi servitori era prodigo di onori e benefici.
Con grande cautela, un gatto teneva fra i denti aguzzi un brandello di pesce pieno di spine: ingoiarlo gli faceva paura, sputarlo gli sarebbe dispiaciuto un po’.
Tutto considerato, Charlotte Péricand riteneva che solo la mente maschile potesse giudicare con serenità avvenimenti così strani e gravi. E al momento né suo marito né il figlio maggiore si trovavano lì: il primo cenava in casa di amici, il secondo non era a Parigi. La signora Péricand dirigeva con polso fermo tutto ciò che atteneva alla vita quotidiana – dal governo della casa all’educazione dei figli o alla carriera del marito – e non aveva bisogno di chiedere il parere di nessuno. Ma questo era un ambito diverso, bisognava che una voce autorizzata le dicesse preventivamente che cosa avrebbe dovuto pensare. Una volta messa sulla buona strada, procedeva poi a tutto vapore e non conosceva ostacoli. Se le si dimostrava, prove alla mano, che la sua opinione era errata, rispondeva con un sorriso freddo e altezzoso: «Me l’ha detto mio padre», oppure: «Mio marito è ben informato». E con la mano guantata tracciava nell’aria un piccolo gesto perentorio.
La posizione del marito la lusingava (lei avrebbe preferito una vita più casalinga, ma secondo l’esempio del nostro Divino Salvatore ciascuno di noi, quaggiù, deve portare la sua croce!). Era rientrata in casa – un breve intervallo tra una visita e l’altra – per controllare i compiti dei bambini, i biberon del neonato, i lavori dei domestici, e non aveva ancora trovato il tempo di togliersi tutta la bardatura. Nel ricordo dei figli Péricand, la madre figurava sempre pronta per uscire di casa, cappello in testa e guanti bianchi debitamente infilati. (Parsimoniosa com’era, i suoi guanti, spesso rinfrescati, avevano un leggero odore di benzina, prova incontestabile del loro passaggio in tintoria.)
Anche quella sera era appena rientrata e stava in piedi nel salotto, davanti alla radio. Tutta vestita di nero, portava un cappellino all’ultima moda, una cosina deliziosa guarnita con tre fiori e un pompon di seta calcata sulla fronte. Il suo volto era pallido e angosciato, e accusava più che mai i segni dell’età e della stanchezza. La signora Péricand aveva quarantasette anni e cinque figli. Era una donna alla quale di sicuro Dio aveva destinato una capigliatura rossa. Lo provavano la pelle molto sottile, sciupata dagli anni, il naso, forte e importante, spruzzato di efelidi, e gli occhi verdi che lanciavano dardi penetranti, da gatto. Ma, all’ultimo minuto, la Provvidenza doveva aver esitato o considerato che una capigliatura troppo accesa non si sarebbe accordata né all’irreprensibile moralità della signora Péricand né al suo rango, e l’aveva dotata di capelli di un castano spento che dopo la nascita dell’ultimo figlio cadevano copiosamente. Il signor Péricand era un tipo rigoroso: i suoi scrupoli religiosi gli impedivano di piegarsi a un buon numero di desideri e, preoccupato com’era della propria reputazione, si teneva alla larga da luoghi di malaffare. Perciò il più piccolo dei Péricand aveva solo un anno, e fra il reverendo Philippe e l’ultimo nato si susseguivano tre figli, tutti vivi, che la signora Péricand chiamava pudicamente «tre incidenti» – senza contare il bambino portato quasi fino al termine della gravidanza. Tre incidenti che l’avevano condotta tre volte sull’orlo della tomba.
Il salotto, dove in quel momento echeggiava la voce della radio, era un ampio locale di proporzioni armoniose, con quattro finestre che davano su boulevard Delessert. Era arredato all’antica, con grandi poltrone e divani giallo oro trapuntati a losanghe. Vicino al balcone c’era la sedia a rotelle del vecchio signor Péricand, ora invalido, che l’età molto avanzata a volte faceva tornare bambino; riacquistava piena lucidità solo quando si trattava del suo ingente patrimonio (era un Péricand-Maltête, erede dei Maltête di Lione). Ma la guerra e le sue vicissitudini non lo toccavano più; vi prestava un orecchio distratto, scuotendo ritmicamente la bella barba d’argento. Dietro la mater familias i figli erano disposti a semicerchio, compreso il più piccolo in braccio alla bambinaia. Questa, madre di tre figli al fronte, aveva portato lì il piccolino per la buonanotte alla famiglia e approfittava della temporanea ammissione in salotto per ascoltare con angosciata concentrazione le parole dello speaker.
Dietro la porta socchiusa la signora Péricand avvertì la presenza degli altri domestici: la cameriera Madeleine, spinta dall’apprensione, si portò addirittura fin sulla soglia, e alla signora Péricand questa infrazione alle usanze parve un brutto segno: è così che, durante un naufragio, tutte le classi sociali si ritrovano mescolate sul ponte. Ma il popolo mancava di autocontrollo. “Come si lasciano andare” pensò con aria di biasimo. La signora Péricand apparteneva a quel tipo di borghesi che hanno fiducia nel popolo. «Non sono cattivi, basta saperli prendere» diceva con il tono indulgente e un po’ sconsolato che avrebbe usato per parlare di una bestia in gabbia. Si vantava di riuscire a tenere molto a lungo presso di sé i domestici e si faceva un dovere di curarli personalmente quando si ammalavano. Una volta Madeleine aveva avuto la tonsillite: le preparava i gargarismi con le sue mani. Poiché durante la giornata non trovava un momento libero, lo faceva alla sera, dopo il teatro. Madeleine, svegliata di soprassalto, testimoniava la sua riconoscenza solo a posteriori e per di più in termini alquanto freddi, pensava la signora Péricand. Ecco come sono quelli del popolo, mai contenti – e più ci si dà da fare per loro, più si mostrano volubili e ingrati. Ma la ricompensa la signora Péricand se l’aspettava solo dal Cielo.
Si voltò verso il vestibolo in ombra e disse con magnanimità: «Potete ascoltare il notiziario, se volete».
«Grazie, signora» mormorarono alcune voci rispettose, e i domestici entrarono circospetti nel salotto camminando in punta di piedi.
Madeleine, Marie, Auguste, il cameriere, e da ultima Maria, la cuoca, a disagio per via delle mani che sapevano di pesce. Il notiziario, del resto, era terminato. Ora seguivano i commenti: la situazione era «seria, certo, ma non allarmante», così assicurava lo speaker. Parlava con una voce così rotonda, così calma e rassicurante (ma che assumeva un tono squillante allorché pronunciava parole come «Francia», «patria», «esercito») da infondere ottimismo nei cuori di chi lo ascoltava. Aveva un modo tutto suo di dar lettura del comunicato secondo il quale «il nemico continua a martellare accanitamente le nostre posizioni scontrandosi con la vigorosa resistenza delle nostre truppe». Leggeva la prima parte della frase con tono leggero, ironico e sprezzante, quasi volesse dire: «Perlomeno è quello che cercano di farci credere». In compenso sottolineava con forza ogni sillaba della seconda parte, scandendo l’aggettivo «vigorosa» e le parole «le nostre truppe» con tanta sicurezza che la gente non poteva fare a meno di pensare: “Non è davvero il caso di preoccuparci più di tanto!”.
La signora Péricand colse gli sguardi interrogativi e speranzosi fissi su di lei e dichiarò con fermezza: «Non mi sembra che la situazione sia poi così brutta!».
Non ne era affatto convinta, ma riteneva suo dovere risollevare il morale delle persone che le stavano attorno.
Maria e Madeleine sospirarono.
«Lo crede davvero, signora?»
Solo Hubert, il secondogenito dei Péricand, un diciottenne paffuto e roseo, sembrava in preda a disperazione e sgomento. Si tamponava nervosamente il collo con il fazzoletto appallottolato ed esclamava con voce acuta e a tratti rauca: «Non è possibile! Guarda a che punto siamo arrivati! Ma insomma, mamma, che cosa aspettano ad arruolare tutti? Dai sedici ai sessant’anni, tutti gli uomini e subito! Questo dovrebbero fare, non credi, mamma?».
Corse fino allo studio, tornò con una grande carta geografica e la spiegò sul tavolo, misurando febbrilmente le distanze fra vari punti.
«Siamo perduti, ti dico, perduti a meno che…»
La speranza tornava a sorridergli.
«Io l’ho capito quello che si deve fare» annunciò quindi con un largo sorriso gioioso che gli scoprì i denti bianchi. «È molto chiaro: li lasceremo venire avanti, sempre più avanti, e noi li aspetteremo lì, poi lì, capisci, mamma! O anche…»
«Sì, sì» disse sua madre. «Su, va’ a lavarti le mani e sistemati quel ciuffo che ti cade sugli occhi. Guarda cosa sembri…»
Furente, Hubert ripiegò la sua mappa. Solo Philippe lo prendeva sul serio, solo P...