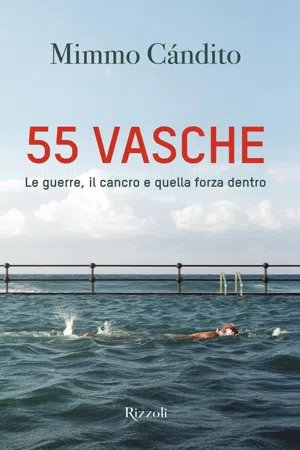![]()
1
La matita del dottor Levi
La paura di morire, la prima volta, mi prese in un tempo lontano da oggi, ma lontano davvero se il tumore allora non aveva ancora un nome, tutti lo chiamavano “quel brutto male”, e lo dicevano a voce bassa, bassi anche gli occhi, come per vergognarsi. Io, quel giorno, anzi quella notte, ero a Beirut, la capitale del Libano, tagliata in due da una guerra che sarebbe continuata ancora per quindici anni.
Non ero mai stato in guerra, prima. Avevo già raccontato l’America Latina e i suoi guerriglieri, ma erano frange d’un mondo che subiva conati di rivoluzione senza frantumarsi. La guerra no, la guerra squarcia una storia da dentro, non lascia spazi vuoti, consuma vite, speranze, illusioni, consuma passato e futuro. Io, ancora non lo sapevo; cominciai a impararlo da quel giorno di Beirut, all’Hotel Commodore.
Già arrivare in albergo non era stato facile, dalla strada dell’aeroporto si sparava e da una parte c’erano i palestinesi e dall’altra i maroniti libanesi. E non era soltanto lo scontro a fuoco con le armi leggere, tiravano anche cannonate e l’aria se ne riempiva con tonfi sordi. «Questa è in uscita» mi dicevano, outgoin’, oppure no, «questa arriva», incomin’. E io imparavo.
Ero emozionato, ma l’emozione non era ancora paura. Forse perché, fuori, per strada, c’era la luce forte del giorno, o forse, piuttosto, perché in quel momento la curiosità, la voglia di capire, si rubavano le mie emozioni.
Ma quando me ne andai a dormire, e Beirut era nera del buio cieco, e gli scontri a fuoco si avvicinarono che li sentivo quasi sotto la finestra con i pick-up che andavano sgommando e i cannoncini che tiravano, allora sì che l’emozione si trasformò di brutto, e mi sentii in trappola, che non sapevo che cosa fare, come comportarmi, dove proteggermi.
Era la metà degli anni Settanta, e oggi ne rido, ma quella notte mi buttai sotto il letto, vestito, pensando che comunque il materasso un po’ di protezione me la poteva dare. Mi addormentai, anche, per qualche attimo, perché prevalse la stanchezza; ma poi mi tirai su, e decisi che tanto valeva farsi animo, e che, se la cannonata arrivava, certamente non sarebbe stato un materasso a salvarmi.
Dormii fino a mattinata tarda, pacificato con me stesso.
Oggi che la morte l’ho sfiorata anche lontano dalla guerra, e che il tumore è stato ad appena un soffio d’aria da me, un soffio che poteva spengersi in ogni momento, quella paura di morire non ce l’ho più ormai da tempo. Ma anche chi scampa dal cancro resta comunque un sopravvissuto, uno cui la sorte ha fatto un regalo che vale la vita. E in America, dove anche la vita e la morte possono diventare materiale profittevole nel mercato della comunicazione e dei consumi, ne hanno fatto perfino un club, i Survivors, con i suoi spot colorati in Tv e, sotto, una musichetta dondolante, che sa di melassa: iscrivetevi, sarete più felici.
Il tumore, comunque, se non ne muori muta lentamente, a farsi una memoria delle tante, che va sbiadendo la sua spietata drammaticità e diventa un ritaglio qualunque della tua vita; proprio come quando il tuo lavoro di reporter ti sbatte via per il mondo a raccontare una guerra: l’Afghanistan, i deserti pietrosi dell’Iraq, il Congo delle sue foreste e dei suoi mille popoli, la Somalia. Sono storie, tutte, allo stesso modo orrende, che puzzano di morte, di piscio, e di sudore, e però ormai ti ci sei abituato, e allora nemmeno ti prende più l’affanno di quelle prime volte, ma solo l’angoscia disperata di non capire, più che una paura della morte.
Perché ora, dentro di te, capire conta assai più di qualsiasi paura, anzi la cancella, la paura: dà identità, consistenza concreta, a una realtà che all’inizio, quando arrivi in guerra, ti si mostra invece ambigua, angosciosa comunque, e che senti che non riesci a piegare al tuo bisogno di sapere per poterne tentare un controllo. Certo, in una guerra si giocano mille destini, o anche centomila, mentre nel tumore ci sei soltanto tu. Ma quel gioco disperato, per te è lo stesso, vale la vita e la morte. E tu vuoi capire.
Io l’ho scoperto, di avere un tumore, che nemmeno sembrava possibile che fosse quella roba lì.
Nel nostro immaginario, il cancro è una sorta di bestia infida che scatena reazioni emotive fuori da qualsiasi controllo; basta il soffio appena sussurrato di quella parola – tumore – perché ancora oggi si apra uno scenario dove tutto è segnato da un’ombra di morte inevitabile, i volti afflitti, i toni sommessi, uno sguardo che si fa subito commiserevole, e il rapporto con il malato si costringe di atti formali, come se già si fosse al funerale e un cordoglio muto e partecipe dominasse l’attesa.
Quella mattina lì, ero in braghe corte, una t-shirt con il faccione striato di Bob Marley, e un paio di espadrillas colorate dal mare.
Era l’estate del 2005, ed ero a Miami per raccontare della vita ribelle e dei sentimenti dei cubani esuli, scappati dall’isola di Castro e rifugiati in Florida. Sono più di un milione, e hanno un gran peso nella politica americana: non soltanto influenzano le decisioni del Congresso a Washington con la loro rabbia antica, contraria a qualsiasi allentamento dell’embargo verso l’Avana, ma il loro appoggio incide sul risultato delle elezioni presidenziali perché la Florida è uno degli Stati dell’Unione con le più alte quote di voti “elettorali”.
Da quando film di gran successo popolare, levigatissime serie televisive, e intere pagine di star sfrenate nei giri dello showbiz, ne hanno fatto il centro di racconti e di curiosità irresistibili, Miami, le sue discoteche, gli struggenti alberghi déco di Ocean Drive, sono diventati un orizzonte perdutamente felice, di spiagge bianche, mare blu, e follie mondane, una pellicola colorata che mima l’illusione d’una vita reale anche se poi per strada non sempre incontri Christian De Sica e nemmeno Bobo Vieri o le modelle dell’Olgettina.
A viverci dentro, però, i suoi giorni hanno ben poco delle disavventure lustre che i fratelli Vanzina raccontano al cinema, o dei misteri inquieti del Miami Vice che t’incolla al televisore; ma nel costume locale le braghe corte e le t-shirt restano di fatto l’uso comune dei giorni qualunque, per tutti. Anche quando vai in ospedale.
In quei giorni, e da qualche tempo, piegandomi a scrivere sulla tastiera del computer provavo un dolore intenso tra spalle e nuca. Cercavo di fare esercizi di relax, lievi massaggi distensivi, rotazioni lente della testa; ma senza un risultato apprezzabile. Per questo, alla fine, decisi di andare da un medico.
Il Mount Sinai Hospital, a Miami Beach, è quello che i tecnici definiscono «un presidio d’avanguardia», un grande ospedale con una decina di lunghi edifici di vetro e cemento distesi tra giardini di alte palme verdi e il blu intenso dell’oceano che si perde dentro l’orizzonte. La Florida, Miami, Palm Beach, sono, ormai da tempo, l’ultimo rifugio dei pensionati americani di buon reddito, soprattutto gli ebrei americani. Sole, mare, e il clima affettuosamente sempre caldo, danno un ristoro gradevole alle vecchie ossa segnate dal tempo, e gli ebrei della Florida – aiutati anche da un opportuno sgravio fiscale – usano lasciare ricche donazioni a questo ospedale che li assiste nel loro percorso finale, tanto più volentieri perché proprietà e gestione medico-amministrativa sono d’una società di capitale ebraico (il nome stesso che identifica ciascuno di quegli edifici, e le decine di targhe cementate nelle pareti dei lunghi corridoi del Mount Sinai, ricordano la generosità delle famiglie che hanno voluto ringraziare per l’assistenza ricevuta: e sono, tutti, nomi di evidente origine ebraica).
Avevo scelto quell’ospedale perché ci lavora una mia giovane amica, uno dei tanti “cervelli in fuga” dall’Italia, Francesca Gallarello, cardiochirurga di solida fama. Francesca mi portò da un suo collega, il dottor Levi, un vecchio medico internista, molto cortese, quieto nei modi e nelle parole.
Confesso che mi dava una sensazione assai rassicurante andare per quei lunghi corridoi silenziosi, incrociando giovani medici sorridenti con camici verdi che sembravano convincenti comparse del Dottor Kildare. Gli ospedali per i quali ero solito passare erano ben altro da questo compound di Miami Beach: in Africa, in Medio Oriente, in Asia, ho visto medici e infermieri operare tra rovine e macerie con camici di sangue e lordura, camere operatorie sventrate dai colpi, letti trasformati in ammassi di polvere, e il sangue e l’etere, e l’urlo disperato dei feriti, come unici segnali sopravvissuti d’un presidio sanitario. Nell’ospedale di Ajdābiya, sollevando per dovere di curiosità il coperchio d’un basso frigorifero che ancora andava grazie all’innesto d’un generatore, mi trovai davanti a un cadavere schiacciato a forza in quel piccolo spazio come un manichino senza ossa, le gambe e le braccia svitate, e la bocca orribilmente spalancata nell’urlo del dolore che lo torturava a morte. A pochi metri, un medico stava tagliando una gamba, senza anestesia, sotto una finestra sfondata. Le guerre non risparmiano più nemmeno gli ospedali; le leggi internazionali della guerra impongono ai combattenti di considerarli territorio neutrale, ma è una delle tante ipocrisie che nessuno finge ormai di rispettare.
Nella stanzetta linda e silenziosa del Mount Sinai, il dottor Levi chiuso nel suo camice bianco, la voce bassa, ascoltava attento il racconto del mio problema, e con brevi cenni del capo conveniva intanto che la mia ipotesi – un qualche problema alle vertebre cervicali – avesse molte probabilità d’essere una diagnosi convincente. Mi auscultò, mi invitò a fare alcuni movimenti del collo e delle spalle, saggiò i muscoli, e alla fine decise che sì, c’era sicuramente un qualche problema alle prime vertebre, ma che un paio di infiltrazioni di cortisone avrebbero attenuato il dolore e forse avrebbero anche ridotto la rigidità dei miei movimenti.
«Intanto, però, una radiografia io la farei ugualmente, in modo da accertare con precisione il grado di schiacciamento della colonna, là, nella regione del collo.»
Non avevo obiezioni, la richiesta mi sembrava sensata. Avevo soltanto una qualche fretta di andarmene: era una bellissima mattinata, nient’affatto rara a Miami, ma particolarmente calda e luminosa quel giorno, con un vento lieve che attenuava la presa del sole; e io avevo voglia di fare un gran tuffo nell’oceano (sotto le braghe, indossavo già il costume da bagno; terminata la visita, sarei andato direttamente in spiaggia, dall’altra parte della baia, in pochi minuti d’auto).
Quando il tecnico portò nella cameretta dello studio medico la lastra della radiografia, il dottor Levi l’infilò nella cornice della vetrina illuminata, e stette a osservarla. Ci stette però a lungo, troppo a lungo, mi sembrava di notare; e, anche, mi parve che stringesse un po’ le labbra come a concentrarsi, mutando l’espressione del viso in una sorta di contrazione segnata da un lieve tentennamento.
«C’è qualcosa che non va, dottor Levi?» Era una domanda fatta per chiedere una risposta comunque, senza che avessi ancora alcuna preoccupazione da quel lungo silenzio muto; al massimo, provavo un’ombra vaga di incertezza, come di qualcosa che però, alla fine, nemmeno mi riguardava. Stavo bene, ero in piena forma, viaggiavo per il mondo, amavo il sole e il mare. Tutto avrei potuto immaginare, meno che quello che il medico stava per dirmi.
Lui non rispose subito. Soltanto, si avvicinò ancor più alla luce opaca della vetrinetta, come a decifrare meglio la lastra appesa sullo schermo, con il disegno in bianco e nero del collo e del mio torace. Guardai lui, allora, e poi guardai anch’io la lastra, e poi di nuovo lui e il suo silenzio, e non so ancora perché ma mi venne un lampo. «Dottor Levi, ma c’è mica un tumore?»
Non sono un fumatore, non ho mai fumato, e anche se in quella radiografia vedevo il disegno del mio busto, il collo, il torace, la colonna vertebrale, i polmoni, anche i polmoni certamente, però io in ospedale c’ero andato a farmi visitare per un problema che con i polmoni non aveva proprio nulla a che fare. E dunque, perché quella sua matita che si era avvicinata al disegno dei polmoni, e ne sfiorava il tracciato, segnando nell’aria un piccolo cerchio?
Non provavo alcun affanno, soltanto il desiderio di sapere che cosa potesse contenere quel silenzio perplesso. Il mio lavoro a raccontare le guerre e gli uomini che le fanno, e le vite ridotte in macerie, le distruzioni, la disperazione dei sopravvissuti, la puzza dolciastra della battaglia appena passata, quel lavoro si accompagna sempre con la presenza della morte: la morte sta lì con te, accanto a te, nelle corse che fai sul terreno per cercare un riparo, nei tiri che ti sfiorano sibilando come frustate rapide dentro l’aria, negli occhi di paura e di terrore dei soldati, nei cadaveri che si disfano sulla terra; sta lì e sai però – lo sai, lo pensi, dentro – che mai ti prenderà.
Tuttavia, questa presenza, costante e però inafferrabile, mi ha anche dato un ordine mentale dove la linea che separa vita e morte è segnata appena, forse già indistinta, come se ormai l’una e l’altra, la vita e la morte, sfuggissero al dovere di differenziarsi, e si fondessero invece in uno spazio comune, lo stesso per entrambe.
Forse la matita del dottor Levi stava disegnando un destino, e però, ancora, io provavo soltanto curiosità.
«Sì, forse... Vede questa grossa macchia biancastra, lì, in alto, sul polmone a sinistra, be’ quella non dovrebbe proprio esserci. Non so se sia davvero un tumore, però devo dire che lo sembra. E bisogna accertarsene, subito... Ma lei fuma, molto? Ha molta tosse, dolori al petto?»
Lo guardavo stupito, e all’improvviso sentivo che qualcosa era cambiato: che una ipotesi astratta, che avevo tirato dentro con leggerezza, quasi per un dovere di compiacenza verso il medico, ora forse diventava una realtà concreta, anche drammatica.
Non ne avevo la misura certa, non riuscivo a capire bene che cosa quelle parole del dottor Levi significassero davvero per me, per la mia vita, anche per ciò che in quei giorni banalmente stavo facendo, le interviste, i bagni nell’oceano, il sole forte. Però mi ritrovai improvvisamente nella stretta brutale delle emozioni che l’idea del tumore scatena dentro lo stomaco, a solo sentirne il nome.
Ci credevo, forse, ma in realtà non ci credevo ancora.
Mi guardai il petto, lì, a sinistra, come se quella grossa macchia biancastra della radiografia si fosse ora trasferita sulla carne del mio torace nudo, quasi a disegnarne un imprevedibile tatuaggio. Non avevo paura, soltanto un’accelerazione dei miei pensieri e del respiro, la stessa angoscia, lieve, controllabile e però sensibile, che mi prende ogni volta che – in un territorio dove si sta combattendo – entro in una zona dove ti muovi senza più riferimenti e senza garanzia alcuna, solo con te stesso e con il tuo respiro accelerato, e senti nell’aria i colpi dello scontro a fuoco, il tonfo sordo del mortaio, il razzo che fischia su di te e ti butti subito a terra e schiacci la faccia nella polvere e non sai mai come finirà.
Poi, in realtà, sai sempre che finirà che ti alzi e vai avanti. E vedi i cadaveri squarciati dietro l’angolo d’un muro sbrecciato, la puzza della carne arsa, le urla dei soldati che si fanno coraggio correndo verso nulla e hanno gli occhi sgranati della morte, ma tu continui ad andare. Perché è il tuo lavoro, e perché vuoi saperne di più, vuoi avvicinarti ancora più a quella linea invisibile dove vita e morte hanno la stessa faccia, e tu ci devi essere. Per capire.
Quando qualcuno ti rivela che hai un tumore – soprattutto se questa notizia ti arriva improvvisa, senza che ci siano stati segni d’un allarme che possa averti dato una qualche preparazione psicologica – la prima reazione non tiene nemmeno conto della dimensione reale di quella notizia; piuttosto, la proietti, inevitabilmente, nello scenario ingannevole dentro il quale tutti consumiamo le nostre conoscenze del cancro, conoscenze fatte di approssimazioni, pregiudizi, informazioni raccogliticce, soprattutto paure inconsce liberate per esorcizzare il timore d’un qualche “contagio”, quasi che, anche soltanto a parlarne, l’ombra inquietante d’una contaminazione possa sfiorarti e prenderti via con sé.
E quando ne parlo, io stesso avverto in coloro che mi stanno ascoltando una sorta di impaccio mal frenato, un imbarazzo che la cortesia – o una ipocrisia prudente – nasconde sotto le buone maniere dell’interessamento solidale, della comprensione dovuta a un’amara disgrazia. Ricordo che quand’ero ancora un bambino, a Reggio Calabria, mi aveva sempre colpito l’espressione che la mamma pronunciava quando qualcuno le comunicava una brutta notizia: un incidente serio, una malattia grave, una disgrazia (non dico il tumore perché che ci fosse “il tumore” lo scoprii più tardi, quando, da adolescente, seguii il misterioso male che lentamente segnava la decadenza fisica di papà, fino alla sua morte). Alla brutta notizia, la mamma diceva a...