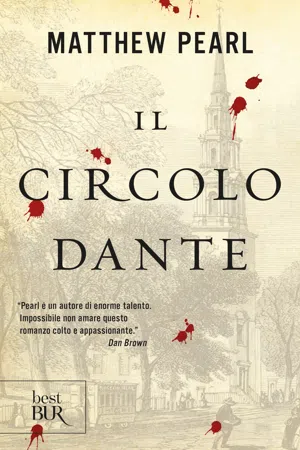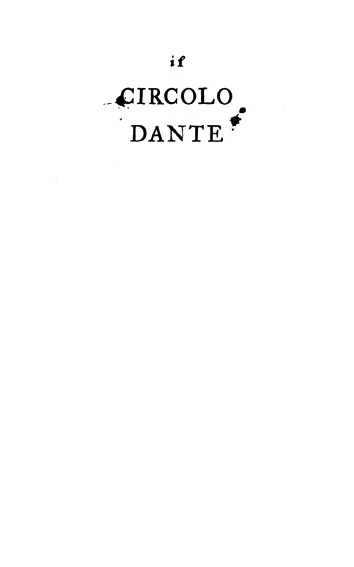![]()
![]()
A Lino, il mio professore,
e a Ian, il mio maestro
![]()
Avvertenza al lettore
Prefazione di C. Lewis Watkins,
docente di Retorica e
Civiltà e Letteratura Italiana
presso l’Università di Harvard
«Pittsfield Daily Reporter», «Community Notebook»,
15 settembre 1989
«RESURREZIONE» DI INSETTI DOPO LA
DISAVVENTURA DI UN RAGAZZO DI LEXINGTON
Martedì pomeriggio, le squadre di ricerca hanno tratto in salvo Kenneth Stanton, 10 anni, di Lexington, in un remoto angolo dei monti Catamount. Il ragazzino è stato ricoverato al Berkshire Medical Center perché alcuni insetti inizialmente non identificati si erano annidati nelle sue ferite deponendo larve e procurandogli dolore e gonfiore.
Secondo il dottor K.L. Landsman, entomologo dell’Harve-Bay Institute Museum di Boston, i campioni di mosca carnaria recuperati sul posto sono storicamente sconosciuti in Massachusetts. Particolare ancor più curioso, dichiara Landsman, gli insetti e le larve sembrano appartenere a una specie che gli scienziati ritengono del tutto estinta da quasi cinquant’anni. La Cochliomyia hominivorax, comunemente denominata mosca azzurra della carne, fu classificata nel 1859 da un medico francese su un’isola sudamericana. Alla fine dell’Ottocento, questa pericolosa specie si era ormai diffusa a livelli epidemici, uccidendo centinaia di migliaia di capi di bestiame in tutto l’emisfero occidentale e, a quanto pare, anche alcuni esseri umani. Negli anni Cinquanta del Novecento, un massiccio programma americano riuscì a eradicarla introducendo nella popolazione esemplari maschi sterili irradiati con raggi gamma e rendendo così le femmine incapaci di procreare. La disavventura di Kenneth Stanton ha forse condotto a una sorta di «resurrezione» degli insetti attuata in laboratorio a scopo di ricerca. «Benché l’eradicazione sia stata una saggia iniziativa di salute pubblica» sostiene Landsman «le nuove tecniche di osservazione permettono di imparare molto in un ambiente controllato.» Quando gli hanno chiesto come abbia reagito a questa fortunata riscoperta tassonomica, il giovane Stanton ha risposto: «Il mio maestro di scienze mi ha detto che sono stato bravissimo!».
Dopo aver letto il titolo del presente volume, vi domanderete che cosa questo articolo abbia a che vedere con Dante Alighieri, ma vi accorgerete presto che esiste un legame allarmante. Poiché sono un’autorità riconosciuta in fatto di accoglienza riservata alla Divina Commedia in America, la scorsa estate la Random House mi ha incaricato di scrivere, in cambio del solito misero compenso, qualche osservazione introduttiva per questo libro.
Il testo del signor Pearl trae spunto dalle vere origini della presenza di Dante nella nostra cultura. Nel 1867, il poeta H.W. Longfellow completò la prima traduzione americana della Divina Commedia, un rivoluzionario poema sull’aldilà. Al momento, esistono più traduzioni della poesia dantesca in inglese che in qualsiasi altra lingua, e gli Stati Uniti sono il Paese che ne produce il maggior numero. La Dante Society of America di Cambridge, Massachusetts, si vanta di essere la più antica organizzazione del mondo dedicata allo studio e alla promozione del poeta fiorentino. Come afferma T.S. Eliot, Dante e Shakespeare si ripartiscono il mondo moderno, e la metà occupata da Dante si allarga di anno in anno. Prima dell’opera di Longfellow, tuttavia, Dante era per noi un’entità quasi sconosciuta. Non parlavamo italiano e lo insegnavamo di rado; pochi di noi andavano all’estero, e negli Stati Uniti viveva solo un modesto numero di italiani.
Lasciandomi guidare dal mio acume critico, avevo concluso che, oltre a questi fatti essenziali, gli straordinari avvenimenti narrati da Il Circolo Dante appartenessero più alla leggenda che alla storia. Consultando i database di Lexis-Nexis per trovare conferma della mia valutazione, ho però scoperto lo sconcertante articolo del «Pittsfield Daily Reporter» riprodotto sopra. Dopo aver contattato senza esitazioni il dottor Landsman dell’Harve-Bay Institute, ho ricostruito con maggior precisione l’episodio accaduto quasi quattordici anni fa.
Kenneth Stanton si era allontanato dalla famiglia durante una battuta di pesca tra le colline del Berkshire ed era incappato in una strana fila di animali morti lungo un sentiero ricoperto di erbacce: prima un procione con l’ombelico congestionato di sangue, poi una volpe e infine, più avanti, un orso nero. In seguito, il ragazzino aveva riferito ai genitori di essersi sentito come ipnotizzato di fronte a quella grottesca scena. Aveva perso l’equilibrio ed era caduto su alcune rocce appuntite. Svenuto e con una caviglia fratturata, era stato aggredito dalle mosche azzurre della carne. Cinque giorni dopo, mentre a letto cercava di riprendersi, era morto a causa di un improvviso attacco di convulsioni. L’autopsia aveva rivelato dodici larve di Cochliomyia hominivorax, una delle specie di insetto più micidiali del mondo – estinta da cinquant’anni, o almeno così si credeva.
Da allora, le mosche ricomparse, che mostravano una capacità di adattamento a climi diversi mai osservata prima di allora, sono approdate in Medio Oriente, forse insieme con alcuni carichi di merce, e, mentre scrivo, stanno decimando il bestiame e l’economia dell’Iran settentrionale. Sulla base dei dati scientifici pubblicati negli Abstracts of Entomology dello scorso anno, negli ultimi tempi si è ipotizzato che l’evoluzione divergente di questi insetti sia iniziata negli Stati Uniti nordorientali intorno al 1865.
Se ci chiediamo come sia cominciato il processo, non troviamo alcuna risposta palese, se non – penso ormai con rammarico – nella storia de II Circolo Dante. Oltre cinque settimane fa, ho pregato otto dei quattordici docenti che collaborano con me durante questo semestre di esaminare il manoscritto di Pearl. Hanno analizzato e catalogato i contenuti filologici e storiografici riga per riga, rilevando con vivo interesse i piccoli errori imputabili soltanto all’ego dell’autore. Abbiamo modo di constatare ogni giorno quanta gloria e quanta ostilità abbiano incontrato Longfellow e i suoi protettori nel seicentesimo anniversario della nascita di Dante. Ho rinunciato al mio compenso, perché questa non era più una prefazione, bensì un avvertimento. La morte di Kenneth Stanton spalanca la porta attraverso cui Dante entra nel nostro mondo, la porta dei segreti ancora latenti nella nostra epoca. Voglio solo metterti in guardia, lettore. Per favore, se decidi di proseguire, ricorda che le parole possono uccidere.
Professor C. Lewis Watkins
Cambridge, Massachusetts
![]()
I
Il commissario John Kurtz, il capo della polizia di Boston, trattenne il fiato per stringersi meglio tra le due cameriere. Da una parte, la irlandese che aveva scoperto il cadavere piagnucolava e singhiozzava recitando preghiere sconosciute (perché erano cattoliche) e incomprensibili (per il pianto della donna) che gli facevano drizzare i peli degli orecchi; dall’altra, vi era sua nipote, chiusa in un silenzio disperato. Il salotto offriva un vasto assortimento di sofà e sedie, ma le domestiche avevano preferito aspettare pigiandosi contro l’ospite. Tremavano tanto sul divano di crine nero, che il commissario doveva stare attento a non versare il tè.
Nella sua carriera, Kurtz si era occupato di altri omicidi. Non abbastanza da farci l’abitudine, però: di solito uno o due l’anno. Boston restava spesso per una ventina di mesi senza un assassinio degno di nota. I pochi che venivano ammazzati erano poveracci, così, fino ad allora, il commissario non era stato costretto a dispensare molte parole di conforto. A ogni buon conto, era troppo insofferente verso le emozioni per farlo come si doveva. Edward Savage, il suo vice, che qualche volta scriveva poesie, ci sarebbe forse riuscito meglio.
Questo (questo era l’unico modo in cui Kurtz riusciva a chiamare la raccapricciante situazione che avrebbe rivoluzionato la vita di una città) non era un semplice omicidio. Questo era l’omicidio di un bramino di Boston, un membro della mondana casta aristocratica del New England, istruita a Harvard e fedele alla Chiesa unitariana. Non solo: la vittima era il principale magistrato delle Corti del Massachusetts. Questo non aveva soltanto ucciso un uomo, come talvolta gli assassini fanno quasi per clemenza, ma l’aveva del tutto annientato.
La donna che aspettavano nel salotto migliore di Wide Oaks era salita sul primo treno utile a Providence dopo aver ricevuto il telegramma. I vagoni di prima classe sferragliavano avanzando con spensierata lentezza, ma quel viaggio, come tutto quanto l’aveva preceduto, sembrava ora parte di un oblio confuso. Aveva fatto una scommessa con se stessa e con Dio: se il ministro di famiglia non fosse ancora stato alla residenza una volta che fosse arrivata là, il messaggio del telegramma non sarebbe stato vero. Non aveva alcun senso, quella scommessa, ma doveva inventarsi qualcosa in cui credere, qualcosa che le impedisse di crollare. Ednah Healey, in bilico fra il terrore e lo smarrimento, teneva gli occhi fissi nel nulla. Entrando nel salotto, notò solo l’assenza del ministro e fu attraversata da un assurdo fremito di vittoria.
Kurtz, un uomo robusto con un’ombra color senape sotto i folti baffi, si accorse di tremare anche lui. Aveva provato il discorso durante il tragitto in carrozza verso Wide Oaks. «Signora, siamo così spiacenti di avervi fatta tornare. Dovete sapere che il giudice Healey...» No, aveva programmato di usare quelle parole come introduzione. «Abbiamo ritenuto che fosse meglio» proseguì «descrivervi le tristi circostanze qui, vedete, a casa vostra, dove sareste stata più a vostro agio.» A suo parere, era stato un pensiero gentile.
«È impossibile che abbiate trova...