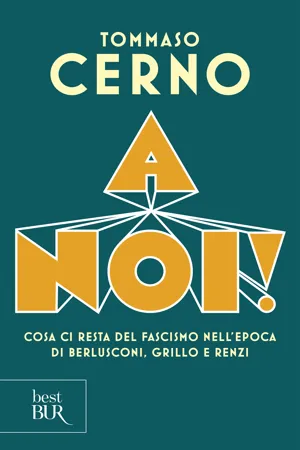![]()
Parte seconda
ALTRI STEREOTIPI:
SANGUE, SESSO E SOLDI
![]()
SANGUE
M come Matteotti, o forse Moro
Due eventi storici, due feroci omicidi, che hanno segnato in due stagioni differenti la storia dell’Italia, presentano molte analogie. Il martirio di due leader politici diversi per carattere e partito, ma ugualmente importanti per la storia della democrazia in questo Paese. La loro morte ha causato orrore e sdegno nella popolazione, cambiando il corso della storia: l’assassinio di Giacomo Matteotti diede inizio alla dittatura fascista, mentre il tragico epilogo dei 55 giorni di prigionia di Aldo Moro spinse il Paese verso la conclusione degli anni di piombo.
Il 30 maggio 1924, in occasione dell’apertura dei lavori della XXVII legislatura, Giacomo Matteotti pronunciò il suo ultimo discorso alla Camera. Una denuncia energica, ma lucida, ricca di puntuali riferimenti ai brogli e alle intimidazioni che i fascisti fecero in occasione delle elezioni del 6 aprile, delle quali chiese l’invalidazione. Al termine del discorso – più volte interrotto dalle vibranti proteste della maggioranza, ma ascoltato in silenzio da Mussolini –, rivolgendosi all’onorevole Costantini e agli altri compagni che si congratulavano con lui, Matteotti disse: «Ed ora preparatevi a farmi l’elogio funebre».
Il capo dell’opposizione era conscio dei rischi che correva ad attaccare così apertamente i fascisti: in passato era già stato vittima di più di un’aggressione. Per Mussolini Matteotti era più che una spina nel fianco, era il più determinato e preparato dei suoi avversari, i suoi attacchi potevano mettere in seria difficoltà il governo: Matteotti era forse l’oppositore che meglio conosceva il fascismo al punto che pochi mesi prima aveva pubblicato l’opuscolo di denuncia Un anno di dominazione fascista. Le parole del 30 maggio ne avevano pericolosamente fatto il portavoce di un’opposizione sconfitta, ma indomita.
In quegli stessi giorni negli ambienti di Montecitorio iniziò a spargersi la voce che Matteotti, per la discussione del disegno di legge che autorizzava il governo all’esercizio provvisorio del bilancio, stesse preparando una documentata accusa di corruzione nei confronti nel Partito Nazionale Fascista. Immediatamente la Čeka fascista, una milizia segreta del Partito fascista formata da ex arditi antesignana dell’OVRA, si mise in moto. Il deputato socialista venne pedinato per giorni, in attesa del momento migliore per l’azione. Ma Matteotti, che si era iscritto a parlare nuovamente alla Camera per l’11 giugno, si chiuse in casa a lavorare al suo discorso, probabilmente consapevole che il cerchio attorno a lui si stava stringendo. Nel tardo pomeriggio del 10 giugno Matteotti uscì dalla sua casa nei pressi del lungotevere per recarsi alla biblioteca della Camera, ma il commando guidato da Amerigo Dumini lo bloccò e con la forza lo costrinse a salire su una Lancia scura, che si allontanò velocemente verso la periferia romana.
A circa cinque chilometri di distanza, in via Fani, il 16 marzo 1978 la Fiat 130 blu di Aldo Moro si sta muovendo verso Montecitorio scortata da un’auto civetta della polizia. Sono le 9 del mattino, alle 10 è previsto l’inizio della discussione per il voto di fiducia al quarto governo Andreotti, il primo esecutivo della Repubblica con l’appoggio diretto del Partito comunista: il frutto di un delicato e faticoso lavoro di mediazione politica del politico pugliese. Il presidente della Democrazia Cristiana è da più di quindici anni il principale sostenitore del “centro-sinistra”: Moro, uno dei più preparati e lucidi politici della sua generazione, è da sempre convinto che la crisi del centrismo democristiano si possa superare solo con la cooperazione riformatrice tra i partiti moderati e le sinistre.
Lo stallo politico degli anni Sessanta, ovvero l’incapacità di introdurre riforme nel Paese, era stato la causa di un clima di crescente tensione in quegli anni. Le convergenze parallele che portano il PCI di Berlinguer ad adottare la strategia del compromesso storico e la DC a un concreto dialogo con le sinistre paradossalmente finiscono per esasperare quel clima, invece che stemperarlo. E questo perché si tratta di un progetto politico inviso alle correnti più conservatrici della DC quanto a quelle più radicali del PCI, agli apparati dello Stato profondamente convinti del “pericolo rosso” quanto agli estremisti della sinistra extra-parlamentare che vedono nel compromesso la peggiore minaccia alla realizzazione dei loro ideali radicali. A fare le spese di quella esasperazione sarà lo stesso Moro.
Il breve convoglio con a bordo il presidente della Democrazia Cristiana procede a velocità sostenuta lungo via Fani. Quando giunge all’angolo con via Stresa una Fiat 128 con targa diplomatica frena bruscamente facendosi tamponare dall’auto di rappresentanza dell’onorevole. Immediatamente dal marciapiede quattro uomini vestiti da avieri Alitalia si avvicinano all’auto del presidente e cominciano a sparare sugli uomini della scorta. Altri due membri del commando escono da una Fiat 128 che seguiva il convoglio e si uniscono alla sparatoria. Moro viene tratto dalla sua auto e caricato a forza su una Fiat 132 appostata in via Stresa. Il commando e il suo ostaggio si dileguano senza lasciare traccia, mentre in via Fani restano le auto crivellate di colpi, con i cadaveri dei tre agenti di pubblica sicurezza e dei due carabinieri della scorta.
Il 16 agosto 1924 il cadavere di Giacomo Matteotti venne ritrovato in una buca scavata nella boscaglia lungo la via Flaminia. Inizialmente l’operato della Magistratura fu encomiabile: appena un paio di giorni dopo il sequestro i responsabili materiali furono individuati e arrestati, grazie alla segnalazione di una coppia residente nei pressi dell’abitazione di Matteotti, che insospettita dalla presenza di un’auto ne avevano annotato la targa. Il corso delle indagini venne però in seguito rallentato e deviato quando coinvolsero dei deputati che per statuto potevano essere indagati solo dal Senato.
Da quasi novant’anni si discute sulla natura del delitto Matteotti: fu una spedizione punitiva sfuggita di mano ai carnefici? Oppure il commando della Čeka eseguì un ordine arrivato dall’alto? È un movente credibile la volontà di punire il leader socialista per le dure accuse fatte il 30 maggio o sotto c’è dell’altro?
Studi recenti hanno portato alla luce diversi indizi che paiono confermare una tesi diversa. In un documento rinvenuto negli archivi statunitensi, una lettera-testamento scritta da Amerigo Dumini per ricattare il Duce, si legge: «La necessità di sopprimere Matteotti era rafforzata dalla voce che circolava che egli fosse venuto in possesso delle prove di certi imbrogli nei quali si mescolavano […] un certo affare di petrolio, di borsa e di cambi in cui sembrava essere implicato perfino il fratello del capo del governo».1 Una prova concreta che testimonierebbe il fatto che i fascisti erano a conoscenza delle informazioni di cui Matteotti era entrato in possesso riguardo all’affaire Sinclair Oil.
La Sinclair Oil era una piccola società petrolifera americana, che aveva ottenuto dal governo Mussolini una concessione in esclusiva per novant’anni e con l’esenzione dalle imposte per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio sul suolo italiano e nelle colonie. Corrompendo aveva ottenuto un accordo più sfavorevole (per il governo) di quello che prometteva di garantire la British Petroleum. Matteotti nella primavera del 1924 era stato in Inghilterra, dove, tramite dei contatti legati al Partito laburista del governo inglese, aveva ottenuto dei documenti per provare i gravi casi di corruzione che coinvolgevano direttamente Mussolini e il «Popolo d’Italia» diretto dal fratello Arnaldo.
In un articolo che uscì postumo su un periodico britannico Matteotti accennò qualche accusa al riguardo, ma era nella discussione parlamentare dell’11 giugno che intendeva denunciare il governo e il Partito fascista. Al momento del sequestro il deputato stava andando alla Camera per completare il suo discorso: con sé aveva una cartella in pelle con tutti i suoi appunti e i documenti. Quella cartella non venne mai ritrovata.
Pochi minuti dopo il rapimento di Aldo Moro iniziano le ricerche a tappeto: nel cielo di Roma risuonano gli elicotteri delle forze dell’ordine, vengono formati centinaia di posti di blocco. In via Fani si affollano polizia, giornalisti, uomini delle istituzioni e semplici curiosi. Quando la notizia del rapimento viene diffusa dalle edizioni straordinarie dei tele e radiogiornali, lo sgomento di un intero Paese sfocia in manifestazioni spontanee contro il terrorismo e in sostegno della Repubblica. Con delle telefonate le Brigate Rosse rivendicano l’azione militare senza avanzare richieste di riscatto. Nella serata del primo dei cinquantacinque giorni del sequestro Moro, le Camere con procedura d’urgenza votano la fiducia al governo Andreotti. Il giorno successivo sui giornali, accanto alle ricostruzioni dell’agguato, negli editoriali di condanna all’azione dei terroristi viene chiesta al governo una reazione forte e determinata.
Il 19 marzo, giorno in cui sono celebrati i funerali degli agenti della scorta uccisi, le BR rilasciano il loro primo comunicato e una Polaroid: la celebre immagine del presidente della Dc prigioniero con alle spalle la bandiera dell’organizzazione terroristica. Nel comunicato è annunciato che Aldo Moro sarà processato da un “tribunale del popolo” in quanto rappresentante, anzi «il gerarca più autorevole, il “teorico” e lo “stratega” indiscusso di quel regime democristiano che da trent’anni opprime il popolo italiano». Un contro-processo parallelo a quello che in quelle settimane a Torino si sta ancora celebrando contro le Brigate Rosse e che si concluderà con una condanna poco più di un mese dopo il tragico epilogo del sequestro.
Moro sa di essere – in quanto presidente della Democrazia Cristiana – un prigioniero politico sottoposto a un processo diretto ad accertare le responsabilità non solo sue, ma di tutto il suo partito. Per settimane il prigioniero è il primo negoziatore per la sua vita: Moro suggerisce come condurre la trattativa con i suoi carcerieri tramite le lettere che fa pervenire alla famiglia e ai compagni di partito, sebbene quanto giunga dal “carcere del popolo” sia frutto di una “scrittura vigilata” dal “dominio pieno e incontrollato” dei terroristi. Moro è consapevole che la ragion di Stato è superiore alla considerazione umanitaria, ma lotta perché si trovi una via intermedia tra l’arrendersi alle richieste e il rifiuto a prescindere di ogni forma di negoziato. Una linea che non è condivisa dalla DC che, assieme al PCI e a quasi tutto l’arco costituzionale, si attesta sulla linea della fermezza. Moro protesta rivolgendosi direttamente a Cossiga, Zaccagnini, Andreotti e al partito; inoltre cerca la mediazione del Vaticano, che sarà vana.
Il processo che traspare dai comunicati dei brigatisti e le lettere di Moro inquietano i vertici della Dc e dello Stato: egli è a conoscenza di segreti che nel 1978 sono “pericolosi” per il partito, per il regime democratico, ma ancor di più per coloro i quali potrebbero essere chiamati in causa da Moro: come Gladio, i colpi di Stato pianificati, le rivelazioni sul caso Italcasse o le compromettenti relazioni di Andreotti e di altri.
Dagli interrogatori verrà tratto un memoriale che i brigatisti annunciano di voler pubblicare. Quelle carte diventeranno negli anni che seguiranno uno dei tanti misteri d’Italia mai risolti: ritrovate dagli uomini di Dalla Chiesa in un covo delle BR a Milano nell’ottobre del 1978, una parte di esse sparirà prima che il contenuto possa essere inventariato; dodici anni dopo, durante dei lavori di ristrutturazione nello stesso appartamento di via Montenevoso, degli operai scopriranno un nascondiglio segreto con armi, denaro e una copia più estesa dello stesso memoriale. «L’interrogatorio, sui contenuti del quale abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. Le risposte che fornisce chiariscono sempre più le linee controrivoluzionarie che le centrali imperialiste stanno attuando; delineano con chiarezza i contorni e il corpo del “nuovo” regime che, nella ristrutturazione dello Stato Imperialista delle Multinazionali si sta instaurando nel nostro Paese e che ha come perno la Democrazia Cristiana.»2
Una sessantina di pagine che alimentano sospetti e ipotesi di complotto. E così si concludono: «Per quel che ci riguarda il processo ad Aldo Moro finisce qui. […] Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte.»3
Nonostante l’annuncio, i tentativi di trattare per la vita del leader democristiano proseguono: il Papa si espone in prima persona chiedendo la liberazione “senza condizioni” di Moro, mentre i socialisti di Craxi, che si sono smarcati dalla linea della fermezza (non senza un cinico calcolo politico) propongono di scambiare il leader democristiano con un brigatista che non si sia macchiato di delitti di sangue. Ma il fronte della fermezza è irremovibile. Nei successivi comunicati i brigatisti chiedono la liberazione di tutti i compagni prigionieri, ma pretendono una negoziazione pubblica, non segreta: più che la liberazione dei prigionieri, le BR cercano un pubblico riconoscimento, vogliono diventare – come hanno inutilmente tentato di fare al processo a carico del nucleo storico delle Brigate Rosse che si era svolto in quegli anni a Torino e che si chiude nel giugno del 1978 – un interlocutore politico. Una pretesa impossibile da soddisfare, ma confermata dallo stesso Mario Moretti nella telefonata fatta da una cabina telefonica della stazione Termini alla famiglia di Moro nel primo pomeriggio del 30 aprile, quando ormai l’inevitabile è imminente: «Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo […], nel senso che, sa, una condanna a morte non è una cosa che si possa prendere così alla leggera neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono e vorremmo appunto… […] il problema è politico quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Abbiamo insistito moltissimo su questo, perché è l’unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene…[…] solo un intervento diretto, immediato chiarificatore, preciso, di Zaccagnini può modificare la situazione; noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l’inevitabile, non possiamo fare altrimenti».4
La DC non si smuove dalla linea della fermezza e il 5 maggio l’ultimo comunicato delle BR annuncia l’esecuzione della condanna. Il 9 maggio il corpo di Moro viene nascosto e fatto rinvenire sotto una coperta beige nel bagagliaio di una Renault rossa in via Caetani, a poche centinaia di metri dalla sede del PCI.
Da allora la polemica non si è mai conclusa: fu giusta l’estrema fermezza dello Stato? In questi ultimi anni il tema della negoziazione con i terroristi è tornato prepotentemente di attualità, ma forse all’epoca venne fatto sulla pelle di Moro anche un cinico calcolo: come testimonia la travagliata vicenda del suo memoriale, le conoscenze di Moro ne facevano un uomo pericoloso, un uomo che si considerava indispensabile per gli equilibri politici di quella stagione, ma che tale non era considerato da chi era pronto a sacrificarlo. Per il regime democratico un Moro vivo sarebbe stato un rischio ben più grande della sconfitta dello Stato di fronte al terrorismo. «Il mio sangue ricadrà su di loro» scrive in una lettera alla moglie riferendosi ai suoi compagni di partito. Una frase che suona come una profezia, più ancora che come il rassegnato testamento politico di uno statista persuaso che la morte sarebbe presto arrivata. Una morte, quella di Moro, che ha nei brigatisti gli esecutori materiali, ma ha in una intera classe politica i corresponsabili morali, non tanto del rapimento in sé ma degli esiti che ebbe.
Ancora oggi prosegue il dibattito tra gli storici riguardo la responsabilità diretta di Mussolini sull’omicidio di Giacomo Matteotti: probabilmente non si avranno mai le prove a conferma che l’ordine sia stato dato dal Duce del fascismo. Il maggiore indizio lo fornì Dumini con la sua lettera-testamento: «Fu lui [Marinelli] che mi disse che Mussolini voleva che Matteotti fosse tolto di mezzo». Il 27 dicembre «Il Mondo» pubblicò stralci del memoriale del latitante Cesare Rossi, ex capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio e a capo, con Marinelli, della Čeka, in cui la responsabilità di Mussolini risultava evidente.
Incalzato dall’opinione pubblica e dagli stessi fascisti Mussolini pronunciò alla Camera il celebre discorso del 3 gennaio: «L’articolo 47 dello Statuto dice: “La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all’Alta corte di giustizia”. Domando formalmente se in questa Camera, o fuori di questa Camera, c’è qualcuno che si vuol valere dell’articolo 47. […] Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho creato con una propaganda che va dall’intervento ad oggi».5
Nei giorni seguenti a questo discorso il governo attuò una serie di misure repressive che trasformarono la democrazia liberale nella dittatura fascista, leggi che affermavano la subordinazione dei ministri e del Parlamento al capo del governo. Nel frattempo le opposizioni, indignate dal rapimento del loro più carismatico rappresentante, si erano da mesi riunite nel cosiddetto “Aventino”, rifiutandosi di partecipare ai lavori delle Camere. Il re, a cui avevano chiesto di dimissionare il leader del PNF, restava bloccato in un ostinato quanto ormai inutile parlamentarismo non solo per le sue propensioni politiche nei confronti di Mussolini, ma anche per la paura dei moti di piazza e per i timori sulla sorte della monarchia che le simpatie repubblicane delle opposizioni gli suscitavano.
Nonostante l’instaurazione del regime e quel celebre discorso, Mussolini non si assumerà mai l’effettiva responsabilità della morte di Matteotti e ancora oggi i nostalgici dubitano delle effettive colpe del Duce. Depistaggi e revisionismi cercarono fin da quei mesi di allontanare, con successo, le indagini dall’anticamera dell’ufficio del presidente del Consiglio. Si alimentarono tesi artificiose e false, si sacrificarono capri espiatori e si finì addirittura per creare il mito che l’ulcera che tormentò per anni Mussolini fosse stata causata dal senso di colpa per non essere riuscito a impedire la morte dell’ex compagno di partito.
Si creò insomma una cortina fumogena, una strategia per lasciare quanto meno dubbi su quelle responsabilità politiche impossibili da occultare. La prassi è stata ripresa anche nell’era repubblicana, nell’affaire Moro con i suoi misteri, le sue coincidenze e le sue ipotesi, dubbi e controversie alimentati dalle ambigue omissioni e dalle sospette confessioni dei protagonisti, soprattutto politici, come Cossiga. Ma la stessa prassi è usata anche in altri delitti politici: dalla ridda di teorie sulle cause e sui mandanti della morte di Mattei, con la coda della scomparsa del giornalista dell’«Ora» Mauro De Mauro che proprio su Mattei stava indagando, al profondo buio che ancora oggi avvo...