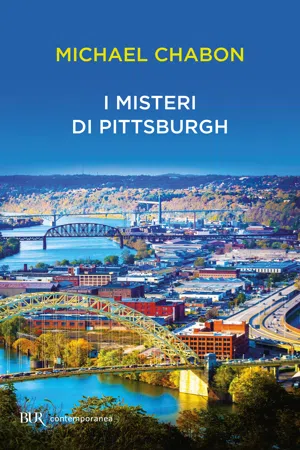![]()
XI
RIFLETTORI E DONNE GIGANTI
La mattina dopo, prima dell’alba, ero sul sedile posteriore della vecchia Barracuda degli Arning, e mi pulivo le briciole di brioche dalle labbra, cercando di apprezzare gli effetti trascurabili di una sola tazza di caffè. Cleveland e Arthur cantavano in coro accompagnando una vecchia cassetta di John e Yoko, e indicavano i ristoranti a forma di mulino, le concessionarie di automobili sormontate da gigantesche statue di plastica di orsi e di grassoni, i negozi di armi e i tabelloni con gli orari delle prediche evangeliche, che erano le pietre miliari della strada per Freedonia. Io cantavo Hail, Freedonia, dal film dei fratelli Marx. Non avevo più fatto un lungo viaggio in auto da quando ero venuto, con tutte le mie cose, da Washington a Pittsburgh quattro anni prima, all’inizio dell’università, e mi ero dimenticato il piacere di stare disteso sul sedile posteriore di un’automobile, con i capelli che volavano fuori da un finestrino e i piedi penzoloni dall’altro, a guardare i pali del telefono che passavano e ad ascoltare la musica, il rumore del motore, del vento sopra l’auto.
Dopo aver sentito due volte la cassetta di Lennon, e dopo che ebbi dormito, a quanto pareva, per la durata di un’altra cassetta, alle otto del mattino rimasero soltanto i suoni della Barracuda e di Patsy Cline, da una radio in qualche punto imprecisato, mentre io guardavo felice la nuca dei miei amici. Ci fermammo in uno snack bar per prendere un altro caffè, e a quel punto mi venne voglia di parlare. Domandai loro da quanto tempo, esattamente, fossero amici.
dp n="110" folio="110" ? «Nove anni» rispose Cleveland. «Ci siamo conosciuti il primo anno che eravamo alla Central Catholic. Ci siamo trovati, per così dire, simili nella nostra diversità.»
«Intende dire che tutti gli altri ci odiavano» spiegò Arthur.
«Parla per te» disse Cleveland. «Il fatto è che semplicemente non eravamo come nessuno degli altri ragazzi in quella ottima scuola.»
«La Central mi fa sempre pensare al castello di Santa Klaus» dissi.
«Noi non assomigliavamo a nessuno degli altri elfi» disse Arthur.
«Arthur aveva già, in effetti, qualche vago indizio delle inclinazioni sessuali perverse e peccaminose che avrebbero fatto di lui la persona meno cattolica che si potesse immaginare.»
«E Cleveland beveva già una confezione di sei birre al giorno, e fumava sigarette e marijuana. E leggeva ogni libro dell’Index librorum prohibitorum. E poi Cleveland» disse ancora Arthur, voltandosi a guardare con tristezza il suo amico, ma parlando con lo stesso tono sarcastico, «scriveva, a quei tempi.»
«Già. Di’, non ti sembra un po’ presto per certe discussioni? Non potremmo tenerle per quando sono abbastanza ubriaco da non badarci e addormentarmi a metà della replica? A proposito» disse, e senza rallentare uscì bruscamente dalla Statale per fermarsi nel parcheggio deserto di una rivendita di alimentari. Poi scese e si diresse verso il bagagliaio.
«Che cosa c’è nel bagagliaio?» domandai ad Arthur, che sbadigliò, si stirò, e si girò a guardarmi, con la faccia rosea e non sbarbata.
«L’oblio» rispose. «Nel bagagliaio c’è l’oblio.»
Cleveland risalì in macchina con una confezione di sei birre presa dalla borsa termica; quando raggiungemmo la casa sul lago aveva già accartocciato nel pugno la seconda lattina verde di Rolling Rock e, anche se la sua guida non si era ancora sfaldata del tutto, fui contento che non dovessimo proseguire oltre. La strada divenne stretta e tortuosa, gli alberi più fitti, e sulla nostra sinistra cominciai a intravedere, attraverso le rare fessure fra i pini e i sicomori, strisce d’acqua argentee e tendoni a righe di case lontane; in breve arrivammo a un vialetto di ghiaia, e a una serie di cassette della posta arrugginite che sembrava una fila di case sgangherate, con gli sportelli rossi di metallo aperti e ciondolanti. Imboccammo il vialetto sollevando la ghiaia dietro di noi, Cleveland frenò, mise in folle e scese dall’automobile.
«Farò due passi» disse. Sbatté la portiera e si allontanò, con una lattina di birra. Arthur e io rimanemmo per un attimo a guardarlo camminare verso la casa vuota; il suo passo era cauto e deciso allo stesso tempo. Il motore acceso girava a vuoto. Passarono tre o quattro minuti. Arthur appoggiò i piedi sul cruscotto.
«Be’?» dissi.
«Fa sempre così» disse Arthur. «Poi torna.»
«E quindi dobbiamo stare qui ad aspettarlo?»
«Sai guidare?»
«Perché, tu no?» Scavalcai lo schienale e mi sistemai al volante, che era tiepido in due punti esatti, per il calore delle mani di Cleveland. «Sei proprio un relitto» dissi.
«Ho sempre trovato persone disposte a guidare al mio posto» disse, stringendosi nelle spalle, mentre innestavo la marcia. «Persone come te.»
Anche se Cleveland aveva detto che suo padre ci andava ogni due settimane, la casa sembrava abbandonata da molto tempo. Era di legno bianco, con decorazioni azzurre, una veranda che girava tutt’intorno e una barca a remi bianca che marciva sul prato incolto; il prato, pieno di erbacce e di zanzare, partiva dalla spiaggia che bordava il lago, circondava la casa, e poi finiva di colpo con uno steccato ricurvo e coperto di rampicanti, al confine con gli alberi, quasi fosse sul punto di cedere all’invasione del bosco. E in verità, qua e là fra le erbacce, spuntavano gruppi di arbusti e anche piccoli alberi. Uno dei gradini dell’ingresso si era schiodato, le colonne dipinte di bianco della veranda si stavano scrostando, il sedile rotto di un dondolo penzolava appeso a una sola catena sotto l’ampia finestra della facciata. Fermo sulla soglia, fui improvvisamente consapevole di tutte le vacanze che erano state trascorse in quel posto, nell’ultimo mezzo secolo, di tutte le esclamazioni – «Una gazza!» «Un meteorite!» – di tutti i sospiri amari e i fuochi campestri accesi da una dozzina di famiglie scomparse.
Quando entrai nella casa buia, che sapeva di cedro, Cleveland era in soggiorno girato di schiena e stava guardando una fotografia incorniciata sopra il caminetto. Mi avvicinai a guardare da dietro le sue spalle. Era una fotografia che lo ritraeva all’età di quindici o sedici anni, sorriso angelico, occhi luminosi, capelli lunghi e di un colore più chiaro; aveva già una lattina di Rolling Rock in una mano e una sigaretta nell’altra, ma c’era qualcosa di diverso in quella posa caratteristica, un’aria di trionfo, di scaltra soddisfazione: e il sorriso era quello di chi la sa lunga, del novizio che ha appena appreso il Segreto e non riesce a capacitarsi che sia tutto così semplice. Nella fotografia Cleveland era bello, quasi smagliante, e a guardarlo ora, grosso, sfregiato e inerte, vidi per la prima volta quello che in lui dovevano aver visto Arthur e Jane: che alla crescita corrispondeva una riduzione, allo sviluppo la dispersione, una gigante rossa diventata una nana bianca. Forse ci vedevo troppo, in quella fotografia, ma la reazione di Cleveland dopo averla guardata confermò la mia impressione. Non potei fare a meno di dirgli: «Cristo, Cleveland, sei davvero bello in questa foto».
«Sì» disse. «Ero felice.»
«Era estate?»
«Sì. Qui sul lago.»
«Ma non ti capita mai che l’estate ti faccia sentire come eri in questa fotografia?»
«Sicuro» rispose, ma era chiaro che lo diceva solo per farmi piacere, mentre il tono della sua voce diceva, più onestamente: No, non più. Tamburellò con le dita sul vetro della cornice, e poi si girò verso di me.
dp n="113" folio="113" ? «Ti faccio vedere la tua camera» disse, evitando il mio sguardo. Fece per muoversi, poi tornò a voltarsi verso la fotografia e vi tamburellò sopra un’altra volta.
La mia camera da letto era la veranda posteriore: quando c’era l’alta marea stava sospesa sul lago Erie. Lentamente mi spogliai e infilai i boxer da mare e poi, irrigidito dal lungo viaggio in automobile, corsi sulla spiaggia dove trovai Arthur e Cleveland già distesi sugli asciugamani. Ridevano, con le lattine di birra ficcate nella sabbia accanto a loro. C’era una leggera brezza vicino all’acqua, e si erano tenuti addosso la maglietta. Su quella di Arthur c’era scritto: ULTIMA CHIAMATA. Bevemmo, nuotammo e guardammo le barche sul lago, distesi sulla sabbia scura. Cleveland sparì in casa, poi ritornò con un fucile ad aria compressa e un cestino pieno di lattine. Rimasi sdraiato sul mio asciugamano e lo guardai sistemare una fila di bersagli lungo lo steccato, prendere la mira, e farli esplodere senza sbagliare un colpo.
«Come fa a fare quella roba quando è ubriaco?» domandai ad Arthur.
«Non è ubriaco» disse Arthur. «Non è mai ubriaco. Semplicemente beve e beve e beve fino a che sviene, ma non si ubriaca mai.»
Mi ricordai della fotografia sul caminetto, la lattina di birra.
«Che tipo di cose scriveva?»
«Oh, saggi, immagino. Strani saggi. Ti ho detto di quello sugli scarafaggi. Avevamo una professoressa in gamba al liceo, una donna fantastica. Cleveland cominciò a scrivere grazie a lei.»
«E poi?» domandai.
«E poi, naturalmente, le capitò una disgrazia.»
«Che tipo?»
«Morte.» Si rigirò e voltò la faccia dall’altra parte, così che potevo vedergli solo la nuca e sentire la sua voce attutita dal vento. «Questo è, in teoria, il motivo per cui smise. Ma il fatto è che sono sempre le solite balle di Cleveland. Ogni suo fallimento ha sempre una scusa perfetta. Di solito una disgrazia di qualche tipo.»
«Tipo?»
«Tipo il suicidio di sua madre. O suo padre che diventa uno dei più spaventosi finocchi che io abbia mai visto – e ne ho visti parecchi, credimi – così Cleveland è esentato per sempre dal dovere di fare qualcosa di buono, o di produttivo.» Si tolse la maglietta e se la avvolse intorno alla testa, lasciando nuda la schiena snella e rosea.
«Ma voleva diventare uno scrittore?» domandai ancora, e cercai di tirargli via la maglietta dalla testa, ma lui la tenne stretta e rimase nascosto.
«Certo che avrebbe voluto diventare uno scrittore, però adesso ha queste ottime scuse. È tanto più facile bersi il cervello quasi tutte le sere.»
«Anche tu bevi molto.»
«È diverso.»
«Guardami in faccia.»
«No. Senti, ormai è andato oltre a questa storia da Giorni perduti. Io sono colpevole come chiunque altro per avergli riso dietro e per averlo rispettato come un caso umano. Cleveland conosce un mucchio di gente, e in molti vorrebbero essergli amici. Almeno all’inizio. Poi, cambiano idea.»
Era vero. Aveva già perso fascino e smalto, al punto che capitava alle volte di incontrare qualcuno che, a sentire il nome di Cleveland, esclamava: «Quell’imbecille?»
«Ti ho già detto che quando sua madre morì, gli lasciò circa ventimila dollari. Finiti. Li ha spesi. Soprattutto in canne, birra, dischi, e viaggi per andare a vedere i Grateful Dead che suonavano a Charleston, o a Boston, o una volta a Oakland, California. In puttanate. Lo sai cosa fa adesso?»
«Sì» dissi.
Levò via la maglietta e si voltò immediatamente a guardarmi, anche se naturalmente la sua espressione non tradiva alcuna sorpresa.
dp n="115" folio="115" ? «Te lo ha detto lui?»
Mi alzai in piedi. «Sono sbronzo» dissi. «Quante lattine pensi possa colpire?»
Mi feci un sonnellino sulla veranda, sopra l’acqua che toccava la riva, e d’un tratto sentii odore di chili. Rimasi sdraiato sulla branda svegliandomi lentamente, a stadi, lasciando che il profumo caldo e rosso si facesse strada nel mio cervello e mi costringesse ad aprire gli occhi. Andai in cucina e mi avvicinai a Cleveland che stava aprendo una lattina di chili dopo l’altra, finché ebbe accumulato due dozzine di bersagli per il giorno dopo e più o meno cinque litri di chili nella pentola. Era a torso nudo e sulla spalla sinistra aveva un livido da ubriaco, così come quelli sullo stinco e sul braccio.
«Cristo, devi avere un bello stomaco» dissi.
Smise di girare il miscuglio aromatico rosso scuro e si diede una pacca sul ventre con aria soddisfatta.
«Puoi contarci» disse. «Sto mangiando il mondo intero. Paese per Paese. La settimana scorsa ho ripulito Bahrain e Botswana. E il Belize.»
Ci sedemmo davanti al tavolo da pranzo di quercia, vecchio e graffiato, con la nostra scodella di chili, e io ricominciai a bere birra: era fresca, e mi schiarì le idee. Dopo cena uscimmo all’aperto. C’era ancora luce, anche se poca. Arthur trovò una palla e una mazza, ed entrammo tutti in acqua. Cominciò a lanciare la palla con tiri lunghi e precisi, e noi nuotavamo per metri e metri per andarla a prendere. Tornati a riva, ci fermammo sulla spiaggia, tremando per il freddo, poi ci infilammo le felpe. Cleveland mi insegnò ad accendere un fiammifero nel vento con le mani a coppa «come l’uomo nella pubblicità delle Marlboro», e poi a lanciare il mozzicone a otto metri di distanza una volta finita la sigaretta. Il sole tramontò, ma noi rimanemmo sulla spiaggia a guardare le lucciole e i pipistrelli occasionali. Il bosco era pieno di grilli, e la musica della radio nella veranda si mescolava al loro canto. Seduto sulla sabbia, pensai per un momento a Phlox. Cleveland e Arthur passeggiavano lungo il bordo dell’acqua, troppo lontani perché io potessi sentirli, e fumavano due lunghi sigari Antonio y Cleopatra. Poi li spensero nella sabbia, si tolsero le felpe e corsero nell’acqua dove anni prima Cleveland aveva brutalizzato la sua sorellina.
Mi sentivo felice – una sensazione vaga e piacevole concentrata nello stomaco, prodotta dalla birra – mentre guardavo il cielo azzurro sempre più scuro tormentato agli orli da lampi di calore, e ascoltavo il canto dei grilli, le grida provenienti dal lago, e la voce di Jackie Wilson alla radio. Ma era una felicità così simile alla tristezza che dopo un attimo mi accasciai.
«Come fai a passare tanto tempo con lei?» stava domandando Arthur, mentre gettava aghi di pino nel fuoco che Cleveland aveva acceso sulla spiaggia. Una fiammata, un bagliore, poi gli aghi scomparivano, come il mio umore mutevole nel corso di tutta la giornata. «Si crede talmente fascinosa.»
«Anche tu» disse Cleveland. Nelle lenti degli occhiali ardevano due piccoli fuochi. «E che cosa c’è di male in questo? Tende a esagerare se stessa. È una cosa sana.»
«È intollerabile» disse Arthur.
«È una dote» disse Cleveland. «Una dote che tu non possiedi. Io non sostengo forse che sto mangiando il mondo intero? Una chiara esagerazione. Non sostengo di essere il Diavolo Incarnato?»
«Sì» dissi. «Sì» e raccontai loro del mio grattacielo, e del mio zeppelin, e dell’ascensore che sfrecciava in su. Arthur grugnì, vuotò ...