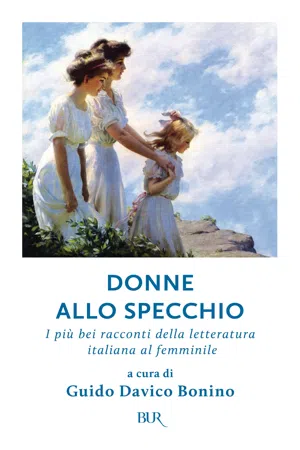![]()
PARTE PRIMA
Racconti per signore e signorine
![]()
CATERINA PERCOTO
(1812-1887)
Nata a San Lorenzo di Soleschiano sul Natisone (Udine) da antica e nobile famiglia il 19 febbraio 1812, Caterina dei conti Percoto studiò nel convento udinese di Santa Chiara, approfondì poi privatamente le lingue straniere (francese e tedesco): e dai ventiquattr’anni alla morte, sopravvenuta il 14 agosto 1887, salvo che per una decina di viaggi nelle principali città italiane, non si mosse dall’avita tenuta dei suoi, dove si dedicò con ininterrotta passione all’allevamento dei bachi da seta e, più generalmente, alla gestione dei suoi tenimenti agricoli.
Dopo qualche saggio di traduzione dal Klopstock della Messiade, prese a scrivere piuttosto presto racconti, su esortazione del collega Francesco Dall’Ongaro, che le aveva chiesto per la triestina «Favilla» (1836-1846) «qualche scritto da donna»: erano spesso novelle «di argomento friulano, fondate sull’osservazione dal vero del medesimo mondo agricolo e paesano in mezzo a cui viveva e al quale era legata da saldi vincoli di simpatia, di comprensione, di affetto» (Bruno Maier). Nacquero così alcune sillogi di Racconti (1858 e 1863, l’una e l’altra con prefazione di Niccolò Tommaseo) sino alle Novelle scelte, in due volumi, edite a Milano nel 1880, che rappresentano, in vita dell’autrice, l’edizione pressoché definitiva dei suoi scritti narrativi. Aveva goduto della stima di Capponi, Lambruschini, Tenca, Nievo, Zanella, Carducci: e nel 1870 Francesco Dall’Ongaro aveva prefato la Storia di una capinera del giovane Verga in forma d’una lettera a lei. Dal secondo dopoguerra ha destato l’attenzione di scrittori e critici (Spaini, Gatto, Prisco, Mariani, il già citato Maier).
Grazia Livi, in una nota critica del 1991, ha scritto con molta appropriatezza: «La forma del racconto le era congeniale, grazie alla sua adesione […] al programma letterario-morale che veniva predicato in quegli anni: produrre “scritti popolari sempre che siano dettati con fede e affetto” (Dall’Ongaro); rinunciare alle “solitarie astrazioni dell’intelligenza” e discendere “a conversare con le classi più numerose e meno istruite” (Tenca); adoperare i dialetti trasformandoli “in serbatoi di nuova vita” (Correnti). Era, in realtà, il filone della letteratura “rusticale” o “campagnuola” che si andava formando: e la Percoto fu tra i primi a rappresentarla, senza aver mai letto George Sand, che in quegli anni incarnava la stessa corrente in Francia, con strepitoso successo».
A questo credo letterario si ispirano, nella loro debordante ricchezza di «verosimili» dettagli, le due storie che seguono, le quali hanno la stessa protagonista, la nobile Ardemia della Rovere. La prima ne è come un «ritratto in piedi» (molto alla Sand, a dire il vero); la seconda la vede invece in azione, e con quasi maschile risolutezza (e anche questo la apparenta alle molte caparbie eroine della narratrice francese).
![]()
Il licof1
Possedere ad un tempo avvenenza, ricchezza e gioventù, dovrebb’esser quel tanto di paradiso terrestre che può la sorte concedere ai mortali. La contessa Ardemia della Rovere aveva ricevuto dalla mano di Dio questi tre bei doni della fortuna, e inoltre un cuore capace di affetto, uno spirito abbastanza svegliato, una cospicua nobiltà di natali; contuttociò ell’era tutt’altro che felice. Per obbedire ai parenti e per altre convenienze di famiglia, ella aveva contratto assai giovane un matrimonio contro genio, a’ pesi del quale non aveva poi saputo rassegnarsi. Ella non era di quelle donne, che, purché godano d’una brillante posizione in società, sanno inghiottire le pillole più amare. Una collana preziosa, un cascemire delle Indie, un qualunque presente per ricco ed elegante che fosse, non valevano a rabbonirla quand’era stata offesa nel suo amor proprio, o credeva mancato ai riguardi che le si dovevano. Aggiungi ch’ella era d’un carattere assai vivo, e un po’ altera e capricciosetta, cosicché in capo a pochi anni si trovò nella necessità di dividersi dal marito. Una donna giovane e bella, che viva isolata in mezzo ad una città, è presto scopo alla maldicenza, e ben anche alla calunnia. Ella aveva compreso tutta la difficoltà della sua posizione, e per sottrarsene viveva la maggior parte dell’anno in una sua villetta, contentandosi di fare qualche allegra giterella or in una or in altra delle città circonvicine, e di sbizzarire in oggetti di lusso e di moda, in ricchezza di equipaggi, in bellissimi cavalli ed altre leggiadrie, che unite alla sua rara bellezza le valevano l’ammirazione e l’applauso della folla dappertutto dove le piaceva mostrarsi. Più tardi s’accorse che questi frivoli piaceri erano troppo scarso compenso all’amarezza del suo povero cuore ferito, e che chi ha la disgrazia d’aver perduto la famiglia che il Signore le aveva destinata, se può trovare qualche conforto nelle cose di quaggiù, gli è solo nel procurare d’essere utile agli altri. D’altronde, col genere di vita allegra e quasi spensierata a cui nei primi momenti della sua crisi si era appigliata, il suo sacrificio non era abbastanza completo per imporre silenzio al mondo. Avrebbe bisognato che a vent’anni avesse menato la vita d’una donna di cinquanta, che si fosse contentata di seppellirsi nella sua solitudine, od almeno di non comparire nella società con quegli ornamenti che davano tanto risalto alla sua bella persona e che muovevano l’invidia delle sue rivali. Se l’avessero veduta priva di tutti i piaceri, con un vestito fuori di moda, trasandata, vecchia prima dell’ora, le avrebbero perdonato la sua avvenenza, la sua ricchezza; avrebbero fors’anco compatito il suo passato, e si sarebbero compiaciuti di riguardarla come una vittima infelice e tradita. Ma se vi era chi per lei nutriva simili sentimenti, la maggior parte invece facevano sul suo conto ben altri commenti. Per cotesti ell’era una donna bizzarra e capricciosa, e che non voleva rassegnarsi agli obblighi del suo stato; era una bisbetica, che non aveva saputo perdonare al marito le colpe ch’ella stessa, second’essi, colla sua mala condotta aveva occasionate; una civettina, che trovava il suo conto a viver fuori di ogni soggezione; e non mancavano di scrutare tutti i suoi passi, ed anche di lacerare la sua riputazione colle più maligne interpretazioni. Queste chiacchere, unite ai rimproveri che di quando in quando riceveva dalla madre, che, lei bamboletta ancora, era passata a seconde nozze e le aveva regalato una sorella e due fratelli uterini, invidiosi del suo assai più ricco patrimonio, spargevano d’assenzio molti de’ suoi giorni. Fortunatamente che il suo cervello era un terreno fertile di fiori che ad ogni strappata di dolore ne produceva tosto di altri e più ridenti e più vivamente coloriti. Ora le veniva il capriccio di cavalcare, e vestita all’amazzone e accompagnata dagli amici scorrazzava su d’un brioso ginnetto per tutti i contorni della sua villeggiatura, finché una predichina della madre o di qualcuno dei parenti non l’obbligava a smettere. Le saltava allora di provare il valore delle sue gambe; e fattasi amica la moglie dello speziale o la nipote del curato, usciva ogni giorno in abito succinto e con un largo cappello di paglia a far delle lunghe passeggiate, fumando qualche sigaro, e compromettendo il decoro della nobilissima sua stirpe e di quella del marito col degnarsi di entrare in qualche povera osteria dei villaggi che percorreva. Alzavano allora il naso i parenti offesi da queste sue pedestri scampagnate, e a forza di rimbrotti giugnevano a persuadergliene l’inconvenienza. Ma il peggio si era l’autunno, quando recavansi a villeggiare nei paesi circonvicini le sue amiche di un tempo, una sua zia, gran dama della croce stellata,2 e il marchese del Verde, marito della madre, che aveva la sua casa di campagna a poche miglia di distanza da lei. Venivano a farle visita, e sempre restavano malcontenti di qualche novità che trovavano, o nel palazzino, o nelle persone che la frequentavano, o nella sua maniera di vivere. Un anno, fra gli altri, fu un gran chiasso, e poco mancò non finisse di disgustarsi per sempre con tutta la sua nobile parentela. Si pensò di farsi piantare in una vasta prateria, a piedi delle colline, un capannuccio di frasche, e provvistasi della sua brava licenza, ogni mattina innanzi che albeggiasse, usciva ad uccellare. Prima ad accorgersi dello scandalo fu la zia gran dama della croce stellata. Era essa venuta a farle visita, e non trovatala in casa, ne chiese alla cameriera, un po’ per premura di sapere della nipote e un po’ per curiosità de’ suoi fatti. Questa le raccontò il nuovo gusto della padroncina, e madama indignata di simili bassezze propose di ricattarsi della visita fatta invano coll’accusarla ai parenti: il che fece la sera istessa alla conversazione del marchese del Verde, dove convenivano a far la partita la maggior parte dei signori dei contorni. Parve la cosa tanto strana che non le fu prestata piena fede: che una contessa della Rovere, discendente da antichissima famiglia, imparentata colla prima nobiltà del paese, andasse ad uccellare alle mattoline3 non combinavasi né colle loro idee, né col carattere orgoglioso ed altero che credevano d’averle sempre conosciuto. È vero che dopo il passo falso, così essi chiamavano quello del divorzio, l’Ardemia n’aveva commessa più d’una delle storditaggini, ma questa pareva troppo grossa, e si limitarono a crederlo uno scherzo malizioso della signora zia. Due giorni più tardi dovettero peraltro persuadersi che non era stata aggiunta sillaba al fatto. Il marchese del Verde, con alcuni amici e col curato, verso mezzogiorno trovavasi per caso nella spezieria, quando la vide che ritornava a casa, seguita dall’uccellatore che portava sulle spalle a cavalcioni d’una lunga asta le gabbie dei richiami, i zimbelli,4 le paniuzze e gli altri attrezzi dell’uccellanda. Ella era in borsacchini5 di cuoio, in un vestitino verde, svelto e succinto, che le stava a meraviglia. Aveva appiattati i ricci in un grazioso turbante di velluto dello stesso colore, sotto il quale quel suo bel visino fresco, sorridente, e allora un po’ arrossato per il sole e per la lunga camminata, pareva una fragola rugiadosa mezzo nascosta tra le foglie. Portava ella stessa la preda consistente in un bel mazzo di mattoline e di cutrettole,6 e sul petto a guisa di decorazione le usciva da un occhiello un cordoncino a cui erano appesi diversi zirli e fischierelli di argento. Questo era più di quanto occorreva per suscitarle contro la guerra. Il marchese particolarmente non poteva perdonarle l’idea di passar per il villaggio in quell’arnese, mentre per andarsene a casa aveva altra via ed anco più breve. Ciò a’ suoi occhi era un voler proprio attirarsi l’indignazione del pubblico e prostituire il decoro della famiglia. La sera alla conversazione non si fece altro che parlare dello scandalo; e fu risolto che nel domani la marchesa, aiutata dalla zia, avrebbe fatte le sue rimostranze in lettera, non volendo più nessuno esporsi ad un contatto che avrebbe potuto riuscire burrascoso, mentre il malumore era tanto grande da rendere difficile, per non dire impossibile, il mantenersi a sangue freddo. Nel domani, intanto che le dame davano forma al sermone, i due fratelli, in compagnia d’un altro giovinotto lor compagno di scuola e ospite in casa, pensarono di fare una scappata all’uccellanda. Faceva una di quelle bellissime giornate d’autunno, che sogliono fiorire in fondo alla buona stagione, come s’ella volesse prima di cedere il campo all’inverno darci ancora un ultimo addio. I tre giovinotti s’erano messi per un viottolo tortuoso che riesciva ad un’acquicella, e attraverso le siepi ancora verdi la vedevano passare luccicando, e ne udivano il lieve sussurro, che faceva armonia con un lontano coro di voci che parevano discendere da uno dei colli vicini. Era gente che terminava di raccogliere le uve, e così vendemmiando cantavano le loro villotte. Un’allegria infinita si spandeva per tutto il creato coi raggi del sole, che spogliati del loro calore, ma splendidi e limpidi come nel più forte della state, piovevano in grembo al verde dei campi e quasi accarezzavano le membra. L’atmosfera placida e senza nubi era commossa da un solo filo d’aria, ma così tenue che non giugneva a scuoter le frondi, tranne quelle della tremerella7 e del pioppo, che sulle più alte cime apparivano or bianche ed or verdi a seconda che le inargentava la luce. A qualche passo di distanza scoprivano di quando in quando alcuni fili di tenuissima seta attraversare lievemente ondulanti la via. Vollero discoprire l’insetto che ardiva lanciarli così pel vano, e sostando dove un punto lucido del filo aveva fermata la loro attenzione, videro il ragno navigatore dell’aria che, adagiatosi tra le vele dell’elegante barchetta ch’egli s’ha filato, si abbandona al venticello e passa quasi volando da un albero all’altro, svolgendo come da gomitolo la seta che la natura gli ha posto nel seno. Così chiaccherando ed osservando giunsero al rivoletto. Lo guadarono coll’aiuto d’alcuni sassi gettati attraverso la corrente, e furono sulla vasta prateria che si stende a piè delle colline di Buttrio a Rosazzo. Camminavano veloci per l’erba, cercando discoprire coll’occhio dove fosse il capannuccio della sorella. In fondo, quasi sotto alle colline vedevano un punto nero, e si diressero a quella volta. Quando le erano distanti non più d’un tiro di fucile, la videro che era sulla porta del capannuccio nascosta tra le frasche, e guardava in alto ed aveva il fischietto alle labbra. Si soffermarono in silenzio. Cinque o sei mattoline giù dai colli dalla parte di levante venivano a piccioli spruzzi volando per l’aria; giunte a portata dei pali, e veduto giuocare nell’erba il zimbello, si lasciarono cadere a...