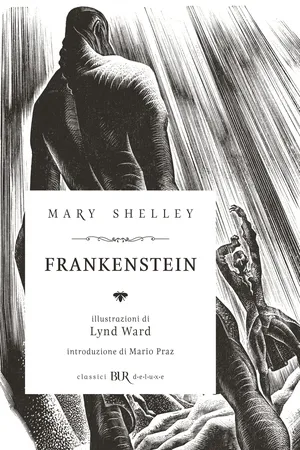![]()
INTRODUZIONE
Oltre al merito di essere uno dei più agghiaccianti «romanzi neri» o «gotici», il Frankenstein di Mrs. Mary Shelley ha quello di aver iniziato il tipo di favola fantascientifica che nel nostro secolo, a cominciare dal gran successo dell’Isola del dottor Moreau di H.G. Wells (1896), si è talmente diffuso che è divenuto un genere letterario a parte. C’è però un’importante differenza tra il punto di vista di Mrs. Shelley e quello di H.G. Wells e dei suoi innumerevoli epigoni. Sebbene entrambi i romanzi, Frankenstein e L’isola del dottor Moreau, si concludano con una catastrofe, nel secondo caso questa è a sfondo sociopolitico, mentre nel primo è a sfondo etico-religioso. In Frankenstein la nemesi appare inevitabile perché l’uomo ha commesso il peccato imperdonabile di proporsi di superare i confini assegnatigli dalla divinità. La concezione che qui predomina è ancora quella dell’overreacher, del trasgressore faustiano: «Il patto con il demonio e la vendetta del cielo non sono metafore astratte ma hanno una loro concretezza palpabile. Ma nel mondo “laico” della scienza contemporanea non vi è più spazio per la vendetta divina bensì soltanto per la punizione ecologica, proprio come non vi è più spazio per il patto col diavolo bensì soltanto con il potere economico e politico».1 Sia Frankenstein che Moreau, con operazioni di vivisezione, innesto e trapianto, creano antropoidi o ominidi, ma l’orrore in Wells non deriva dalla prevaricazione e sfida alle leggi divine, ma dalla manipolazione delle masse da parte di chi detiene il potere. L’efficacia di amara satira che ha il romanzo di Wells, come l’episodio dei sapienti di Laputa nei Viaggi di Gulliver, sta in un forzamento, fino ai limiti del possibile, di una plausibilità psicologica. Ma il romanzo della Shelley, con tutta la sua capacità di stimolare il nostro senso di orrore, soffre di una debolezza fondamentale che ostacola la «sospensione di credibilità» del lettore. Frankenstein non vuole essere una favola come Vathek di William Beckford, dove ogni improbabilità può farla franca perché qui impera l’irresponsabile arbitrio del regno delle fate. Non mettiamo in dubbio il potere dell’occhio micidiale del Califfo come non ci passa per la mente di dubitare della capacità degli angeli di volare con uno sterno ridevolmente sproporzionato all’estensione delle loro ali. Ora nel quarto capitolo di Frankenstein leggiamo che «dopo giorni e notti di travaglio e fatica incredibili» il narratore è «riuscito a scoprire la causa della generazione e della vita», anzi, che addirittura lui medesimo è divenuto «capace di conferire animazione su materia inanimata». Indi egli si rivolge all’amico in questi termini:
«Vedo dalla vostra impazienza e dallo stupore e dalla speranza espressi dai vostri occhi, amico mio, che vi aspettate di venire informato del segreto di cui io sono a conoscenza; ma ciò non può essere: ascoltate pazientemente il mio racconto fino alla fine, e comprenderete facilmente perché io sono così riservato a questo proposito. Io non voglio spingervi, incauto e zelante com’io ero allora, alla vostra rovina e immancabile infelicità. Imparate da me, se non dai miei precetti, almeno dal mio esempio, quanto sia pericolosa la conquista del sapere».
Così il modo per animare la materia inanimata dev’esser tenuto segreto, ma si accontenta il lettore di questa secca dichiarazione? In genere gli autori di romanzi di fantascienza cercano di alzare il velo, sia pure per un momento. Così fa infatti M.P. Shiel nella Nube purpurea, un romanzo che fu pubblicato a circa un secolo di distanza da quello di Mrs. Shelley; così fa il suo contemporaneo H.G. Wells, e così faceva Jules Verne. Nel suo studio su Mary Shelley’s Notes on Shelley’s Poems and «Frankenstein»,2 F.D. Fleck ha fatto osservare «la continua insistenza di Mary sull’amore di Shelley per l’astrazione», e il fatto che «Frankenstein implica, in forma fantastica, la sua critica di Shelley». Certamente Frankenstein ha molti tratti di Shelley giovane, che pure cercava di carpire il segreto delle leggi della natura. Gli Shelley avevano letto Vathek nel 1815 e non potevano non aver colto l’allusione all’«insolente desiderio di Vathek di penetrare i segreti del cielo». I passi paralleli del romanzo di Mary e di Alastor (1816), versi 23-29, citati dal Fleck, sono assai significativi:
«I have made my bed
In charnels and on coffins, where black death
Keeps record of the trophies won from thee,
Hoping to still these obstinate questionings
Of thee and thine, by forcing some lone ghost
Thy messenger, to render up the tale
Of what we are».3
Anche Frankenstein frequenta i cimiteri come campo delle sue ricerche (cap. IV):
«La tenebra non aveva alcun effetto sulla mia fantasia; per me un cimitero era solo il ricettacolo di corpi privi di vita, che dall’essere stati sede di bellezza e di forza, eran divenuti alimento del verme. Ed ecco che io fui condotto a esaminare la causa e il progresso della decomposizione, e forzato a passare giorni e notti in sepolcreti e ossari. La mia attenzione era su ogni oggetto più intollerabile alla delicatezza dei sentimenti umani. Io vidi come la bella forma umana veniva degradata e consumata. Osservai la corruzione della morte che succedeva alla fiorente guancia della vita. Vidi come il verme ereditava le meraviglie dell’occhio e del cervello. [...] Inseguii la natura nei suoi nascondigli. Chi potrà farsi un’idea degli orrori del mio lavoro segreto, mentre io m’affaccendavo tra i profanati umidori della tomba o torturavo l’animale vivente ad animare l’insensibile argilla? Le mie membra ora tremano e i miei occhi traboccan di lacrime al ricordo, ma allora un impulso irresistibile e quasi frenetico mi sospingeva, mi pareva d’aver perduto ogni sentimento fuorché per quest’unica ricerca. Invero non si trattò che di un raptus passeggero, che mi fece soltanto sentire con rinnovata intensità, appenaché, cessato lo stimolo innaturale a operare, fui tornato alle mie antiche abitudini. Raccolsi ossa dagli ossari, e disturbai, con dita profane, i tremendi segreti della struttura umana. In una camera, o piuttosto cella, solitaria, in cima alla casa, e separata da tutti gli altri appartamenti da una galleria e da una scala, io tenni il mio laboratorio d’immonda creazione: gli occhi mi uscivano dalle orbite mentre attendevo ai particolari del mio lavoro».
Questa non è che un’espansione del passo in versi di Shelley citato, ma per quanto Mrs. Shelley abbia sottolineato l’orrore gotico della ricerca, non ha afferrato in maniera più completa la realtà. Al modo stesso in cui Dickens, malgrado la ricchezza d’aggettivazione di cui disponeva, nel descrivere i bassifondi londinesi non definisce mai con precisione gli oggetti più repellenti, ma ricorre a termini generici (quali: sporcizia, sozzo, impurità, odori nauseabondi, e via dicendo), Mrs. Shelley usa parole che denotano la reazione del narratore ai materiali dei suoi esperimenti («ogni oggetto più intollerabile alla delicatezza dei sentimenti umani»), ma non descrive mai gli oggetti stessi o la maniera delle sacrileghe operazioni.
La creazione artificiale d’un essere umano era stata il sogno di secoli, ma il problema era particolarmente vivo nel Settecento, e Goethe lo espresse nell’Homunculus nella seconda parte del Faust, che, tuttavia, fu cominciata solo nel 1826, mentre Frankenstein fu pubblicato nel 1818. Si sono indicate fonti4 nei romanzi di Godwin, in Pygmalion et Galatée di Madame de Genlis, e naturalmente nel Paradiso perduto; Condillac può avere contribuito col suo sensazionalismo psicologico, Locke era stato letto meticolosamente da Mrs. Shelley durante il dicembre 1816 e il gennaio 1817. Nessuno, tuttavia, sembra avere richiamato l’attenzione sul fatto che si era tentato in Francia un famoso esperimento di creazione di un uomo artificiale. Si ritiene che Jacques Vaucanson, che aveva fabbricato tre famosi automi, che erano stati mostrati in tutta Europa e anche a Londra (nel 1742), un suonatore di flauto, un tamburino, e un’anatra che digeriva (Canard digérateur), venisse richiesto da Luigi XV nel 1739 se egli sarebbe stato capace di mostrare nello stesso modo la circolazione del sangue. Egli si applicò allora a «construire une figure automate qui imitera dans ses mouvements les opérations animales, la circulation du sang, la respiration, la digestion, le jeu des muscles, tendons, nerfs, etc.»5. Vaucanson non era il solo a tentare quest’esperimento; allo stesso tempo un fisiocrate, François Quesnay, che aveva un interesse altrettanto acuto per il problema della circolazione del sangue quanto per quello della circolazione della ricchezza, un gran ministro, H. Jean-Baptiste Bertin, che aveva la mente aperta a tutte le invenzioni curiose, e un medico, Claude-Nicolas Le Cat, miravano allo stesso scopo. Le Cat parlò del suo progetto alla sessione inaugurale dell’Académie des Sciences et Belles-Lettres di Rouen il 17 novembre 1744. Il titolo della sua comunicazione suona: Dissertation sur un homme artificiel dans lequel on verrait plusieurs phénomènes de l’homme vivant. Una relazione contemporanea dice che «son automate aura respiration, circulation, quasi-digestion, secrétion et chile, cœur, poumons, foye et vessie, et, Dieu nous le pardonne, tout ce qui s’ensuit. Mais il aura la fièvre, on le saignera, on le purgera, et il ressemblera trop à un homme».6 La relazione del segretario dell’Accademia aggiunge che l’automa avrebbe perfino avuto «la parole même et l’articulation des mots, le tout par le moyen d’un nombre infini de grands et petits ressorts et de contrepoids».7 Jean Baptiste Rodier, che frequentava il laboratorio di Vaucanson (l’Hôtel de Mortagne) sostiene che nel 1762 vide là un automa che mostrava la circolazione del sangue. Ma sopravvenne un ostacolo per via del materiale dei condotti che imitavano le vene e le arterie; essendosi lo stagno dimostrato insoddisfacente, qualcuno pensò alle proprietà duttili del caucciù recentemente scoperto, e si fece un certo numero di tentativi d’importarlo dalla Guiana in modo che conservasse quelle proprietà; ma si trovò che era necessario usare il caucciù nella sua condizione originaria sul posto, e a tal scopo si progettò di fabbricare l’automa laggiù, ma benché il re stesso avesse dato la sua approvazione e ordinato la spedizione, ci furono tali ritardi che Vaucanson si disgustò e il progetto finì in niente di fatto.
Si fecero anche tentativi di riprodurre la voce umana, un problema che nel Seicento era parso quasi sacrilego. Alla fine di quel secolo si diffuse in tutta la Germania una storia di ebrei capaci di creare Golem, o falsi sosia degli esseri viventi. Il famoso gesuita Athanasius Kircher e altri sognarono di macchine armoniche capaci di migliore riuscita della testa parlante attribuita ad Alberto Magno (il quale è ricordato tra gli autori letti da Frankenstein). Un filosofo materialista, Julien de La Mettrie, nel suo libro L’homme machine (Leida 1746) esortava Vaucanson a fabbricare un parleur, «machine qui ne peut plus être regardée comme impossible surtout entre les mains d’un nouveau Prométhée».8 E Jean Blanchet nei suoi Principes philosophiques (1756) si fece ardito a indicare il procedimento da seguire per fabbricare un tale automa, che sarebbe stato capace di «chanter, non seulement les airs les plus brillants, mais encore les plus beaux vers».9 Concludeva: «Voilà un phénomène qui demanderait toute l’invention et l’industrie des Archimède, ou bien des Vaucanson, et qui étonnerait toute l’Europe savante».10
Tutti questi tentativi sembrano piuttosto appartenere alla preistoria della cibernetica che alle fonti del romanzo gotico di Mrs. Shelley. Ci si chiede tuttavia se questi precedenti francesi dell’uomo artificiale fossero almeno ricordati nella conversazione a Villa Diodati nel 1816 in cui Polidori e Shelley parlarono dei «principi – se l’uomo doveva esser considerato solo uno strumento», della prima sorgente della vita, delle teorie di Erasmus Darwin, e del galvanismo, una discussione che può aver dato a Mrs. Shelley l’idea del suo romanzo. Per non essere avventati, gioverà adottare il punto di vista di Burton R. Pollin, secondo cui «in mancanza di ulteriori prove bisogna presumere che il suo racconto dapprima prese la forma del suo brutto sogno descritto nella prefazione, poco prima che Shelley e Byron partissero pel loro giro del lago di Ginevra, dal 22 giugno al 1° luglio». Crediamo, ciò nonostante, che l’affinità tra il tema di Frankenstein e i tentativi fatti in Francia per creare un uomo artificiale non possa esser dovuta a mera coincidenza; e crediamo pure che la somiglianza del tema della fanciulla innocente accusata di aver ucciso un bimbo, per colpa dell’infernale tranello del mostro, al fato delle donne virtuose del marchese de Sade non possa neppure essere una coincidenza, tanto più che il nome della donna innocente imprigionata, processata e giustiziata è proprio Justine.11 Il sogno di Mrs. Shelley era stato ispirato da un passo che aveva letto in Erasmus Darwin il quale, come gli scienziati e i fabbricanti di automi in Francia, faceva esperimenti per creare artificialmente la vita. È poi da ricordare che anche Horace Walpole pretendeva che il suo Castello di Otranto fosse stato ispirato da un sogno.
Ci sono in Frankenstein echi della Ballata del vecchio Marinaio del Coleridge;12 tale l’aspetto stesso del narratore («i suoi occhi luminosi si posano su di me con tutta la loro melanconica dolcezza» dice Walton nella quarta lettera preliminare), tale la regione polare attraverso la quale ha luogo l’ultimo folle inseguimento; e certamente l’immagine del cervo ferito nel capitolo IX venne ispirata dal famoso passo di William Cowper (The Task, III, 108-20).13 Ci sono pure anticipazioni del Demone della Perversità di Poe («il caso, o piuttosto il cattivo influsso, l’Angelo dello Sterminio, che impose su di me il suo onnipotente giogo dal momento in cui io volsi i miei passi riluttanti lontano dalla porta di mio padre – mi condusse dapprima a Mr. Kempe, professore di filosofia naturale»), e perfino un’anticipazione della caccia di Achab a Moby Dick nell’implacabile inseguimento del mostro, assegnato dal Cielo. Così per le lontane ripercussioni del tema principale e per il grandioso scenario attraverso il quale si svolge la folle caccia, il romanzo di Mrs. She...