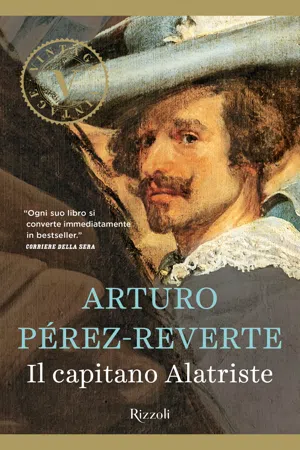
- 220 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il capitano Alatriste (VINTAGE)
Informazioni su questo libro
Diego Alatriste ha combattuto le guerre delle Fiandre e ora tira a campare come spadaccino al soldo nell'elegante e corrotta Madrid del Diciassettesimo secolo. I suoi nemici sono letali e numerosi, come l'inquisitore Bocanegra e l'assassino Malatesta. Un personaggio freddo e solitario, dal carattere rude e sbrigativo, lunghi silenzi affogati nel vino, una disperazione profonda, così come un cuore impavido e fero. Le sue avventure trascinano il lettore tra gli intrighi della corte di Spagna, tra i viottoli bui dove scintillano spade sguainate e sogni di grandezza.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il capitano Alatriste (VINTAGE) di Arturo Pérez-Reverte in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817081573eBook ISBN
97888586794561
La taverna del Turco
Non sarà forse stato l’uomo più onesto e neanche il più caritatevole della terra, ma era un uomo valoroso. Si chiamava Diego Alatriste y Tenorio e aveva combattuto come soldato nei vecchi battaglioni di fanteria durante le guerre delle Fiandre. Quando lo conobbi tirava a campare a Madrid, dove lo si poteva assoldare al prezzo di quattro maravedì per lavori di poco lustro, soprattutto come spadaccino per conto di chi non aveva l’abilità o il fegato necessari per risolvere da sé i propri contenziosi. Avete già capito: oggi un marito cornuto, domani una causa o un’eredità incerta, debiti di gioco saldati solo a metà con tutta una serie di annessi e connessi. Adesso è facile criticarlo: ma all’epoca la capitale dell’impero spagnolo era un posto in cui la vita bisognava guadagnarsela cogliendo al volo ogni occasione, a un angolo di strada, tra il luccichio di due spade. In tutto ciò Diego Alatriste se la cavava a meraviglia. Era estremamente abile quando si trattava di tirare di spada e maneggiava ancor meglio, con le finte della mano sinistra, la daga stretta e lunga che qualcuno chiamava ‘biscaglina’ e di cui erano soliti avvalersi gli attaccabrighe di professione. Un colpo con la spada e uno con la biscaglina, si diceva allora. L’avversario era tutto preso ad affondare e a parare eleganti stoccate di scherma quando all’improvviso gli arrivava da sotto, dritta nelle budella, una coltellata secca come un fulmine che non gli lasciava neanche il tempo di raccomandarsi a Dio. In effetti, come ho già detto a lorsignori, erano anni duri.
Il capitano Alatriste, insomma, con la spada si guadagnava da vivere. Per quanto ne so io, quello di capitano era più un soprannome che un grado effettivo. Se lo portava appresso da lunga data: da quando, in qualità di soldato semplice nelle guerre del re, una notte aveva dovuto attraversare con altri ventinove compagni e un effettivo capitano un fiume gelato, pensate un po’, in nome della Spagna e compagnia bella, con la spada tra i denti e in maniche di camicia per mimetizzarsi in mezzo alla neve e prendere di sorpresa un avamposto di olandesi. Erano i nemici di allora perché avevano la pretesa di proclamarsi indipendenti, e chi si è visto si è visto. Alla fine ci sono comunque riusciti, ma nel frattempo gli abbiamo dato del bel filo da torcere. Per tornare al capitano, l’idea era quella di restare lì, in riva al fiume, o a una diga, o quel che diavolo era, finché all’alba le truppe del nostro signor re non avessero sferrato l’attacco per ricongiungersi a loro. Insomma, gli eretici furono debitamente accoltellati senza che avessero nemmeno il tempo di dire ba. Stavano dormendo come ghiri quando all’improvviso i nostri uscirono dall’acqua con una gran voglia di scaldarsi un po’, e si scrollarono il freddo di dosso spedendo eretici all’inferno o in qualsiasi altro posto finiscano le anime dei luterani. Il guaio fu che poi venne l’alba e si fece mattina inoltrata, e il successivo attacco spagnolo non ci fu. Questione, avevano raccontato in seguito, di rivalità tra maestri di campo e generali. Di fatto, i trentun malcapitati vennero lasciati lì, abbandonati al loro destino, tra le imprecazioni, a maledire chissà chi e ad appellarsi al cielo, circondati da olandesi decisi a vendicare i compagni sgozzati. Erano più spacciati dell’Invincibile Armata del buon Filippo II. Fu una giornata lunga e durissima. E perché lorsignori se ne facciano un’idea, solo due spagnoli riuscirono a tornare sull’altra sponda quando fece buio. Diego Alatriste era uno di loro e siccome durante tutta la giornata aveva comandato lui la truppa – il vero capitano era stato liquidato già nella prima scaramuccia, con due palmi di spada che gli uscivano dalla schiena – gli era rimasto quel nomignolo, anche se non era mai arrivato a ricoprire tale grado. Capitano per un giorno, di una accozzaglia di soldati condannati a morte che erano andati al diavolo vendendo cara la pelle, uno dopo l’altro, con il fiume alle spalle e bestemmiando in buon castigliano. Cose che succedevano nel turbinio della guerra. Cose che succedevano in Spagna.
Comunque fosse, mio padre era l’altro soldato che tornò indietro vivo quella notte. Si chiamava Lope Balboa, era basco ed era a sua volta un uomo valoroso. Dicono che Diego Alatriste e lui fossero buoni amici, quasi fraterni; e deve essere stato così perché in seguito, quando mio padre venne colpito mortalmente da un colpo di archibugio in un baluardo di Jülich – per questo Diego Velázquez non lo poté ritrarre più tardi nel quadro della presa di Breda, come invece fece con il suo amico e omonimo Alatriste, che vi appare, dietro il cavallo – gli promise che si sarebbe occupato di me quando fossi cresciuto. E per questo motivo, quando stavo ormai per compiere il mio tredicesimo anno, mia madre mi mise una camicia, un paio di calzoni, un rosario e un tozzo di pane secco in un fagotto, e mi mandò a vivere con il capitano, approfittando del fatto che un suo cugino doveva venire a Madrid. E fu così che entrai a servizio, un po’ come domestico e un po’ come paggio, dell’amico di mio padre.
Vi voglio fare una confidenza: dubito fortemente che, se l’avesse conosciuto bene, l’autrice dei miei giorni mi avrebbe mandato così spensieratamente al suo servizio. Ma immagino che il titolo di capitano, benché apocrifo, conferisse una patina di onorabilità al personaggio. Inoltre, la mia povera madre non stava bene di salute e aveva altre due figlie. In questo modo si alleggeriva di una bocca da sfamare e dava a me l’opportunità di cercare fortuna a Corte. Così mi spedì via con suo cugino senza premurarsi di andare più a fondo alle cose, accompagnato da una lunga lettera dettata al parroco del nostro paese, in cui ricordava a Diego Alatriste il suo impegno e la sua amicizia con il mio defunto padre. Ricordo che quando entrai al suo servizio non era passato molto tempo dal suo ritorno dalle Fiandre, perché una brutta ferita che aveva al costato, e che gli avevano inflitto a Fleurus, era ancora fresca e gli arrecava forti dolori; e io, arrivato da poco, timido e spaesato come un pesce fuor d’acqua, lo sentivo la notte, dal mio pagliericcio, camminare avanti e indietro nella sua stanza, senza riuscire a prendere sonno. E a volte lo sentivo canticchiare piano strofe spezzate dagli spasmi di dolore, versi di Lope, un’imprecazione o un commento a suo uso e consumo ad alta voce, in parte rassegnato e in parte quasi divertito dalla situazione. Era tipico del capitano: affrontare tutti i mali e le disgrazie che lo colpivano come se fossero gli scherzi inevitabili che una sua vecchia conoscenza di indole perversa si divertiva a fargli di quando in quando. Forse era questa consapevolezza a infondergli il suo particolare senso dell’umorismo, ruvido, inalterabile e disperato.
È passato moltissimo tempo e io faccio un po’ di confusione con le date. Ma la storia che vi racconterò deve essere successa intorno all’anno milleseicentoventi e qualcosa, su per giù. È l’avventura degli uomini mascherati e dei due inglesi, che destò non poco scalpore a Corte e nella quale il capitano non solo rischiò di lasciarci la pellaccia rammendata che era appena riuscito a salvare dalle Fiandre, dai turchi e dai corsari berberi, ma che gli rimediò anche un paio di nemici che da allora in poi l’avrebbero tormentato per il resto della vita. Mi riferisco al segretario del nostro signor re, Luis de Alquézar, e al suo sinistro sicario italiano, lo spadaccino taciturno e pericoloso che rispondeva al nome di Gualterio Malatesta, un uomo talmente avvezzo a uccidere a tradimento che quando casualmente lo faceva guardando in faccia l’avversario cadeva in profonde depressioni, perché immaginava di perdere i propri poteri. Fu anche l’anno in cui io mi innamorai follemente e per sempre di Angélica de Alquézar, perversa e malvagia come può esserlo solo il Male incarnato in una fanciulla bionda di undici o dodici anni. Ma vediamo di raccontare ogni cosa a suo tempo.
Mi chiamo Iñigo. E il mio nome fu la prima cosa che pronunciò il capitano Alatriste la mattina in cui venne rilasciato dalla vecchia prigione di Corte, in cui aveva trascorso tre settimane a spese del re per debiti insoluti. A spese del re è solo un modo di dire, perché in quella, come nelle altre prigioni dell’epoca, gli unici lussi – e per lussi si intendevano anche i pasti – erano quelli che ciascuno poteva pagare di tasca sua. Fortunatamente, benché il capitano fosse stato portato dentro quasi senza un soldo, poteva contare su non pochi amici. E così, a turno, lo soccorsero per tutta la durata della reclusione, che gli fu più sopportabile grazie alle zuppe di legumi che Caridad la Lebrijana, la padrona della taverna del Turco, ogni tanto gli mandava tramite me, e ad alcune monete d’argento da quattro reali che gli facevano pervenire i suoi compari don Francisco de Quevedo, Juan Vicuña e qualche altro. Quanto al resto, e mi riferisco ai tipici inconvenienti della prigione, il capitano sapeva guardarsene come nessun altro. Era ben nota all’epoca la consuetudine carceraria di alleggerire di beni, vestiti e persino di calzature gli stessi compagni di sventura. Ma Diego Alatriste era abbastanza conosciuto a Madrid; e chi non lo conosceva non ci metteva molto a scoprire che era più salutare usare con lui un certo tatto. A quanto seppi in seguito, al momento del suo ingresso in carcere per prima cosa era andato dritto dal più pericoloso degli spacconi reclusi e, dopo averlo salutato con molta diplomazia, gli aveva messo alla gola un coltello corto da macellaio che era riuscito a conservare dietro pagamento di un maravedì alla guardia carceraria. Fu un vero toccasana. Dopo quella inequivocabile dichiarazione di principi nessuno si azzardò più a importunare il capitano, che di lì in avanti poté dormire in pace avvolto nella sua cappa in un cantone più o meno pulito dell’edificio, protetto dalla sua fama di uomo temerario. In seguito, la generosa condivisione delle zuppe della Lebrijana e delle bottiglie di vino comprate dal secondino con l’aiuto degli amici gli garantirono solide lealtà all’interno della prigione, compresa quella del ruffiano del primo giorno, un cordovese dal brutto nome di Bartolo Cagafuego che, benché avesse fama di essere un delinquente abituale che godeva di certe immunità e un assiduo frequentatore di galere, non si rivelò per nulla rancoroso.
Roba da non credersi. Non ricordo bene l’anno – era il milleseicentoventidue o ventitré –, ma di una cosa sono sicuro: il capitano uscì di prigione in una di quelle mattine azzurre e radiose di Madrid, con un freddo che toglieva il fiato. Sono passati molto tempo e molta acqua sotto i ponti del Manzanarre da quel lontano giorno che – nessuno dei due poteva saperlo allora – avrebbe cambiato tanto la nostra vita; ma a me sembra ancora di vederlo, Diego Alatriste, magro e con barba lunga, fermo sulla soglia mentre il portone nero di legno borchiato si chiudeva alle sue spalle. Ricordo perfettamente come sbatté gli occhi investito dalla luce accecante della strada, con i baffi folti che gli nascondevano il labbro superiore, la sagoma snella avvolta nella cappa e il cappello a tesa larga all’ombra del quale socchiudeva gli occhi chiari, abbagliati, in cui mi parve di cogliere un sorriso quando mi scorsero seduto su una panchina di pietra della piazza. C’era qualcosa di singolare nello sguardo del capitano: da una parte era chiarissimo e gelido, glauco come l’acqua delle pozzanghere nelle mattine d’inverno, dall’altra poteva incrinarsi di colpo in un sorriso caldo e affettuoso, come se una folata di calore sciogliesse di colpo una lastra di gelo, mentre il resto della faccia restava serio, inespressivo e grave. Disponeva poi, oltre a questo, di un altro sorriso più inquietante che riservava ai momenti di pericolo o di tristezza: una smorfia sotto i mustacchi che storceva leggermente verso la commessura di sinistra e che risultava sempre minacciosa come una stoccata – che di solito veniva immediatamente dopo – o funebre come il presagio determinato da un certo numero di bottiglie di vino, di quelle che il capitano era solito scolare in solitudine nei suoi giorni di silenzio. Bottiglioni da due litri e mezzo svuotati senza prendere fiato, asciugandosi i baffi con il dorso della mano, lo sguardo perso sulla parete di fronte. Bottiglioni cui si aggrappava per uccidere i fantasmi, era solito dire, anche se non ci riusciva mai del tutto.
Il sorriso che mi rivolse quella mattina, quando mi trovò lì ad aspettarlo, era del primo genere: quello che gli illuminava gli occhi smentendo l’imperturbabile gravità dell’espressione e l’asprezza che spesso si sforzava di infondere alle sue parole, ma che era ben lungi dal provare davvero. Guardò da una parte della strada e poi dall’altra, sembrò soddisfatto di non trovare in agguato qualche altro creditore e mi venne incontro, si levò la cappa malgrado il freddo e me la tirò, appallottolata.
«Iñigo» disse, «mettila a bollire. È piena di piattole».
Il mantello puzzava, proprio come lui. Anche i suoi abiti erano infestati di parassiti che sembravano invitati a nozze; ma il tutto fu risolto dopo meno di un’ora, nei bagni di Mendo il Toscano, un barbiere che da ragazzo aveva fatto il soldato a Napoli e che, stimando molto Diego Alatriste, gli faceva credito. Quando mi presentai con un cambio di biancheria e l’unico altro vestito che il capitano conservava nell’armadio tarlato che ci faceva da guardaroba, lo trovai in piedi in una tinozza di legno piena di acqua sporca, intento ad asciugarsi. Il Toscano gli aveva tagliato bene la barba e i capelli castani, corti, umidi e pettinati all’indietro, divisi da una riga in mezzo, gli scoprivano una fronte ampia, bruciata dal sole del cortile della prigione, con una piccola cicatrice che scendeva sul sopracciglio sinistro. Mentre finiva di asciugarsi e si metteva i calzoni e la camicia osservai le cicatrici che già conoscevo. Una, a forma di mezzaluna, tra l’ombelico e il capezzolo destro. Un’altra, lunga, zigzagante, sulla coscia. Erano entrambe d’arma bianca, spada o daga; a differenza di una quarta nella schiena che presentava l’inconfondibile forma a stella lasciata da un proiettile. La quinta era la più recente, ancora non completamente rimarginata, la stessa che gli impediva di dormire bene la notte: un taglio violaceo lungo quasi un palmo sul costato sinistro, ricordo della battaglia di Fleurus, che, seppur di un anno prima, ogni tanto si riapriva leggermente e suppurava; ma quel giorno, quando lui uscì dalla tinozza, non aveva un brutto aspetto.
Lo assistetti mentre indossava senza fretta, distrattamente, il farsetto grigio scuro e i calzoni dello stesso colore, di quelli che venivano chiamati valloni e si stringevano alle caviglie sui borzacchini che nascondevano i rammendi delle calze. Quindi si allacciò in vita la cinta di cuoio che io avevo ingrassato con cura durante la sua assenza e vi infilò la spada dai grandi rivettini la cui lama e coccia mostravano le tracce, le ammaccature e i graffi di altri giorni e altre spade. Era una buona spada, lunga, minacciosa, toledana, ed entrava e usciva dalla guaina con un sibilo metallico interminabile che faceva venire la pelle d’oca. Poi studiò un attimo il suo aspetto in uno specchio malconcio a mezzobusto che c’era nella stanza e abbozzò il suo sorriso stanco:
«Quant’è vero Iddio» disse tra i denti, «ho una gran sete!»
Senza dire altro mi precedette giù per le scale e poi lungo la strada di Toledo fino alla taverna del Turco. Siccome era senza cappa, camminava sul lato della strada in cui batteva il sole, a testa alta e con la consunta penna rossa nella fascia del cappello, che sfiorava con la mano sulla tesa larga per salutare qualche conoscente o si toglieva quando incrociava dame di un certo prestigio. Lo seguii, distratto, guardando i monelli che giocavano per la strada, le venditrici di legumi dei portici e i perdigiorno che prendevano il sole chiacchierando a gruppetti vicino alla chiesa dei gesuiti. Anche se non ero mai stato un tipo ingenuo e i mesi trascorsi nel quartiere erano serviti a svegliarmi ulteriormente, ero ancora un cucciolo giovane e curioso che scopriva il mondo con gli occhi pieni di stupore, cercando di non perdersi un dettaglio. Quanto al cocchio, sentii gli zoccoli delle due mule del tiro e il rumore delle ruote che si avvicinavano alle nostre spalle. Inizialmente vi feci appena caso; il passaggio di vetture e carrozze era cosa abituale, perché la strada era una pubblica via di comunicazione usata per raggiungere Plaza Mayor e la Fortezza Reale. Ma alzando un attimo gli occhi quando il cocchio arrivò alla nostra altezza, notai una portiera senza stemma e, al finestrino, il viso di una fanciulla dai boccoli biondi e lo sguardo più azzurro, limpido e conturbante che avessi visto mai. Quegli occhi incrociarono i miei per un attimo e poi, portati via dal movimento della carrozza, proseguirono lungo la strada. E io trasalii, senza sapere bene perché. Ma il mio turbamento sarebbe stato anche maggiore se avessi saputo che chi mi aveva appena guardato era il Diavolo in persona.
«Non ci resta che batterci» disse don Francisco de Quevedo.
Il tavolo era coperto di bottiglie vuote e ogni volta che don Francisco si lasciava prendere la mano dal vino di San Martín de Valdeiglesias – cosa che accadeva con una certa frequenza – si ostinava a voler tirare di spada e battersi con chicchessia. Era un poeta zoppo e spaccone, puttaniere, miope, cavaliere di San Giacomo, svelto di mente e di lingua quanto di spada, famoso a Corte per i suoi bei versi e il suo caratteraccio. Tutto ciò lo pagava, periodicamente, con un pellegrinaggio di esilio in esilio e di prigione in prigione; perché se pur era vero che il buon re Filippo IV, nostro signore, e il suo uomo di fiducia, il conte di Olivares, apprezzavano come tutta Madrid i suoi versi riusciti, quello che non gradivano tanto era esserne i protagonisti. E così, di quando in quando, dopo l’apparizione di qualche sonetto o strofa anonima in cui tutti riconoscevano la mano del poeta, le guardie e gli sbirri del Correggitore piombavano nella taverna o a casa sua o nei ritrovi in cui faceva salotto, per invitarlo gentilmente a seguirli, togliendolo dalla circolazione per qualche giorno o qualche mese. Siccome era testardo, orgoglioso e non imparava mai la lezione, tali disavventure erano frequenti e gli esacerbavano il carattere. Era, ciò nonostante, un eccellente commensale e un amico fidato per le persone che amava, tra le quali si con...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- 1. La taverna del Turco
- 2. Gli uomini mascherati
- 3. Una piccola dama
- 4. L’imboscata
- 5. I due inglesi
- 6. L’arte di farsi dei nemici
- 7. La passeggiata del Prado
- 8. Il Passaggio delle Anime
- 9. La gradinata di San Felipe
- 10. Il corral del Principe
- 11. Il sigillo e la lettera
- Epilogo
- Florilegio di poesia di vari ingegni della Corte
- Ringraziamenti
- Indice