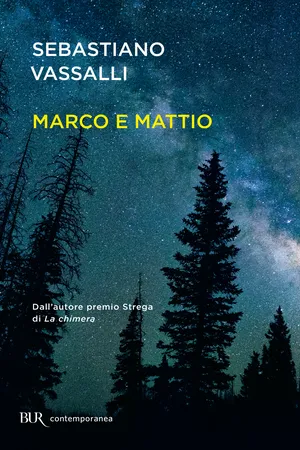![]()
1
Marco
Il forestiero arrivò un martedì, venendo a piedi da quella strada del Canal che era ed è tuttora la principale via di comunicazione tra la valle di Zoldo e il resto del mondo. Era il 18 aprile del 1775. Le campane della Pieve avevano da poco battuto i rintocchi dell’Angelus e gli aromi provenienti dalla cucina incominciavano a filtrare sotto l’uscio dello studiolo del pievano, don Giacomo Fulcis; quando un’improvvisa scampanellata alla porta di strada interruppe il corso dei pensieri del prete, e causò scompiglio in tutta la casa. Il cane Fun, richiamato alle sue funzioni di guardiano, manifestò la sua presenza nel cortile sbatacchiando la catena di qua e di là e abbaiando con tutto il fiato che aveva in corpo, fino quasi a strozzarsi. Al piano di sotto, dov’era la cucina, ci fu il rumore di una porta sbattuta; si sentirono un passo frettoloso su per le scale, una voce maschile dalla strada e la voce di Pellegrina che diceva: «Entrate!». «Qualche malato che sta morendo», borbottò l’arciprete: passandosi le dita tra i capelli candidi come per ravviarli, in un gesto che gli era abituale. «Vuoi scommettere? Se non muoiono in una notte tempestosa, muoiono tutti all’ora di pranzo o all’ora di cena.» E poi aggiunse ad alta voce: «Avanti!», perché qualcuno aveva bussato alla porta del suo studio. Entrò un uomo che don Giacomo non ricordava di avere mai visto, né a Zoldo né altrove, con indosso un mantello corto da viandante e brache di cuoio come s’usavano nel Tirolo, legate sotto il ginocchio con dei legacci rossi. Quel forestiero – osservò don Giacomo – dimostrava trentacinque anni, o pochi di più; aveva la barba e i baffi rasati, i capelli un poco brizzolati sulle tempie e occhi grigi mobilissimi che ispezionarono la stanza in un istante, per poi fermarsi sull’interlocutore. «Che sia il nuovo conestabile di polizia?», si chiese il pievano. Nonostante fosse nato nobile, e anche ricco, don Giacomo aveva fama d’essere un uomo sordido e taccagno, che difendeva ogni centesimo come se fosse stato l’ultimo; ed effettivamente il suo pensiero successivo fu: «Mi toccherebbe invitarlo a pranzo!». S’alzò, mosse alcuni passi incontro al forestiero. Questi, per parte sua, s’inchinò profondamente, tenendo in mano il cappello; non vide, o fece finta di non vedere, l’anello arcipretale che il pievano gli porgeva perché lo baciasse; disse più o meno le cose che avrebbe detto chiunque in quelle circostanze, però con forte accento tedesco: si scusò del disturbo che arrecava, dell’ora in cui si presentava, del non essersi annunciato con una lettera... Posò il bastone e il cappello su un piccolo sofà, proprio di fronte alla scrivania del prete; si tolse di dosso un recipiente di metallo che portava a tracolla, d’una forma che il pievano non aveva mai veduta prima d’allora e che non capiva cosa servisse a trasportare (forse, un’arma?), si slacciò la giubba; e mentre già don Giacomo, spazientito, stava per chiedergli, alla buon’ora!, chi fosse e cosa volesse da lui: gli porse un plico chiuso con un sigillo a ceralacca che il prete andò a guardare presso alla finestra, riconoscendo le insegne di monsignor Giovan Battista Sandi vescovo di Belluno. Dunque, quello strano viandante veniva da Belluno e dalla curia vescovile! Si rivolse alla nipote, che era rimasta sull’uscio per ogni evenienza: «Vai, vai pure!».
«Ma sedetevi!», disse al forestiero. «Cosa fate lì in piedi?»
Si sedette lui stesso. Mise gli occhiali sul naso, aprì la lettera e per prima cosa guardò da chi fosse firmata, decifrò: monsignor Francesco Persicini... Tutto in regola! («Chiunque sia questo benedetto forestiero, – pensò il prete, – mi toccherà invitarlo a pranzo, non c’è via di scampo!») La lettera, indirizzata all’eccellentissimo e reverendissimo arciprete di Pieve di Zoldo, cioè a lui, lo informava che lo straniero seduto davanti alla sua scrivania veniva da Ingolstadt in Baviera e si chiamava Joseph Markus Stromer, professore di filosofia e di teologia; che si era presentato a sua eccellenza il vescovo di Belluno con una lettera commendatizia di sua eccellenza il vescovo di Bressanone e che aveva chiesto di essere ospitato per l’estate in una parrocchia italiana di montagna, adducendo valide ragioni a sostegno di tale richiesta. (Era stato malato, diceva la lettera da Bressanone, di «male tisico» e i medici gli avevano prescritto, per la convalescenza, il clima alpino temperato delle regioni del Sud; in più, avrebbe approfittato di quel soggiorno per perfezionare la conoscenza della lingua italiana, che già parlava correntemente, e per dedicarsi allo studio delle scienze della natura, di cui era appassionato cultore). Si confidava dunque nella ben nota carità del pievano di Zoldo – concludeva monsignor Persicini – perché aiutasse il confratello a trovare una sistemazione adeguata nella sua stessa casa, o, se ciò proprio non fosse stato possibile, in altra casa di persona a lui nota e timorata di Dio...
Don Giacomo era diventato paonazzo. («La mia ben nota carità... Che spudorati! Mandarmi un uomo da mantenere, per dei mesi, e fare appello alla mia carità! Che mascalzoni!») Piegò la lettera. Disse ad alta voce, parlando più a se stesso che al forestiero: «Monsignor Persicini... Io non capisco... non capisco come in curia abbiano potuto pensare di mandarvi proprio da me... A Pieve di Zoldo! Lo sanno tutti che questa è una parrocchia poverissima, con dieci preti da sfamare e ottanta poveri a carico... Ma sì! Per loro, a Belluno, sono bagattelle! Per me, invece...».
«Forse è proprio per questo che mi hanno mandato da voi.» Lo straniero lo guardava e sorrideva, in un certo modo che a don Giacomo non avrebbe dovuto piacere granché; ma lui era troppo indignato per la lettera che aveva tra le mani, e non se ne accorse. Allora il tedesco tirò fuori di tasca una moneta d’oro e gliela mise davanti. «È una doppia imperiale, – gli disse: – vale due zecchini. Ve ne darò una in anticipo, ogni mese, per una stanza e due pasti al giorno. Vi sembra un prezzo ragionevole?»
Don Giacomo spalancò gli occhi: una doppia d’oro! La sollevò, la palpò, la mise in luce per guardarla meglio. Si scusò: «Voi mi capite, professore...». Indicò la lettera con il sigillo del vescovo: «Lì si parla di carità, ma un pover’uomo... in una parrocchia di montagna... Insomma c’è stato un equivoco, perdonatemi!». Si alzò, e anche il forestiero si alzò con lui. Gli strinse forte tutt’e due le mani: «Benvenuto! Sono lieto di offrirvi la mia ospitalità, e vi prego di accettarla. Mia nipote Pellegrina vi preparerà la camera degli ospiti, ma intanto scendiamo a rifocillarci, perché voi certamente vi sarete stancato venendo su a piedi per il Canal e avrete anche appetito, è naturale: siete ancora così giovane! Dopo pranzo, poi, vi presenterò i miei coadiutori di qui, cioè quelli della Pieve e dell’Ospitale dei Battuti: gli altri sono sparsi per cappellanie e mansionerie di montagna, e li conoscerete in seguito. Dieci preti per una sola parrocchia: una bazzecola! Conoscerete don Bonaventura, don Giovanni, don Bortolo, don Giuseppe, don Fedele». Aprì la porta al forestiero. «Ma voi, – gli chiese, – viaggiate il mondo così leggero, senza nessun bagaglio?»
«Ho lasciato i miei due bauli a Longarone, – rispose il tedesco, – a un mulattiere che provvederà a consegnarmeli nei prossimi giorni. Là dentro ho la mia biancheria, i miei libri, le cassettiere per le raccolte di minerali e di insetti, gli erbari... tutto ciò che ho portato con me venendo dalla Germania!»
«Anche gli abiti da prete, spero», osservò don Giacomo. L’altro scosse la testa: «Quelli no...» Un’espressione indefinibile mosse i suoi occhi e le sue labbra a un accenno di sorriso, che subito si perse. «Per tutto il tempo che resterò in Italia, – aggiunse dopo un attimo di silenzio, – ho una speciale dispensa del mio vescovo che mi esonera dall’obbligo di dire messa e di vestire gli abiti ecclesiastici. Quando arriveranno i bauli ve la mostrerò; ma vi avverto fin d’ora, è scritta in tedesco!»
Discesero le scale. Come spesso accade nelle case di montagna, la casa della Pieve di Zoldo s’affacciava verso la valle con tre piani, anzi addirittura con quattro, se si tiene conto del seminterrato adibito a deposito della legna e a pollaio; mentre la parte verso il sagrato, dove c’era l’ingresso, di piani ne aveva solamente due e per andare in sala da pranzo bisognava scendere, dal pianoterra della piazza al primo piano dell’altra parte.
«Mangeremo quello che c’è, bisogna adattarsi! – ripeteva don Giacomo. – Mi dispiace! Per questa volta non si può fare di meglio! Pellegrina! Pasqua!»
(La perpetua Pasqua – tanto vale che lo dica subito, perché poi nessuno pensi a un errore dell’autore – era sordomuta dalla nascita e chiamarla per nome era perfettamente inutile, come chiamare una sedia o un altro oggetto del mobilio: ma don Giacomo, quando riceveva visite di persone considerate importanti, chiamava ad alta voce tutta la gente di casa, sordomuti inclusi.)
Entrarono in sala da pranzo. Contrariamente a quanto aveva temuto l’arciprete, la tavola era apparecchiata anche per l’ospite ed era imbandita con ogni ben di Dio, come nei giorni di festa: sui taglieri di legno facevano bella mostra di sé una sopressa, una mezza forma di pecorino e una ricotta affumicata; mentre il piatto forte del giorno, la polenta col burro, spandeva attorno i suoi vapori e il suo profumo da un recipiente di coccio. Quale forma d’intuizione o di chiaroveggenza – si domandò il pievano – aveva spinto Pellegrina a preparare la tavola in quel modo? Forse aveva ascoltato i suoi discorsi con il forestiero attraverso la porta, o forse invece – Pellegrina, a volte, era così strana! – aveva provato un’immediata simpatia per quell’uomo, e aveva deciso di apparecchiare anche per lui, comunque poi fossero andate le cose. Presentò la nipote all’ospite. «Questa, – disse, – è la signorina Pellegrina Fulcis, mia nipote. E questo, – disse alla nipote, – è il professor...»
«Stromer, – suggerì il forestiero, inchinandosi verso Pellegrina. – Joseph Markus Stromer.»
«... il professor Stromer, sacerdote e teologo. A proposito, – chiese l’arciprete all’ospite, e si chiese: – se vi fermerete qualche mese qui con noi, come dobbiamo chiamarvi? Di don Giuseppe, alla Pieve, ne abbiamo già uno. Qual è l’altro vostro nome?»
«Marco, – disse il forestiero. – Chiamatemi don Marco.»
Don Marco, a Zoldo, diventò subito molto noto tra la gente del popolo. Il «prete tedesco» – come lo soprannominarono gli abitanti della valle – faceva lunghe passeggiate per i sentieri del Prampèr e del Mareson, su per il Ru Torto e per la Cervegana, tra i tabià del Pradamonte e del Col di Salera o addirittura sopra Fusine, alla ricerca di quelle mitiche miniere per cui un tempo – si raccontava nei filò – la valle era stata ricca, anzi ricchissima... Salutava i montanari da lontano, agitando la mano: «Sani! Sani!». (Così la gente si salutava e si saluta tuttora, in quest’angolo di mondo: augurando a se stessa di rimanere sana, e includendo pro-forma, nell’augurio, anche la persona incontrata per strada.) Quand’erano più vicini, li interrogava sui nomi dei tabià e delle montagne: gli chiedeva come si chiamassero loro stessi, dove stessero andando e cosa facessero... Gli mostrava ciò che aveva raccolto. Erbe e fiori li riponeva dentro a quel contenitore di latta verniciata che portava a tracolla il giorno in cui era arrivato e che era sembrato, al povero don Giacomo, la custodia di un’arma; i sassi, invece, li metteva in un sacchetto che teneva appeso alla cintura e ne parlava sottovoce, come se fossero stati dei diamanti o delle pietre preziose. Indicava al montanaro certi segni, certe forme appena accennate sulla superficie del sasso. Gli diceva: «È una conchiglia! È un granchio fossile!».
«Lo sapevi, – chiedeva all’interlocutore, – che qui una volta c’era il mare? Molte di queste pietre che tu calpesti senza nemmeno farci caso, erano il fango del fondo marino, che poi s’è pietrificato! Qui è la prova!»
Il montanaro sgranava gli occhi: «Il mare! Il fango!». Se ne andava come camminando sulle uova, nel centro del sentiero: badando a dove metteva i piedi, per non calpestare quei sassi prodigiosi. Qualcuno scuoteva la testa, mormorava: «No s’ha mai ’mparà bastanza!». Qualcun altro, invece, la testa se la batteva col dito, sentenziava: «Dai ati, se conosse i mati!».
(«I matti, si riconoscono da ciò che fanno!»)
Nelle giornate di sole pieno e senza nuvole, il forestiero si dedicava ai piccoli animali: alle farfalle, che catturava con una reticella posta in cima a un bastone, ma anche ai ragni, agli scarabei, a tutti gli insetti, insomma, che si muovono in mezzo all’erba dei prati e tra le pietraie. Portava in spalla uno zainetto di tela, sorretto da due robuste cinghie di cuoio; lì dentro teneva un gran numero di scatoline e di vasetti dove chiudeva le sue vittime dopo averle stordite con un liquido incolore, dall’odore acre, di cui versava una gocciolina sopra una pezzuola. Ciò che più impressionava i montanari, però, era il modo con cui don Marco maneggiava le vipere per togliergli il veleno, senza provarne repulsione: le fermava a terra immobilizzandogli la testa con un bastoncello biforcuto, le sollevava per la coda, le costringeva con due dita ad aprire la bocca e poi, letteralmente, le mungeva: raccogliendo il veleno dei denti superiori dentro un flacone di vetro. In questi casi la gente scappava terrorizzata oppure rimaneva a guardare i movimenti del forestiero tenendosi a distanza; qualcuno, anche, si faceva il segno della croce e recitava una preghiera. Per secoli, per millenni, a Zoldo come in tutte le valli alpine, la vipera era stata l’incarnazione del male e della morte, una forza oscura da cui il mondo doveva essere liberato; e quell’uomo che con le vipere ci giocava, alzandole per la coda e facendo anche il gesto di buttarle addosso ai montanari, preoccupava e impauriva un po’ tutti. «Sarà anche un prete, – dicevano in molti, – ma si comporta come se fosse un Diavolo!» Alcuni attribuivano le stranezze di don Marco al suo essere tedesco, sentenziavano: «Todesco italianizà, xe un Diavolo incarnà!»; i più, invece, preferivano soffermarsi sul suo aspetto, sui suoi abiti, e specialmente su quel suo modo di guardare gli interlocutori, come se avesse voluto farsi beffe di tutto e di tutti. Ripetevano, ogni volta che se ne parlava: «Macché prete! Quello o è un Diavolo in carne e ossa, o è un framassone, che ha consacrato la sua vita al servizio del Diavolo!».
Insistevano: «È stato mai visto a mettere piede in una chiesa? A farsi il segno della croce, come un buon cristiano? A celebrare la santa messa e a leggere il breviario, come i veri preti? S’è mai sentito raccontare, da che mondo è mondo, di un prete così fatto, che va in giro dall’alba a notte per i monti senza occuparsi di nient’altro che di erbe, sassi e animali schifosi?».
Quando era seduto alla tavola del pievano don Marco badava soltanto a mangiare, senza fare conversazione; se lo interpellavano, rispondeva con poche parole o addirittura con un monosillabo: sì, no. Una sera, però, a cena dal parroco, c’era un prete tarchiato e riccioluto, con due mani enormi da boscaiolo: era don Giuseppe, direttore dell’Ospitale dei Battuti e medico della valle. Forse per effetto di quella presenza, o forse per caso, lo straniero quella sera si dimostrò più loquace del solito; tanto loquace, che raccontò la storia della sua vita. Era nato in Oriente, disse, anzi proprio in Palestina, nei luoghi della predicazione e della passione di Nostro Signore; ma la sua formazione culturale e i suoi studi s’erano compiuti in Germania. Aveva studiato teologia in varie Università, e non soltanto teologia: anche scienze naturali, medicina, diritto. Un desiderio continuo di approfondire, di indagare, di conoscere il mondo lo aveva spinto a vedere in ogni scienza le connessioni con altre scienze, a non fermarsi ai postulati, ad andare oltre: cercando Dio nella natura, la natura in Dio e l’uomo in entrambi. (Don Giuseppe, al suono di quelle parole, trasalì, e anche il pievano allontanò la bocca dalla coscia del cappone che teneva tra le dita, guardò in viso don Marco: stava parlando sul serio? Lo scrutò e vide che lui sorrideva al modo solito, come se volesse dirgli: non è vero niente! Vi sto solo prendendo in giro! Scosse il capo; tornò a occuparsi del cappone.) Quell’inquietudine, quella perpetua insoddisfazione, proseguì don Marco, lo avevano indotto a intraprendere lunghi viaggi, anche fuori del suo paese: era stato in Inghilterra, in Francia e una prima volta in Italia; quasi senza accorgersene, era diventato un medico famoso, richiesto da arciduchi, vescovi e principi elettori, continuamente in viaggio da una città all’altra, da una corte all’altra; finché le fatiche e i disagi lo avevano fatto diventare tisico. S’era curato da solo, con quel Balsamo di Baviera di cui – disse – a buon diritto poteva considerarsi l’inventore; era ritornato sano, ma un medico suo amico lo aveva persuaso a venire in convalescenza in Italia, per scongiurare il pericolo di una ricaduta e anche per distrarsi da una misteriosa malattia dello spirito: da un’insania – don Marco, a questo punto del racconto, abbassò la voce – che di tanto in tanto tornava ad assillarlo e che nessun medico, ancora, era riuscito a guarirgli...
Don Giuseppe aveva ascoltato le parole dello straniero con molta attenzione, e quando lui arrivò a parlare d’insania lo interruppe. «Anch’io, – disse, – ho curato dei casi d’insania! Persone di questa valle che per molti mesi dell’anno conducevano una vita normale e però poi, quando la melanconia le assaliva, dovevano essere ricoverate nel nostro Ospitale perché non erano più in grado di connettere, non riconoscevano i congiunti e potevano compiere ogni sorta di stranezze.» Dopo un attimo di pausa, aggiunse alla descrizione della malattia anche la cura prescritta. «Questi casi, – ci tenne a specificare, – noi li trattiamo con i salassi, con le purghe e con l’immersione del paziente in acqua gelata...»
Don Marco inorridì: «Salassi? Purghe?». Guardò il collega, tra divertito e sbalordito. «Davvero, – disse, – non vorrei finire come paziente nelle vostre mani!»
Le mani di don Giuseppe erano grandi come badili e l’interessato le alzò, le guardò con affetto. «Queste mani, – rispose, – hanno sempre fatto del bene, e continueranno a farne finché io avrò vita!» Tornò ad appoggiarle sul tavolo. «Anche noi medici di montagna, – aggiunse dopo un attimo di silenzio, – di tanto in tanto sentiamo parlare dei nuovi farmaci, e dei nuovi modi che ci sono ora per curare gli ammalati; ma continuiamo a curarli alla maniera antica, perché crediamo che le vecchie cure, se funzionavano in passato, funzioneranno anche in futuro: e i fatti, grazie a Dio, ci danno ragione.»
Le «vecchie cure», come le chiamava don Giuseppe, avevano effettivamente due grandi vantaggi sulla medicina moderna e sulle nuove terapie ispirate dal progresso scientifico: erano semplici e curavano tutto. Qualunque fosse la malattia che doveva affrontare, don Giuseppe cercava di eliminarla sottoponendo l’ammalato a una serie di salassi, via via sempre più energici; se quello non guariva, lo purgava con la salappa oppure gli prescriveva un vigoroso clistere «rinfrescante», per togliergli dal corpo ogni presenza maligna; se anche così la malattia non si decideva ad andarsene, lui allora confessava il poveretto – che a questo punto era ormai prossimo a tirare le cuoia – gli somministrava l’olio santo e lo accompagnava all’ultima dimora, pregando Dio per la sua anima immortale. Perciò – diceva don Giuseppe – le sue cure erano anche complete, più complete di quelle di qualsiasi altro dottore: perché trattavano sia il corpo che lo spirito e non abbandonavano l’ammalato nel momento del trapasso, ma lo accompagnavano fin oltre la morte. Don Giuseppe, il prete-medico di Zoldo, non aveva il minimo dubbio sull’eccellenza dei suoi metodi terapeutici: nessun altro medico, per quanto studiasse e s’aggiornasse, poteva dare all’ammalato più di quanto gli dava lui!
La nipote del pievano, Pellegrina Fulcis, davanti a don Marco era come incantata: lo guardava in un certo modo, e con certi occhi, che lui avrebbe dovuto avere il cuore duro come la pietra per resistere al richiamo di quegli sguardi! A tavola, gli serviva le parti più succulente della selvaggina, le porzioni più grosse di polenta e lugànega. Lo toccava facendo finta di urtarlo; e il vecchio pievano, quando finalmente si accorse delle manovre della nipote intorno al forestiero, ne fu preoccupato e turbato. «Ci mancava solo più questa!, – borbottava. – Mia nipote che fa gli occhi dolci... a un prete! In casa mia!»
L’unico pensiero che dava conforto al povero don Giacomo era che di lì a poche settimane Pellegrina sarebbe tornata a Belluno da suo padre, e che a tenere compagnia allo zio arciprete sarebbe venuta una sua sorella minore, la signorina Rosa. Il pievano sperava che quelle settimane passassero in fretta e si limitava a sbuffare, e a fare gli occhiacci, quando vedeva la nipote in estasi davanti a don Marco. A volte, anche, mormorava a mezza voce, come se stesse parlando da solo. «Quella sventata, – le diceva perché lei lo sentisse, – quell’ingenua! Si decidesse a prendere marito, una buona volta, e a mettere giudizio!»
Pellegrina Fulcis, nel 1775, era una zitella d’una trentina d’anni, o pochi di più, che aveva dato e dava molti dispiaceri ai suoi familiari, per via appunto che non si...