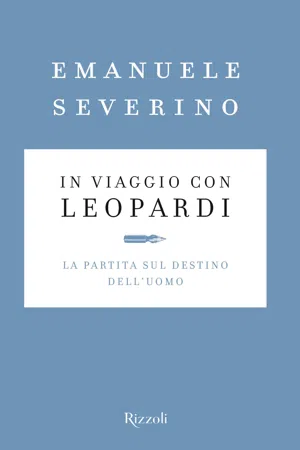![]()
1
Piangere i morti
«Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.»
Così scrive l’apostolo Paolo nella Prima lettera ai Tessalonicesi. Anche i Vangeli esprimono questa convinzione. Chi piange i propri morti non sa che anch’essi risorgono. Come è risorto Gesù. Quando il cristianesimo assimilerà la filosofia greca, aggiungerà che l’anima umana non è mai morta: è immortale. Un altro motivo per non piangere i nostri morti. Solo il corpo è andato distrutto. Ma risorgerà. I morti non sono veramente morti. Così parla il Giocatore Bianco.
Eppure si può replicare. Il Giocatore Nero ribatte che è naturale piangere i morti che abbiamo amato. È secondo natura. Se questa sua replica fosse vera, si dovrebbe dire che il cristianesimo è «contro natura». Li si piange istintivamente, egli dice, «senza ragionare». Il pianto «è un puro sentimento». Li piangiamo perché, «seguendo un sentimento intimo, e senza ragionare», crediamo «che essi abbiano perduto la vita e l’essere». «Dunque noi non crediamo naturalmente all’immortalità dell’animo; anzi crediamo che i morti siano morti veramente e non vivi; e che colui ch’è morto non sia più». Seguendo la natura, crediamo che la vita dei morti sia ormai nulla. Per sempre. «Privato della vita e dell’essere», chi muore è diventato nulla, non sarà «mai più». Si piange dunque per lui perché si crede, naturalmente, che questa privazione e questo «mai più» sia l’«ultima e irreparabile disgrazia».
Perché abbiamo messo tra virgolette molte espressioni della replica ora richiamata? Perché essa è di Giacomo Leopardi. Il Giocatore Nero. Il cantore della morte. La replica si legge nelle pagine 4277-79 di quell’opera gigantesca, alla quale Leopardi ha lavorato per tutta la vita, che ormai è consuetudine chiamare Zibaldone. (Noi non lo faremo.) Alla fine di quelle pagine Leopardi appunta: «Recanati. 9 aprile. Lunedì Santo, 1827». Annota di stare scrivendo cose in cui si voltano le spalle al cristianesimo e di scriverle all’inizio della settimana che per il mondo cristiano, all’interno del quale egli vive, è «santa».
E come mai, tra i grandi che hanno pensato la morte con parole, musiche, figure allontanandosi dal cristianesimo, proprio Leopardi? A questa seconda domanda risponderanno le pagine che seguono. Qui limitiamoci a dire, riprendendo quanto già si è affermato nelle precedenti «Istruzioni», che egli non solo è tra i geni più grandi, come poeta e come filosofo, ma che la sua filosofia ha la capacità di portare al tramonto l’intera tradizione dell’Occidente. Decenni prima di Nietzsche, Leopardi apre la strada al tempo della «morte di Dio». Il nostro tempo. Certo, questa può sembrare un’affermazione troppo azzardata. Per esempio, le religioni e le loro degenerazioni non sono forse uno dei fenomeni più visibili e dunque ben vivi del nostro tempo? Ma, appunto, si dovrà sentire che cosa risponde Leopardi.
È andato annotando tutta la vita quel che pensava in campo filosofico, letterario, religioso, filologico. Alla sua morte venne rinvenuto un gruppo di manoscritti di circa 4500 pagine, senza titolo. Ma Leopardi aveva sentito il bisogno di fare un po’ d’ordine in quel materiale enorme, tanto che nel 1827 aveva steso un indice intitolato Indice del mio Zibaldone di pensieri. La parola «zibaldone» indica sì il carattere di quei manoscritti, ma indica anche una vivanda composta da svariati ingredienti. Qualcuno ha accostato «zibaldone» a «zabaione». Sennonché Leopardi è capace di un’ironia sovrana. In modo altrettanto sovrano sa indirizzarla su di sé. Prendere sul serio chi fa dell’ironia sulla propria opera, e l’opera contiene pietre preziose, è – mi sembra – segno di cattivo gusto e di poco spirito. Da parte mia, per evitare almeno in questo caso tali inconvenienti, dirò Pensieri invece di Zibaldone – come appunto ho fatto nei miei scritti dedicati al pensiero di Leopardi (e nelle citazioni indicherò Pensieri con l’abbreviazione P).
Ritorniamo alla replica contenuta nelle pagine 4277-79 dei Pensieri. Parlando della natura che ci fa piangere i nostri morti, la replica non si confronta con l’apostolo Paolo. Ma il riferimento al cristianesimo è implicito nel suo modo di rifiutare, si è visto, la tesi dell’immortalità dell’anima. Nei Pensieri le numerose pagine che riguardano il cristianesimo hanno un’importanza centrale. Altrettanto centrale la critica a Platone e alla sua dottrina dell’immortalità (e anzi dell’eternità) dell’anima.
La natura, dunque. Un concetto complesso, nell’opera di Leopardi. Nel passo sul compianto dei morti la natura mostra uno dei lati di questa complessità: la natura è il nostro desiderio di essere felici. È presente nell’uomo inteso sia come genere sia come individuo. E ognuno la felicità la desidera per sé e per chi ama. Amiamo una persona quando desideriamo che anche lei sia felice. Dunque, quando accade che muoia, l’istinto naturale ce la fa piangere perché crediamo che non possa più esser felice, «mai più» felice; e che nemmeno noi possiamo continuare a esser felici per la sua presenza, la sua vita, per quel che c’è stato tra noi. Se cioè vogliamo sapere «quel che passa nell’animo nostro» quando muore chi amiamo – quel che naturalmente, istintivamente vi passa –, «troveremo che il pensiero che principalmente ci commuove, è questo: egli è stato, egli non è più, io non lo vedrò più» (P 4278). Un anno dopo Leopardi scrive A Silvia; due anni dopo Le ricordanze. Due dei suoi Canti più alti. Canta il «mai più» di Silvia e di Nerina. Canta? Non è stridente il cantare la morte di due ragazze che egli ha amato? La risposta è negativa. Quando mostreremo perché, ci troveremo dinanzi a uno dei temi decisivi del pensiero di Leopardi.
Va però anche osservato (qualche riserva la renderemo esplicita più avanti) che Leopardi considera il pianto per i morti come atteggiamento dell’intero genere umano, laddove esso è l’atteggiamento che si riscontra, come oggi sappiamo, in un certo ambito della storia dell’uomo, degli ultimi millenni e di certe regioni della Terra. Se cioè si può presumere che ogni uomo desideri la felicità e il piacere, ossia che questa sia la natura di ogni uomo, ciò non implica che, dinanzi alla morte di chi è stato amato, ogni uomo creda che l’amato non tornerà «mai più» perché è totalmente «privato della vita e dell’essere». Sarà il popolo greco a crederlo, guidato dai suoi pensatori. Con i Greci l’uomo incomincia a morire e a esser pianto in un modo assolutamente nuovo, inaudito. E la filosofia greca è il terreno in cui cresce l’intera storia dell’Occidente.
Comunque, a parte l’estrapolazione che attribuisce a tutti l’atteggiamento di alcuni di fronte alla morte, Leopardi può dire: «Allegano [cioè si appellano] in favore dell’immortalità dell’animo il consenso degli uomini. A me par di potere allegare questo medesimo consenso in contrario [cioè per dimostrare il contrario]».
Appunto perché la natura ci fa piangere i nostri morti e ce li fa piangere perché per natura crediamo che essi non siano più e che noi non li vedremo mai più. È «il pensiero della caducità umana», che è il contrario del credere nell’immortalità. Il compianto dei morti mostra che il «consenso degli uomini» è per «il non esser definitivamente più» di chi è morto. Non lo piangeremmo se potessimo pensare tra noi: «io rivedrò però questo tale dopo la mia morte». Ma questo è il sentimento che nessuno prova, qualsiasi siano le sue convinzioni razionali (P 4277-79).
Il tema del «mai più» ritornerà in Consalvo. Morente, chiede «un bacio» all’amante, prima di esser lasciato per sempre («pria / di lasciarmi per sempre, Elvira», vv. 49-50). Lui la lascia nella vita, lei lo lascia nel nulla della morte. Il tema era già stato toccato nei primi mesi del 1821: «Non c’è forse persona tanto indifferente per te, la quale salutandoti nel partire per qualunque luogo, o lasciarti in qualsiasi maniera, e dicendoti, non ci rivedremo mai più, per poco d’anima che tu abbia, non ti commuova, non ti produca una sensazione più o meno trista. L’orrore e il timore che l’uomo ha, per una parte, del nulla, per l’altra, dell’eterno [ossia l’orrore e timore dell’eternità del nulla] si manifesta da per tutto, e quel mai più non si può udire senza un certo senso […]: è partito per sempre – per sempre? Sì: tutto è finito rispetto a lui: non lo vedrò mai più: nessuna cosa sua avrà più niente di comune colla mia» (P 644-45). Questo è il sentimento che ognuno prova, qualsiasi siano le sue convinzioni razionali. L’orrore e timore del nulla – del nulla in cui va progressivamente cadendo ogni momento della vita, e del nulla definitivo della morte – è orrore e timore dell’eternità del nulla, della morte. Il Coro di morti che apre il Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, composto nel 1824, incomincia così:
Sola nel mondo eterna, a cui si volve
ogni creata cosa,
in te, morte, si posa
nostra ignuda natura;
lieta no, […]
la nostra natura – il nostro desiderio di felicità – che con la morte è rimasta «ignuda», spogliata dell’essere.
(Refrain. La potenza espressiva del linguaggio di Leopardi è evidente. Per un certo tipo di lettore può essere appagante, anche se sconvolgente. Altri possono restare indifferenti. Possono già aver chiuso queste pagine. Ma per chi continua a leggere è decisivo ripetere che con Leopardi non si ha semplicemente a che fare con uno scrittore e un poeta che «fa pensare». O meglio: egli fa pensare non soltanto così come uno scrittore o un poeta possono far pensare, ma come il pensatore che riesce a superare, «in verità», l’intera tradizione della civiltà occidentale, cioè secondo il senso che la «verità» possiede all’interno di tale tradizione. Se la tradizione dell’Occidente sembra viva, dicevamo nelle «Istruzioni», è viva nello stesso senso in cui le foglie secche restano ancora legate ai rami. Leopardi è il Giocatore Nero che ha partita vinta sul Giocatore Bianco. Indicheremo nei capitoli 4 e 5 le mosse essenziali di questa partita. Non è una esagerazione affermare che in essa viene giocata la sorte del nostro tempo. La nostra.)
![]()
2
«In mezzo al nulla» e «il naufragar m’è dolce in questo mare»
Il sentimento del «mai più», per Leopardi, è provato da ognuno, qualsiasi siano le sue convinzioni razionali. Si è visto. Le convinzioni razionali, appunto. Che valore hanno? E che valore ha la voce della natura? Giacché di tutto questo il passo 4277-79 dei Pensieri, da cui abbiamo preso le mosse nel capitolo precedente, non parla. Parla invece della direzione verso cui effettivamente si dirige il «consenso degli uomini». Nel 1827 – quando stende quelle pagine –, della verità, del valore della ragione e della natura i Pensieri si sono già occupati a fondo.
Già nel 1819 Leopardi scriveva: «Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla» (P 85).
Ha ventun anni. Questo passo complica notevolmente le considerazioni che abbiamo svolto sin qui. Soprattutto perché nel 1819 Leopardi scrive anche L’infinito, e l’infinito è l’«eterno», l’«immensità» del «mare» in cui è per lui «dolce» fare naufragio. Mentre non è certo «dolce», ma spaventoso e soffocante, fare naufragio «in mezzo al nulla». Il nulla è la morte, «sola nel mondo eterna», in cui «si posa / nostra ignuda natura».
Possiamo aggiungere, sviluppando uno spunto toccato nel capitolo precedente, che, contrariamente a quanto Leopardi ritiene, la morte non è sempre stata pensata come annullamento e come il nulla che risulta dall’annullamento. Infatti solo il pensiero greco incomincia a pensare che l’altro, ossia ciò che nel loro divenire le cose diventano, è l’assolutamente altro dal loro essere: è il nulla. Prima dei Greci questo senso radicale del nulla è ignorato. Se il corpo vivo di un uomo diventa un cadavere, tuttavia sia l’uno sia l’altro si lasciano vedere e toccare, sono entrambi cose, essere. Il cadavere è solo relativamente altro dal corpo vivo. Per le civiltà pregreche il diventar cadavere è l’inizio di un viaggio che consente ai viventi di mantenere rapporti di diversa natura con chi è partito. Se piangono i loro morti, il loro è un pianto diverso da quello dei Greci, che nel cadavere credono di vedere l’annullamento di una vita, il «mai più», l’esser «passato per sempre». Ma ritorniamo al passo (P 85) del 1819.
«Considerando e sentendo che tutto è nulla», Leopardi si sente soffocare. Nel passo del 1819 si parla sia di un «considerare» sia di un «sentire». C’è il «sentire»: appartiene alla sfera del «sentimento intimo», che abbiamo incontrato sopra; ci fa piangere i nostri morti ed è prodotto dal desiderio di felicità per noi e per coloro che amiamo, quando tale desiderio è frustrato dalla loro morte. Ma c’è anche il «considerare». Questa parola guarda più alla ragione che all’istinto. Indica la verità. Propriamente, anticipa la grande sequenza che nei Pensieri conduce alla distruzione del platonismo e del cristianesimo, le fondamenta della tradizione dell’Occidente. È come se Leopardi anticipasse i risultati essenziali della sua indagine. L’anticipazione va quindi interpretata alla loro luce.
«Tutto è nulla.» L’espressione non è da intendere come un piatto rifiuto del «principio di non contraddizione». La negazione di questo principio, in Leopardi, è estremamente più complessa. È ovvio che per lui l’essere ancora vivi non equivale all’essere morti. Il «mai più» si riferisce a ciò che ne è della vita quando muore una persona amata; non quando essa è viva. La vita non è la morte. L’essere non è il nulla.
Dunque «tutto è nulla» (e «un nulla io medesimo») nel senso, appunto, che tutto è «in mezzo al nulla», ossia viene dal nulla e va nel nulla. Non è prodotto da un Demiurgo o da un Dio; e, finendo, non è accolto da braccia divine. «Essere» significa trovarsi provvisoriamente «in mezzo al nulla». «Sentire» e «considerare» questo è spaventoso, orrore e timore. Avvertire il nulla da cui ogni cosa è circondata (l’avvertire che è «il pensiero della caducità umana») significa esser soffocati da questo stesso nulla. Il nulla soffoca in quanto è sentito e considerato; non in quanto è nulla. In quanto, sentito e considerato, è soffocante, orrendo e temibile, il nulla è «solido».
Se e poiché per Leopardi la verità scoperta dalla ragione è questa, cioè «che tutto è nulla, solido nulla», allora la conoscenza della verità è la fonte dell’angoscia più profonda in cui l’uomo può precipitare – la falla che provoca il naufragio dove annega ogni speranza, ogni illusione, ossia ogni felicità. Infatti (scrive l’anno successivo) «la felicità consiste nell’ignoranza del vero» (P 326). Solo voltando le spalle alla verità si può avere quel tanto di felicità che ci è concessa.
Sennonché, dicevamo, nello stesso periodo in cui formula queste tesi, Leopardi compone L’infinito. È spesso interpretato come un canto positivo, che dal tempo conduce all’eterno. Il poeta ode la «voce» del vento, là sul «colle» dove gli è «caro» rifugiarsi. E lo...