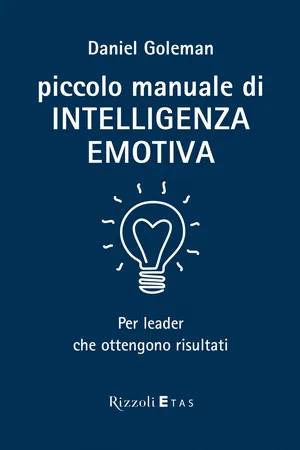
eBook - ePub
Piccolo manuale di intelligenza emotiva
Per leader che ottengono risultati
- 180 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Che cosa conta di più per avere successo: il quoziente intellettivo o il quoziente emotivo? Il QI è importante, ma le competenze che si basano sull'intelligenza emotiva - la capacità di gestire noi stessi e le nostre relazioni - sono quelle che distinguono i leader migliori. In questa agile guida Daniel Goleman raccoglie i concetti chiave dei suoi studi per ottenere una performance superiore in tutti gli ambiti complessi, dalla medicina al management, dalla giurisprudenza alla finanza.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Piccolo manuale di intelligenza emotiva di Daniel Goleman in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Letteratura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1
LE CARATTERISTICHE DEL LEADER
Tutti gli uomini e le donne d’azienda conoscono almeno un caso in cui un dirigente intelligentissimo e preparatissimo è stato promosso a un ruolo di leadership dove ha fallito clamorosamente. E conoscono anche il caso di qualcuno che aveva buone capacità intellettuali (ma non eccezionali) e discrete competenze tecniche, ma quando è stato promosso a un ruolo di leadership ha fatto benissimo. Questi esempi sostengono la diffusa convinzione che identificare coloro che hanno la “stoffa giusta” per diventare leader sia più arte che scienza. Dopotutto, gli stili personali dei grandi leader variano: alcuni sono silenziosi e analitici; altri gridano i loro messaggi dalla cima di una montagna. E, cosa altrettanto importante, situazioni diverse necessitano tipi diversi di leadership. Quasi tutte le fusioni richiedono la presenza al vertice di un abile negoziatore, mentre molte ristrutturazioni richiedono un’autorità più carismatica. Io ho scoperto, tuttavia, che i leader più efficaci si assomigliano per un aspetto decisivo: hanno tutti un’elevata intelligenza emotiva.
Ciò non significa che il QI e le competenze tecniche siano irrilevanti. Contano certamente, ma soprattutto come “soglie di ingresso”; vale a dire che sono i requisiti di base per accedere al senior management. Tuttavia, le mie ricerche, insieme ad altri studi recenti, indicano inequivocabilmente che l’intelligenza emotiva è la condicio sine qua non della leadership. Se manca, la persona può avere la miglior formazione del mondo, una mente incisiva e analitica, e un flusso incessante di idee brillanti, ma non sarà mai un grande leader. Io e i miei colleghi ci siamo concentrati su come opera l’intelligenza emotiva nell’ambiente di lavoro. Abbiamo esaminato la relazione tra intelligenza emotiva e performance efficace, specialmente nei leader, e abbiamo cercato di capire come si manifesta l’intelligenza emotiva nell’esercizio dei propri compiti. Come potete sapere, per esempio, se qualcuno ha un’elevata intelligenza emotiva? E come potete riconoscerla in voi stessi? Cercheremo di rispondere a queste domande, passando in rassegna una per una le componenti dell’intelligenza emotiva: autoconsapevolezza, autoregolamentazione, empatia e orientamento ai rapporti sociali.
Oggi quasi tutte le grandi aziende hanno affidato a psicologi specializzati lo sviluppo di “modelli delle competenze” che dovrebbero aiutare a identificare, formare e promuovere le stelle che andranno a illuminare il firmamento della leadership. Gli psicologi hanno sviluppato modelli analoghi anche per posizioni di livello più basso. Mentre scrivevo Lavorare con intelligenza emotiva, ho analizzato i modelli delle competenze di 188 tra aziende – in prevalenza grandi e globali – e agenzie governative. L’obiettivo che mi prefiggevo era stabilire quali capacità personali potevano indurre una performance eccellente in quelle organizzazioni, e in che misura lo facevano. Ho raggruppato le capacità in tre categorie: competenze puramente tecniche come l’accounting e la pianificazione strategica; abilità cognitive come il ragionamento analitico e competenze che dimostrano intelligenza emotiva, come l’attitudine a lavorare insieme agli altri e l’efficacia nel guidare il cambiamento. Per creare alcuni modelli delle competenze, gli psicologi hanno chiesto ai senior manager delle aziende di identificare le capacità che caratterizzavano i leader più apprezzati dell’organizzazione. Per realizzarne altri, gli psicologi hanno usato criteri oggettivi, come la profittabilità di una divisione, in modo da differenziare le star dai soggetti medi ai livelli senior. Quelle persone sono state intervistate approfonditamente e sottoposte a test analitici, e le loro capacità sono state poi messe a confronto. Questo processo ha portato alla creazione di elenchi delle caratteristiche dei leader altamente efficaci. Gli elenchi includevano da sette a quindici elementi, tra cui l’iniziativa e la visione strategica. Alcune delle competenze riflettevano abilità puramente cognitive, legate al QI, o competenze puramente tecniche, mentre altre si basavano largamente su abilità legate all’intelligenza emotiva come l’autogestione.
Quando ho analizzato tutti questi dati, ho scoperto delle cose sorprendenti. Certo, l’intelligenza stava alla base di una performance di prim’ordine. Competenze cognitive come la visione del quadro complessivo e una prospettiva di lungo termine erano particolarmente importanti. Ma quando ho calcolato il rapporto tra competenze tecniche e QI e intelligenza emotiva come ingredienti di una performance eccellente, l’intelligenza emotiva si è rivelata due volte più importante delle altre per mansioni di tutti i livelli. La mia analisi dimostrava inoltre che essa aveva un ruolo sempre più decisivo ai massimi livelli dell’azienda, dove le differenze nelle competenze tecniche erano d’importanza trascurabile.
In altre parole, più alto era il livello gerarchico di un performer eccezionale, più la sua efficacia era spiegata da capacità associate all’intelligenza emotiva. Quando ho confrontato le “star” con i soggetti medi a livello di senior management, quasi il 90% delle competenze che le caratterizzavano erano attribuibili a fattori che si possono ricondurre all’intelligenza emotiva, anziché ad abilità puramente cognitive. Altri ricercatori hanno confermato che oltre a distinguere i grandi leader, l’intelligenza emotiva si può anche collegare a una performance di altissimo livello.
Le scoperte del compianto David McClelland, uno dei più grandi studiosi del comportamento umano e organizzativo, offrono un esempio emblematico. In uno studio del 1996 su un’azienda alimentare globale, McClelland ha scoperto che quando i senior manager avevano una massa critica di capacità riferibili all’intelligenza emotiva, le loro divisioni eccedevano del 20% gli obiettivi annui di profitto. E, nel frattempo, i leader divisionali che non avevano quella massa critica li mancavano quasi nella stessa misura. Curiosamente, le scoperte di McClelland valevano sia per le divisioni americane sia per quelle asiatiche ed europee dell’azienda. In poche parole, i numeri ci raccontano una storia convincente sul legame tra il successo di un’azienda e l’intelligenza emotiva dei suoi leader. E, cosa non meno importante, la mia ricerca dimostra inoltre che, se adottano l’approccio giusto, le persone possono sviluppare la propria intelligenza emotiva.
Autoconsapevolezza
L’autoconsapevolezza è la prima componente dell’intelligenza emotiva, com’è facile immaginare se pensiamo che migliaia di anni fa l’oracolo di Delfi consigliava a chi lo consultava: “Conosci te stesso”. Autoconsapevolezza vuol dire avere una profonda conoscenza delle proprie emozioni, dei propri punti deboli, dei propri punti di forza, dei propri bisogni e dei propri desideri. Le persone altamente consapevoli di sé non sono né ipercritiche né irrealisticamente speranzose. Sono oneste con se stesse e con gli altri. Sanno come i sentimenti incidono su di sé, sul prossimo e sulla propria performance lavorativa. Così, una persona autoconsapevole che sa di essere in difficoltà quando le scadenze incombono pianifica accuratamente il proprio tempo e porta a termine il lavoro in anticipo. Un’altra persona altamente consapevole di sé riuscirà a soddisfare un cliente esigente. Capirà l’impatto che questi ha sui propri atteggiamenti e le ragioni più profonde della propria frustrazione. “Le sue richieste capricciose ci distolgono dal lavoro vero che bisogna fare”, potrebbe spiegare. Perciò fa un passo avanti e trasforma la sua irritazione in qualcosa di costruttivo.
L’autoconsapevolezza si estende alla comprensione dei propri valori e dei propri obiettivi. Chi è altamente consapevole di sé sa dove vuole arrivare e perché; così, per esempio, rifiuterà un’offerta di lavoro finanziariamente attraente ma non in linea con i suoi principi o con i suoi valori di lungo termine. Una persona che manca di autoconsapevolezza tende a prendere decisioni che poi provocano un travaglio interiore perché calpestano valori profondi. “Mi offrivano tanti soldi, perciò ho firmato”, potrebbe affermare due anni dopo, “ma il lavoro mi dice così poco che sono perpetuamente annoiato”. Le decisioni delle persone consapevoli sono coerenti con i loro valori; di conseguenza trovano spesso entusiasmante il proprio lavoro.
Come si può riconoscere l’autoconsapevolezza? Essa si manifesta, anzitutto e soprattutto, nella sincerità e nella capacità di valutare se stessi in modo realistico. Le persone molto consapevoli di sé sono in grado di parlare lucidamente e apertamente – ma non necessariamente anche in tono enfatico o confessionale – delle proprie emozioni e dell’impatto che producono sul loro lavoro. Per esempio, una manager di cui mi hanno riferito era scettica su un nuovo servizio che voleva introdurre la sua azienda, una catena di grandi magazzini: la messa a disposizione di un personal shopper. Senza aver avuto sollecitazioni in proposito dai suoi collaboratori o dal suo capo, ha dato loro una spiegazione: “Faccio fatica a condividere l’introduzione di questo servizio”, ha ammesso, “perché ci tenevo molto a gestire il progetto, ma non me l’hanno affidato. Sopportatemi finché non digerisco l’amarezza”. Ha esaminato a fondo i propri sentimenti, e una settimana dopo era pienamente focalizzata sul progetto. L’autoconsapevolezza viene fuori spesso nei colloqui di selezione. Chiedete a un candidato di descrivere un caso in cui si è lasciato guidare dai sentimenti e ha fatto qualcosa di cui poi si è pentito. I candidati consapevoli di se stessi non hanno problemi ad ammettere questo tipo di errore, e a volte lo raccontano con un sorriso. Uno dei segni distintivi dell’autoconsapevolezza è la capacità di ironizzare su di sé.
L’autoconsapevolezza si può identificare anche nella valutazione della performance. Le persone consapevoli di sé conoscono i propri limiti, non hanno difficoltà a parlarne, e dimostrano frequentemente un sincero apprezzamento per le critiche costruttive. Per contro, chi ha una bassa autoconsapevolezza interpreta l’invito a migliorare come una minaccia o come una forma di insuccesso. Le persone consapevoli di sé si possono riconoscere anche dalla fiducia che manifestano in se stesse. Conoscono bene le proprie capacità e sono meno inclini a rischiare l’insuccesso, assumendosi per esempio incarichi che non sono sicuri di poter ricoprire adeguatamente. Sanno, poi, quando chiedere aiuto. E sul lavoro non domanderanno una sfida che sanno di non poter gestire da sole. Cercano di sfruttare i loro punti di forza.
Riflettete sulle azioni di un manager intermedio che è stato invitato a partecipare a una riunione strategica con i massimi dirigenti della sua azienda. Pur essendo la persona di livello gerarchico più basso, non si è limitato ad ascoltare, rifugiandosi in un ossequioso silenzio. Sapeva di avere una mente logica e la capacità di presentare le idee in modo convincente, e ha fornito suggerimenti ineccepibili sulla strategia aziendale. Nello stesso tempo, l’autoconsapevolezza gli ha impedito di sconfinare in un terreno su cui sapeva di essere debole. A dispetto del beneficio che le persone autoconsapevoli possono apportare all’ambiente di lavoro, la mia ricerca indica che spesso e volentieri i senior manager non accordano a questa capacità il credito che merita quando sono alla ricerca di leader potenziali. Molti dirigenti scambiano la trasparenza sui sentimenti per “debolezza” e non trattano con il dovuto rispetto i dipendenti che riconoscono apertamente i propri limiti. Queste persone vengono giudicate troppo affrettatamente “non abbastanza toste” da guidarne delle altre.
In realtà è esattamente il contrario. Anzitutto, la gente ammira e rispetta la sincerità. In secondo luogo, i leader devono prendere in continuazione decisioni discrezionali che richiedono una valutazione obiettiva delle capacità, proprie e altrui. Abbiamo l’esperienza manageriale che occorre per acquisire un concorrente? Possiamo lanciare un nuovo prodotto nel giro di sei mesi? Le persone che si valutano onestamente – ossia le persone autoconsapevoli – sono in condizione di fare la stessa cosa per le organizzazioni che dirigono.
Autoregolamentazione
Gli impulsi biologici guidano le nostre emozioni. Non possiamo sopprimerli, ma possiamo fare molto per gestirli. L’autoregolamentazione, che assomiglia molto a una conversazione interiore continua, è la componente dell’intelligenza emotiva che ci libera dalla tirannia dei nostri sentimenti. Le persone impegnate in una conversazione di questo tipo provano sentimenti negativi e impulsi emozionali come chiunque altro, ma trovano la maniera di controllarli e persino di incanalarli in modi produttivi. Immaginate un dirigente che ha appena visto un gruppo di collaboratori presentare un’analisi pasticciata al comitato direttivo dell’azienda. Sull’onda dello sconforto, potrebbe avere la tentazione di battere i pugni sul tavolo o di prendere a calci una sedia. Potrebbe saltare su e fare una scenata ai colleghi. Oppure potrebbe chiudersi in un minaccioso silenzio, guardandoli in faccia uno dopo l’altro prima di andarsene indignato. Ma se avesse il dono dell’autoregolamentazione, adotterebbe un altro approccio. Sceglierebbe le parole con cura, riconoscendo la performance deludente del team senza dare giudizi affrettati. Poi farebbe un passo indietro per cercare di capire i motivi dell’insuccesso. Sono personali: mancanza di impegno? Ci sono dei fattori attenuanti? Qual è stato il suo ruolo nella débâcle? Dopo aver risposto a queste domande, riunirebbe il team, spiegherebbe le conseguenze dell’episodio ed esprimerebbe i propri sentimenti in proposito. Poi presenterebbe la sua analisi del problema e offrirebbe una soluzione ragionata.
Perché l’autoregolamentazione conta così tanto per i leader? Anzitutto, coloro che sanno controllare i propri sentimenti e i propri impulsi – ossia le persone ragionevoli – sono in grado di creare un ambiente ispirato alla fiducia e alla correttezza. In un ambiente di questo tipo, i giochi politici e le lotte intestine si riducono drasticamente e la produttività è elevata. Le persone di talento sono attratte dall’organizzazione e non hanno desiderio di andarsene. E l’autoregolamentazione ha un effetto a cascata. Nessuno vuole farsi la fama di testa calda quando il capo è noto per la razionalità del suo approccio. Meno chiassate al vertice vuol dire meno chiassate in tutta l’organizzazione. In secondo luogo, l’autoregolamentazione è importante per ragioni competitive. Tutti sanno che il business di oggi è caratterizzato dall’ambiguità e dal cambiamento. Le aziende si fondono e si separano regolarmente. La tecnologia trasforma il lavoro a un ritmo vertiginoso. Coloro che hanno imparato a tenere sotto controllo le proprie emozioni possono adeguarsi al cambiamento. Quando ne viene annunciato uno, non si lasciano prendere dal panico; sospendono il giudizio, raccolgono informazioni e ascoltano attentamente i dirigenti mentre spiegano il nuovo programma. A mano a mano che l’iniziativa va avanti, queste persone sono in grado di assecondarla. A volte assumono addirittura un ruolo di leadership.
È il caso di un manager di una grande azienda industriale. Come i suoi colleghi, usava un certo software da cinque anni. Quel programma condizionava il modo in cui raccoglieva e presentava i dati, e anche il suo punto di vista sulla strategia dell’azienda. Un giorno, il top management ha annunciato l’introduzione di un nuovo programma informatico che avrebbe rivoluzionato la raccolta e la valutazione dei dati all’interno dell’organizzazione. Mentre molti dipendenti si lamentavano dello sconvolgimento, lui si è interrogato sulle ragioni che avevano portato all’adozione del nuovo software e si è convinto che poteva migliorare davvero la performance. Ha partecipato attivamente alle sessioni di addestramento – alcuni suoi colleghi si sono rifiutati di farlo – e alla fine è stato promosso a capo di varie divisioni, anche perché usava la nuova tecnologia con la massima efficacia.
Voglio sottolineare ulteriormente l’importanza dell’autoregolamentazione ai fini della leadership, e farvi notare che rafforza l’integrità, che non è solo una virtù personale ma anche un punto di forza organizzativo. Molte patologie che affliggono le aziende derivano da un comportamento impulsivo. Le persone non progettano quasi mai di gonfiare i profitti, truccare le note spese, mettere le mani sulla cassa o abusare del potere per finalità egoistiche. Ma se si presenta l’occasione, quelli che hanno un basso controllo sui propri impulsi tendono ad approfittarne. Considerate per contro il comportamento del direttore commerciale di una grande azienda alimentare. Era onesto fino allo scrupolo nelle trattative con i distributori locali. Spiegava la sua struttura dei costi nei minimi dettagli, offrendo loro una visione realistica del pricing praticato dall’azienda. Questo approccio gli impediva di imporre sempre e regolarmente le sue condizioni. Di tanto in tanto provava la tentazione di accrescere i profitti tenendo per sé delle informazioni sui costi dell’azienda, ma resisteva a quell’impulso, perché si rendeva conto che nel lungo termine era meglio così. La sua autoregolamentazione si è tradotta in solide relazioni con i distributori, che hanno reso all’azienda più di qualunque beneficio finanziario immediato.
I segni dell’autoregolamentazione emotiva, perciò, sono facili da riconoscere: la propensione alla riflessione e alla ponderazione; l’accettazione dell’ambiguità e del cambiamento; e l’integrità, ossia la capacità di reprimere gli impulsi. Come l’autoconsapevolezza, spesso anche l’autoregolamentazione non riceve il credito che merita. Le persone che sono in grado di tenere a freno le proprie emozioni sono viste spesso come dei tipi freddi: le loro reazioni meditate vengono sbrigativamente liquidate come sintomo di insensibilità. I tipi irascibili si inquadrano spesso nello stereotipo “classico” del leader: i loro sfoghi violenti si considerano segni di carisma e di potere. Ma quando questi soggetti arrivano al top, l’impulsività gioca spesso co...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Sommario
- Introduzione
- 1 Le caratteristiche del leader
- 2 Una leadership che produce risultati
- 3 La leadership primaria: il driver occulto di una performance eccellente
- 4 Risvegliare la vostra passione per il lavoro
- 5 L’intelligenza sociale e la base biologica della leadership
- 6 La triplice focalizzazione del leader
- 7 Non solo intelligenti ma anche saggi. Perché i grandi leader devono avere una focalizzazione che va al di là delle loro organizzazioni
- Riferimenti bibliografici