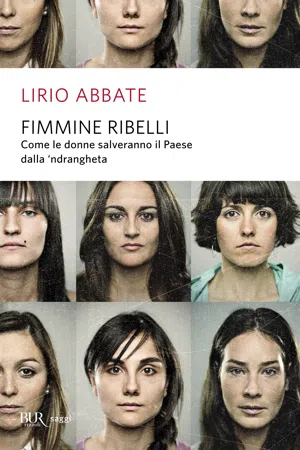![]()
1
Morire oggi in Calabria
È una sera di luglio del 2009. Sono in casa a Palermo, e sto per sedermi a tavola per la cena quando squilla il cellulare. Sul display vedo il nome di mia cugina, che abita con la sua famiglia in un piccolo paese della provincia di Cosenza. Tra qualche settimana si sposerà con un ragazzo che è buono come il pane. Così immagino che mi stia chiamando per chiedermi un consiglio o un aiuto per gli ultimi preparativi. Rispondo in maniera scherzosa, ma mi accorgo stupito che lei sta singhiozzando. Penso subito alle nozze, a qualcosa che possa essere andato storto.
«Che ti succede? Perché piangi?» le domando preoccupato. È come se ogni parola le costasse un’immensa fatica. Poi di botto mi dice: «Enzo è morto!». Ammutolisco. Un dolore lancinante al petto, non riesco a respirare. Devo sedermi e riprendere fiato qualche secondo prima di aprire bocca.
Enzo era mio cugino. Un ragazzone di quasi un metro e ottanta che aveva un anno meno di me. Era nato a Milano, e lì aveva vissuto i primi anni della sua vita finché i suoi genitori avevano deciso di trasferirsi in Calabria. Credevano, e penso che ci credano ancora, nella bontà di
questa terra. Tutte le estati fino all’adolescenza le abbiamo trascorse insieme nella mia casa di campagna in Sicilia, dove lui, dopo qualche caduta rocambolesca, ha imparato ad andare in bici, e dove facevamo grandi nuotate nel nostro mare e giochi spericolati nei campi, sotto l’occhio vigile di mio nonno Vincenzo. Eravamo felici, spensierati, e lui si addossava spesso, con cavalleria, la colpa delle marachelle commesse dagli altri. Crescendo, le nostre strade si sono divise: lui è rimasto in Calabria, ha conosciuto una brava ragazza, si è sposato ed è diventato padre di una bellissima bambina, Anna.
«Calmati» balbetto al telefono cercando di rimandare indietro le lacrime, «calmati e dimmi come è successo.» «Non lo sappiamo nemmeno noi» mi dice lei. «È accaduto poche ore fa. È stato trovato a terra a casa sua con la testa fracassata.» «Avete chiamato un medico, i carabinieri?» domando nel tentativo di aggrapparmi a qualcosa, a qualcuno per cercare aiuto. «Sì, sì, sono tutti a casa di Enzo, ma lui è morto e non sappiamo come.» «Ascoltami, dammi il tempo di avvertire i ragazzi della scorta, così mi metto subito in macchina e fra alcune ore sarò lì da voi.»
La strada tra Palermo e Cosenza l’ho fatta già tante volte, ma stasera mi sembra non finire mai. Continuano a scorrermi davanti agli occhi immagini di Enzo, di lui bambino, di lui con la figlioletta tra le braccia. Sempre sorridente. Sempre disponibile con chi aveva bisogno. A un giovane rumeno disoccupato e senza casa aveva offerto un tetto e un lavoro. Non riesco a credere che sia successo davvero, e non riesco nemmeno a figurarmi il dolore di sua moglie, della piccola Anna, delle mie cugine e dei miei
zii. Eravamo tutti felicemente in attesa del giorno delle nozze, ora invece abbiamo il lutto nel cuore.
Come un automa, macino chilometri di autostrada fino a Messina, mi imbarco sul traghetto e affronto la logorante odissea della Salerno-Reggio Calabria, perpetuo cantiere costellato di interruzioni e tratti di carreggiata a doppio senso. Dopo quasi cinque ore di viaggio arrivo al paese di Enzo, che così silenzioso e punteggiato di luci mi sembra un piccolo presepe. Mi fermo davanti alla villetta in cui abitava, immersa nel verde, ai piedi di una collina. Dal cancello in ferro battuto che dà accesso al giardinetto davanti alla casa entrano ed escono decine di persone. Ci sono parenti, amici, vicini e un paio di carabinieri. Quello che dovrebbe essere uno spazio tutelato, per preservare eventuali impronte o indizi utili alle indagini, è ormai inesorabilmente contaminato. Uno dei militari dell’Arma ha addirittura chiesto a un parente di Enzo di ripulire il sangue da terra. E fare ordine. Scelte inaudite, fuori da ogni logica investigativa, dettate forse da pregiudizi verso la vittima. Ma non è raro che i preconcetti, in questa terra, prevalgano sulla giustizia. Ci vorranno ventiquattr’ore perché la magistratura si accorga della situazione e ordini il sequestro della casa. Ma ormai è troppo tardi. A disporre gli accertamenti e coordinare le indagini è un pm della procura di Cosenza. È una romana, ed è capace. Intuisce da subito che questa morte nasconde qualcosa.
È a casa dei miei zii, a circa mezzo chilometro da quella di Enzo, che la tragedia mi investe in tutta la sua realtà. I genitori e le mie cugine piangono sconvolti e la moglie di Enzo mi appare ancor più minuta di quanto non sia. Nessuno riesce a capacitarsi dell’accaduto, a trovare anche
solo un barlume di spiegazione. Enzo era amato e stimato da tutti in paese, per il suo carattere energico e gioviale, lo spirito vivace con cui si rapportava agli altri, la solarità. E tutti avevano apprezzato il coraggio da lui dimostrato a vent’anni, quando, da solo, era riuscito a sottrarsi all’influenza di individui senza scrupoli che cercavano di avviarlo sulla cattiva strada, su cui tanti ragazzi calabresi si perdono, per quanto solidi siano i principi trasmessi loro dalle famiglie. Quell’esperienza lo aveva segnato, lasciandogli cicatrici nell’anima, ma alla fine la sua fiducia nella vita aveva avuto il sopravvento. Enzo si era sposato, e per mantenere la famiglia si spaccava ogni giorno la schiena lavorando nei campi e tagliando la legna, senza lamentarsi mai, sempre pronto a rimboccarsi le maniche col sorriso sulle labbra.
La sua morte improvvisa ha stupito e addolorato tutti quelli che lo conoscevano. Alcuni pensano che il suo errore sia stato quello di essere troppo buono con le persone sbagliate, che hanno approfittato di lui. Nessuno sembra dar credito all’infamia e al fango che qualche investigatore della provincia cosentina gli getta addosso attraverso i giornali. A distanza di qualche anno, soltanto uno dei quotidiani calabresi darà conto della notizia che quella morte è un omicidio mascherato e che Enzo era una persona pulita, rimasta vittima di una ferocia che purtroppo, a causa dei pregiudizi di certi uomini di Stato, resterà impunita.
Mi fermo in Calabria qualche giorno, in attesa degli esiti delle indagini, affidate a un maresciallo di una piccola stazione dei carabinieri. Il capitano che comanda la sua compagnia non ritiene opportuno affiancargli i reparti
investigativi che di solito seguono i casi di omicidio. Il pm continua a chiedere uomini e mezzi per condurre le indagini, ma occorrono settimane prima che qualcuno si muova. In molte zone della Calabria, purtroppo, l’amministrazione della giustizia non sempre risponde ai principi di efficienza ed equità che lo Stato dovrebbe salvaguardare.
È la prima volta che un mio parente viene coinvolto in maniera diretta in un fatto di sangue. Il mio lavoro mi ha messo di fronte a molti omicidi, in Sicilia, a molte storie violente che ho cercato di ricostruire e raccontare come cronista. Questa volta è diverso. E diversi sono gli occhi con cui guardo a questa terra lacerata da una guerra impietosa alimentata dall’odio e dalla sete di denaro e potere, di cui fanno le spese persone che aspirano solo a una vita onesta e pacifica. Enzo è stato probabilmente una vittima innocente di questa guerra. In base a quanto accertato dal pm di Cosenza, infatti, è stato assassinato. I risultati dell’autopsia sono chiari, sul suo cranio è stata rilevata una ferita determinata non dall’impatto col pavimento in seguito alla caduta, bensì da un corpo contundente con il quale sarebbe stato colpito a più riprese. Da chi, ancora non si è scoperto, ma certo non poteva essere un suo nemico, perché Enzo di nemici non ne aveva.
In chiesa ci sono centinaia di giovani. Dopo i funerali, familiari e amici danno a Enzo l’ultimo saluto al cimitero. La piccola Anna e la mamma rimangono nella cappella davanti alla bara. Anna tiene stretto fra le mani un sacchetto con gli oggetti a cui il suo papà era più affezionato.
Guardo questa bambina che così presto, e con così tanto dolore, ha dovuto conoscere la violenza della sua terra e penso a mia figlia, che da quando è venuta alla luce si
è sempre vista intorno agenti di polizia e auto blindate. Uomini che ormai fanno parte della sua vita, della nostra vita, e che non mi stancherò mai di ringraziare per il lavoro che svolgono con dedizione, coraggio e sacrifici.
Per mesi mi sono svegliato di soprassalto nel cuore della notte per correre ad affacciarmi alla finestra. Scrutavo la strada, sgombra di auto perché è stata creata una zona rimozione anti bomba, col terrore che ai poliziotti o carabinieri in servizio di vigilanza sotto casa mia potesse accadere qualcosa.
Ho fatto fatica ad abituarmi a vivere con il peso della responsabilità, col pensiero che per colpa mia la mia famiglia o le persone che mi stanno accanto giorno e notte per proteggermi possano essere colpite. E solo per il fatto che racconto storie di mafie e complicità. È questo il mio lavoro, e non so farlo se non puntando dritto alla verità. Non sono un magistrato, non devo raccogliere prove e portare imputati in tribunale muovendomi entro i binari d’acciaio della legge e del codice penale. Sono un giornalista. Anche a me servono prove e riscontri alle notizie, ma il mio mestiere consiste nel collegare e analizzare i fatti, eventi socialmente e moralmente rilevanti, per dare ai lettori un quadro fedele e documentato della realtà in cui vive. Il giornalista arriva dove il magistrato non può per legge. E muovendosi in questa terra di nessuno può scatenare l’ira di mafiosi, collusi e favoreggiatori, che si nascondono spesso dietro le facciate rispettabili di politici, commercialisti, avvocati, medici, giudici, banchieri e, a volte, anche giornalisti.
I mafiosi e i loro complici mettono in conto di ricevere un avviso di garanzia, o di dover affrontare un processo
da cui comunque, in un modo o nell’altro, tenteranno sempre di tirarsi fuori, a volte riuscendoci grazie anche all’appoggio di uomini di Stato infedeli.
L’informazione, invece, la temono. E la temono soprattutto i colletti bianchi. Ogni volta che leggono sui giornali o ascoltano in televisione una notizia che li riguarda, impazziscono. Non tollerano che attraverso l’informazione si possa indurre un giudizio sul loro conto, non riescono ad affrontare lo scandalo.
Quando si tratta di proteggere chi cura i loro affari i mafiosi non indugiano, passano subito all’opera. Puntano a imbavagliare i giornalisti scomodi, e se non ci riescono li eliminano. È così che sono morti Giancarlo Siani e Peppino Impastato, Pippo Fava e Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Mario Francese, Beppe Alfano, Mauro Rostagno e Giovanni Spampinato. Tutti avevano raccontato gli affari delle mafie. Avevano indicato i complici e ricostruito la rete di collegamenti con la politica collusa. Sono stati uccisi perché avevano fatto i nomi dei colletti bianchi, non per aver raccontato le gesta criminali dei boss. O per aver pubblicizzato i loro nomi. Sono stati uccisi perché si sono spinti su un terreno dove la magistratura spesso non arriva. E oggi anche molti di noi sono in pericolo.
Perché di tanti delitti eccellenti o stragi mafiose, da Portella della Ginestra fino agli attentati a Falcone e a Borsellino o in via dei Georgofili a Firenze, sappiamo molto grazie ai processi. Ma non tutto. Degli omicidi di uomini dello Stato, investigatori, sindacalisti, preti, medici e giornalisti ancora oggi non conosciamo tutta la verità.
Nell’ingresso di casa mia ho appeso la foto di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, mi è stata regalata dal
fotografo che l’ha realizzata, Tony Gentile. È sistemata in modo che chiunque se la trovi di fronte appena entra.
Mia figlia vede questa immagine da quando è nata. Ce la siamo portata dietro in tutte le case in cui siamo stati trasferiti.
Mia figlia ha sei anni e non ha conosciuto Falcone e Borsellino. E quando un giorno mi ha chiesto chi fossero i due signori ritratti in quell’immagine in bianco e nero, le ho raccontato la loro storia e per la prima volta le ho parlato della mafia. Di quanto sia pericolosa, di quanto male faccia agli uomini e alla democrazia. Mentre parlavo mi rendevo conto che ciò che narravo non sempre coincideva con le sentenze scritte dai giudici, troppo spesso condizionate da depistaggi e insabbiamenti.
A mia figlia piace la musica e così, per aiutarla a capire, le ho fatto ascoltare I cento passi, una canzone scritta su Peppino Impastato. Lei ha cominciato a ballare ascoltando le parole con attenzione, e quando mi ha chiesto chi fosse il protagonista di quella canzone le ho detto che si trattava di un giovane che denunciava attraverso l’informazione gli affari dei boss e che per questo era stato ucciso e poi denigrato. E infine privato anche del diritto di avere giustizia, visto che le indagini sul suo caso erano state depistate.
Il nostro travagliato e martoriato paese ha bisogno di verità, oggi più che mai. Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari. E lo dobbiamo in particolare ai nostri figli. Perché solo se conosceranno davvero il loro passato potranno costruire il futuro.
Una sera con mia figlia abbiamo guardato in tv il film Johnny Stecchino, graffiante parodia della mafia ideata da Roberto Benigni. Quando un personaggio, parlando con
il protagonista, pur di non nominare la mafia dice che il vero problema della Sicilia, e in particolare di Palermo, è il traffico, entrambi abbiamo sorriso.
Alcuni giorni dopo ho assistito a un dialogo fra mia figlia e le sue amichette. «Perché il tuo papà ha la scorta?» chiedevano le bambine. E lei, dopo una breve riflessione ha risposto: «Perché al mio papà non va di guidare con tutto questo traffico».
Sono convinto che Anna, la figlia di Enzo, diventerà grande in questo pezzo di Calabria. E a lei voglio raccontare altre storie, storie di donne della sua terra. Donne di ’ndrangheta costrette a sposarsi bambine e a subire in silenzio violenze e soprusi. Madri, mogli, sorelle schiacciate da leggi arcaiche e retrive che fanno pagare il tradimento con la vita. Perché ancora oggi ci sono vittime di una brutalità antica che ha cambiato volto ma resta identica nella sua ferocia atavica: il delitto d’onore. Nel ventunesimo secolo esiste ancora. Come nel remoto Afghanistan dei telebani, anche in Calabria resiste il codice che punisce con la morte il tradimento femminile. La ’ndrangheta ignora la modernità, anzi la trasforma in una colpa. Ad Anna voglio raccontare soprattutto storie di donne che hanno trovato la forza di ribellarsi e denunciare padri, mariti e fratelli, minando dall’interno il loro mondo di prepotenza e omertà. Queste ragazze hanno acceso luci di speranza in nome della legalità e del diritto di scegliersi la vita, e molte altre stanno oggi seguendo la loro strada.
Mi piacerebbe che il loro coraggio aiutasse la piccola Anna a crescere orgogliosa di essere una fimmina calabrese.
![]()
2
Fimmine nel bunker
«Ma cosa aspetti ad andare a trovarlo? Vai, prima che ci vadano le altre!»
A pronunciare queste parole è il padre di Valentina R., preoccupato che la figlia si lasci sfuggire l’occasione d’oro della vita, e altre ne approfittino al posto suo. Valentina ha ventidue anni, è una bella ragazza, e probabilmente non ha alcuna voglia di assecondare il padre e accodarsi alla fila di quelle che si concedono notte dopo notte a uno dei più pericolosi boss della ’ndrangheta. Lui, il boss, è Francesco Pesce, detto Ciccio ’u Testuni, e vive da mesi sepolto in un bunker. È latitante, e impartisce ordini alla ’ndrina dei Pesce, che con quella dei Bellocco controlla la città di Rosarno. Ciccio ’u Testuni adora le donne, e tutti lo sanno. Dunque perché non approfittarne?
In questa fetta di Calabria dove la disoccupazione nel secondo trimestre del 2012 sfiorava il 20 per cento, conoscere l’uomo giusto può rivelarsi assai vantaggioso. Quando ho domandato ad alcuni abitanti di Rosarno perché un padre arrivi al punto di dare la figlia in pasto a un criminale, anziché ammonirla a stargli alla larga, mi hanno risposto: «Ma perché è un affare!». È un modo pure questo di fare investimenti, di piazzare un bene al miglior offerente: perché è così che questi padri considerano le proprie figlie, merce di scambio. Se poi la ragazza le sue carte le gioca bene e riesce a entrare nelle grazie del boss diventando la sua favorita ufficiale, il ritorno per la famiglia non si misura più solo in termini economici, ma anche di prestigio sociale.
Da quando hanno capito che farsi la guerra non è conveniente, le ’ndrine dei Pesce e dei Bellocco appianano tutte le beghe a parole anziché con le armi e si accordano quando c’è da spartirsi un affare. Soprattutto un appalto. A Rosarno, grazie al business, non scoppia una faida da tempo. E i clan fanno soldi a palate. Possiedono società, imprese, negozi intestati a devote figure di copertura, e liquidità di denaro per decine di milioni di euro. Gestiscono un fiorente traffico internazionale di droga, si aggiudicano appalti appetitosi come quelli per i lavori di ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. E controllano il porto di Gioia Tauro, costruito a partire dalla metà degli anni Settanta per servire quello che doveva decollare come il quinto polo siderurgico italiano e diventato poi, dopo il naufragio del progetto, terminal polifunzionale tra i primi del Mediterraneo. Il porto, snodo centrale del traffico di stupefacenti e di merci contraffatte, è un grande affare per i tre comuni che gli gravitano intorno: Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. E alimenta un indotto altrettanto lucroso: i container che arrivano sulle banchine vanno smistati, e poi trasportati coi camion. I clan mettono a disposizione uomini e mezzi e incassano milioni di euro.
dp n="19" folio="19" ? Ma non c’è solo il porto. I Pesce e i Bellocco tengono sotto il giogo l’intero sistema economico. Tutti a Rosarno pagano la guardiana, il pizzo o la mazzetta, se vogliono continuare a lavorare tranquilli, senza incidenti. E così devono fare i proprietari terrieri della Piana, frazionata in micro appezzamenti (i «giardini») coltivati soprattutto a kiwi e ad agrumi, se vogliono vendere quello che producono. Perché è la ’ndrangheta a controllare gli ortomercati, e se non sei in regola con i pagamenti la frutta la puoi lasciare a marcire sulle piante. Chiunque incassi dei soldi lavorando in proprio, a Rosarno, sa che una parte dovrà destinarla alle ’ndrine. Non sono esentati da questo balzello nemmeno i gestori dei circhi, che quando arrivano in paese sono costretti a comprarsi il diritto di alzare il tendone con blocchi corposi di biglietti ceduti gratuitamente ai membri dei clan e devono inoltre versare tangenti ogni giorno. Così alcune famiglie circensi hanno cancellato Rosarno dai loro itinerari.
Eppure, malgrado il loro criminale parassitismo, i clan godono del consenso di molti settori della società. Coi soldi che ricavano dalle attività illecite, infatti, creano lavoro dove il lavoro non c’è, e sono percepiti quasi come benefattori. Omertà e connivenza trovano spesso giustificazione nella convenienza, oltre che nella paura: meglio schierarsi con chi ti dà il pane che con uno Stato che ti promette sviluppo e benessere e poi latita e ti abbandona a te stesso. E sono sempre di più quelli che scelgono di affiliarsi, soprattutto a Rosarno.
Su quindicimila abitanti, gli affiliati formali alle cosche locali sono 250. Come spiega ai suoi compari il capocrimine della ’ndrangheta Mico Oppedisano, intercettato da microspie, ogni settimana se ne aggiungono tre o quattro nuovi. Se a questi 250 ’ndranghetisti si sommano gli amici, i parenti, i complici e i conoscenti, si arriva a 1500-2000 persone. Una porzione di tessuto cittadino capace di condizionare la vita non solo sul piano socioeconomico ma anche su quello politico, visto che questi individui godono tutti del diritto di voto. Il dato numerico ha dunque una forte valenza qualitativa. Neanche in Sicilia la mafia ha gioco così facile nel reclutare gli uomini: in tutta Palermo non ci sono tanti affiliati quanti a Rosarno. A Bagheria, per esempio, nel momento di massimo fulgore di Provenzano, gli affiliati a Cosa nostra noti erano non più di una cinquantina.
Le ’ndrine non possono prescindere dal vincolo con la terra d’origine, ma i loro traffici sono oggi di portata globale. Un investigatore da anni impegnato nella lotta alla ’ndrangheta mi ha raccontato come durante una perquisizione a una famiglia vicina ai Pesce titolare di uno stabilimento di frutta candita, siano state trovate fra le carte diverse commesse provenienti dalle più grandi aziende nazionali che producono panettoni, e poi fatture di albergo per settimane di permanenza in città del Nord, il che fa comprendere come il giro di affari delle cosche si faccia sempre più capillare ed esteso.
Il clan Bellocco si è ormai infiltrato nell’imprenditoria emiliana e lombarda, ma ha ramificazioni persino in Svizzera, Belgio e Lussemburgo. Individuano i settori più vitali dell’economia e allungano le mani per accaparrarseli. A Milano nel giro di pochi mesi si sono impadroniti di una florida società di call center, la Blue Call, dove erano entrati con una quota modesta. I titolari lombardi, Tommaso Veltri e Andrea Ruffino, pensavano di aver fatto un buon affare tirando dentro la loro azienda la ’ndrangheta. Intendevano convivere solo per breve tempo con quelli che nelle conversazioni telefonich...