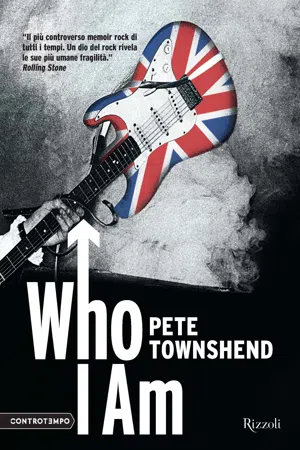![]()
Atto primo
La musica della guerra
You didn’t hear it.
You didn’t see it.
You won’t say nothing to no one.
Never tell a soul
What you know is the truth.
1921 (1969)
Don’t cry
Don’t raise your eye
It’s only teenage wasteland.
Baba O’Riley (1971)
And I’m sure – I’ll never know war.
I’ve Known No War (1983)
![]()
1
Io c’ero
Vederli ballare tutti insieme al suono dei miei assoli di chitarra, mentre lavoro di feedback, ha un che di straordinario, tra il magico e il surreale. In mezzo al pubblico, i ragazzi della mia stessa scuola d’arte stanno a testa alta tra i Mods dinoccolati, quell’esercito di adolescenti giunti da North e West London in sella ai loro strabilianti scooter, con i capelli corti e le scarpe di buona fattura, sotto l’effetto delle pastiglie di speed. Non so cosa passi nella mente degli altri membri del gruppo, Roger Daltrey, Keith Moon e John Entwistle. Sono d’indole solitaria, anche quando sono con la band, ma in questa sera del giugno 1964, al primo concerto degli Who al Railway Hotel di Harrow, nel West London, mi sento invincibile.
Suoniamo R&B: Smokestack Lightning, I’m a Man, Road Runner e altri classici dal suono heavy. Faccio ululare la Rickenbacker sfregandola su e giù lungo l’asta del microfono, poi commuto il selettore speciale che ho appena montato ed ecco che dalla chitarra paiono schizzare proiettili sonori verso quelli delle prime file. Scaglio con violenza lo strumento in alto e un tremendo brivido mi scuote quando il suo ruggito si trasforma in rumore di ferraglia. Alzo la testa giusto in tempo per vedere la paletta che si rompe mentre strappo la chitarra dal buco nel soffitto basso in cui, dopo il lancio, si era incastrata.
Decido tutto in quel preciso momento, in una frazione di secondo, e come un pazzo inizio a sbattere più volte contro il soffitto lo strumento danneggiato. Il taglio netto diventa un caos di schegge. Sollevo la chitarra per mostrarla alla folla trionfante. Non l’ho distrutta: l’ho scolpita, per loro. Con noncuranza la butto in frantumi per terra, imbraccio la nuova Rickenbacker a dodici corde e continuo il concerto.
Quel martedì sera mi sono confrontato con qualcosa di più potente delle parole, un’emozione più sconvolgente dei miei tentativi di suonare blues da ragazzo bianco. E come risposta ecco il saluto a piena voce della folla. Una settimana più tardi, nello stesso locale, non avevo più chitarre, così iniziai a rovesciare la pila di amplificatori Marshall. Per non restare nella mia ombra, Keith Moon prese a calci la batteria mentre Roger percuoteva il microfono contro i piatti crepati di Keith. Per qualcuno quella smania distruttiva era solo un espediente per fare spettacolo, ma io sentivo che il mondo stava cambiando, che stavamo trasmettendo un messaggio. Il solito modo di fare musica, ormai obsoleto, non sarebbe più stato lo stesso.
Mai avrei pensato a cosa sarebbe scaturito da quella prima volta in cui distrussi una chitarra, ma sapevo bene cosa mi aveva spinto a farlo. Da figlio di un clarinettista e sassofonista degli Squadronaires, il prototipo dell’orchestra di swing britannica, ero cresciuto amando la sua musica che avrei presto tradito per una nuova passione: il rock’n’roll, lo stile nato per distruggere lo swing.
Sono inglese. Sono un londinese. Sono nato nel West London mentre stava per finire la devastante Seconda guerra mondiale. Questi sono i tre elementi che mi hanno forgiato come artista professionista, proprio come l’oscurità della guerra aveva segnato la vita dei miei nonni e dei miei genitori. Sono cresciuto in un periodo su cui la guerra gettava ancora le sue ombre, benché in quei giorni i tempi cambiassero così rapidamente che era impossibile prevedere cosa sarebbe successo l’indomani. La guerra era stata una minaccia reale, un dato di fatto per tre generazioni della mia famiglia.
Nel 1945 la musica popolare aveva uno scopo serio: sfidare la depressione postbellica e rivitalizzare le aspettative piene di romanticismo e speranze di un popolo allo stremo. Tutta la mia infanzia fu intrisa del mistero e del fascino che percepivo lucidamente nella musica di mio padre. Per lui e per mamma la musica era tanto importante da sembrare il centro dell’universo. Ed ecco che tornammo a ridere e a essere ottimisti: la guerra era finita. Papà suonava un genere chiamato swing. Era ciò che la gente voleva ascoltare. E io c’ero.
![]()
2
È un maschio!
Sono appena nato, la guerra è finita, anche se non del tutto.
«È un maschio!» grida qualcuno da sotto la ribalta. Ma mio padre continua a suonare.
Sono un figlio della guerra pur non avendola mai conosciuta. Sono nato in una famiglia di musicisti, il 19 maggio 1945, due settimane dopo il Giorno della Vittoria in Europa e quattro mesi prima di quella Giornata della Vittoria sul Giappone che concluse la Seconda guerra mondiale. Intanto, a farmi agitare e scalciare quando ancora sono nel grembo di mia madre sono gli echi sincopati del conflitto, i clacson e i sassofoni, le big band e i rifugi antibombardamento, le V2 e i violini, i clarinetti e i Messerschmitt, le nenie alla Mood Indigo e le serenate alla Satin Doll, i lamenti, le bombe a grappolo e le sirene, gli scoppi e le esplosioni.
Due sono i ricordi che tornano sempre a visitarmi come quei sogni che, rimasti nella memoria al risveglio, non si dimenticano più.
Ho due anni e sto viaggiando al piano superiore di un vecchio tram preso insieme a mia mamma in cima al colle di Acton, un quartiere nella zona occidentale di Londra. Il tram passa lentamente davanti al mio futuro: il negozio di elettrodomestici in cui sarà messo in vendita il primo disco di papà nel 1955; la stazione di polizia in cui andrò a riprendermi la moto rubata; il negozio di ferramenta che mi affascina con le sue migliaia di cassetti perfettamente etichettati; il cinema Odeon in cui frequenterò le esagitate matinée del sabato con i miei amici; la chiesa di Santa Maria, dove fra qualche anno canterò inni anglicani nel coro e guarderò centinaia di persone ricevere la comunione senza che io lo faccia mai; il pub White Hart dove prenderò la mia prima vera sbronza nel 1962, dopo aver suonato in uno dei concerti settimanali in programma con il gruppo rock formato a scuola e che si chiama i Detours, quello che un giorno diventerà gli Who.
Adesso sono un po’ più grandicello, tre mesi fa ho compiuto due anni. È l’estate del 1947 e sono su una spiaggia, in pieno sole. Sono ancora troppo piccolo per andarmene in giro da solo e sto seduto su una coperta a godermi i profumi e i suoni: l’aria marina, la sabbia, la brezza leggera, le onde che mormorano sul bagnasciuga. I miei genitori cavalcano abili come arabi, spruzzando sabbia ovunque, mi fanno cenni allegri, poi ripartono al galoppo. Sono giovani, affascinanti, belli e quando li vedo scomparire lontano è come se mi sfuggisse dalle mani un inafferrabile Graal.
Il padre di mio padre, Horace Townshend, che tutti chiamavano Horry, era diventato calvo precocemente, a trent’anni, ma colpiva ancora con il suo profilo aquilino e gli occhiali dalla spessa montatura. Horry, musicista e compositore semiprofessionista, aveva scritto canzoni e si era esibito negli spettacoli estivi delle località balneari, nei parchi e nelle sale da concerto durante gli anni Venti. Abile flautista, sapeva leggere e scrivere la musica, ma gli piaceva la vita comoda e non guadagnò mai molto.
Horry aveva incontrato nonna Dorothy nel 1908. Erano entrambi artisti, lavoravano insieme e si sposarono due anni dopo, quando Dot era incinta di otto mesi del loro primo figlio, Jack. Zio Jack raccontava che una volta, quando lui era un bambino, i genitori stavano suonando per strada sul molo di Brighton, mentre lui li guardava da poco distante. Una signora dall’aspetto ricco si avvicinò, ammirò il loro impegno e gettò loro uno scellino nel cappello. «Per quale buona causa state raccogliendo offerte?» domandò la donna.
«Per la nostra» rispose Dot.
Dot era una donna attraente ed elegante. Cantante e ballerina, capace di leggere la musica, si esibiva alle feste, a volte insieme al marito, e in seguito aiutò Horry a scrivere le sue canzoni. Era allegra e ottimista, sebbene un po’ vanitosa e anche vagamente snob. Nel 1917, tra uno spettacolo e l’altro, Horry e Dot concepirono un compagno di giochi per zio Jack, Clifford Blandford Townshend, mio padre.
Mia madre trascorse i suoi primi anni con i genitori, Denny e Maurice, a Paddington. Benché ossessionata dalla pulizia, Denny non era una custode attenta dei suoi figli. Mamma la ricorda affacciata alla finestra del primo piano con in braccio il figlio minore, Maurice Junior, mentre salutava il marito che passava alla guida del furgoncino con cui consegnava il latte. Quella volta il piccolo quasi le sfuggì di mano.
Nonno Maurice era un uomo dolce e fu abbandonato in maniera crudele da Denny che, dopo undici anni di matrimonio, fuggì all’improvviso con un uomo ricco di cui era amante da tempo. Quel giorno mia mamma tornò a casa da scuola e trovò la casa vuota. Denny si era portata via tutti i mobili tranne un letto, lasciando solo un biglietto senza indirizzo. Ci vollero diversi anni perché Maurice rintracciasse la fuggiasca, ma i due non giunsero mai a una riconciliazione.
Maurice, con i due bambini, andò a vivere da sua madre, Ellen. Mia mamma, che allora aveva solo dieci anni, aiutava nella faccende domestiche e finì subito sotto l’influenza della nonna irlandese. Si vergognava di Denny che l’aveva abbandonata, ma era orgogliosa di nonna Ellen che le insegnava a modulare la voce per far spiccare l’accento irlandese. Mamma era capace di imitare gli accenti più diversi e sin da piccola mostrò attitudine per la musica.
Alla fine, da adolescente, mamma andò a vivere con la zia materna Rose nella parte settentrionale di Londra. Ricordo Rose come una donna straordinaria, sicura di sé, intelligente, colta. Era lesbica e viveva tranquillamente, senza nascondere nulla, con la sua compagna.
Papà era un adolescente ribelle, proprio come me. Prima della guerra, lui e il suo migliore amico erano membri delle Blackshirts, le camicie nere fasciste di Oswald Mosley. Naturalmente in seguito si vergognò di quell’esperienza, ma si giustificava dicendo che era giovane e che le uniformi gli erano apparse molto eleganti. Invece di dedicarsi agli studi per clarinetto di Prokofiev, su cui comunque passava due ore ogni mattina con ottimi risultati, a sedici anni preferiva suonare ai bottle party, quelle feste tipicamente inglesi in cui ogni invitato porta da bere. Vista la sua abilità, affrontare simili concertini era per lui una passeggiata. Per tutta la vita papà ha sempre avuto qualità maggiori rispetto a quelle richieste dalla musica che suonava.
Nel giro di pochi anni iniziò a esibirsi in giro per Londra con Billy Wiltshire e la sua Piccadilly Band, suonando nei dancing o facendo il cosiddetto bar-stooling, cioè creando dei sottofondi musicali nei bar. Nell’intervallo tra le due guerre mondiali la raffinatezza, l’eleganza e la spensieratezza erano un paravento alla grande paura di scomparire dalla faccia della Terra. I temi più pressanti erano nascosti dietro nuvole di fumo di sigaretta e di nuova musica popolare. Come sempre, il sesso era l’ingrediente capace di placare i cuori agitati. Eppure, nella musica dell’epoca di mio padre, l’energia sessuale era implicita e non esibita, celata dietro l’eleganza curata di uomini e donne in abito da sera.
Furono la guerra e la musica a far incontrare i miei genitori. Papà si era arruolato nella RAF nel 1940 e tra le varie funzioni aveva quella di suonare sassofono e clarinetto in piccoli gruppi per intrattenere i commilitoni. Nel 1945 si esibiva con la RAF Dance Orchestra, una delle più grandi di tutto l’esercito. Formata da militari di truppa già appartenenti a celebri band e diretta dal sergente Leslie Douglas, veniva definita come la più importante orchestra da ballo che la Gran Bretagna avesse mai prodotto. A suo modo è stata rivoluzionaria. Il suo asso nella manica era lo swing, genere che ai tempi non era ancora pienamente accettato dalla buona società, ma che alla gente comune piaceva molto. Papà si era assicurato l’incarico perché il marito della celebre cantante inglese Vera Lynn, il sassofonista Harry Lewis, pur facendo parte dell’aviazione, aveva paura di volare e non voleva andare in Germania. E quando il messaggero motorizzato gridò la notizia della mia nascita da sotto la ribalta, papà era proprio in Germania, impegnato a suonare il sassofono per le truppe.
Mamma aveva falsificato l’età per arruolarsi nel 1941. Dotata di una bella voce, era entrata a far parte della band di papà come cantante. Nel programma per il concerto del 18 giugno 1944 a Colston Hall, Bristol, si legge: Star Eyes, All My Life (un duetto con il bel sergente Douglas) e Do I Worry. Papà appare come solista in Clarinet Rhapsody e Hot and Anxious. Secondo una nota di copertina, la RAF Dance Orchestra stava indicando al pubblico la nuova strada intrapresa dalla musica: «Dalle melensaggini alla musica sincopata, ritmo flessibile e più spazio ai solisti per esprimersi».
Quando la guerra finì, l’orchestra decise di continuare con il suo nome ormai popolare: gli Squadronaires.
Secondo quanto mi raccontava, mamma trascorse i primi anni di matrimonio in solitudine. «Non vedevo mai papà. Non c’era mai. E quando era a casa passava più tempo in quel maledetto White Lion o al Granville.» Allegro, di bell’aspetto e sempre pronto a pagare un giro di birre, papà era popolare nei pub locali, dove il suo successo musicale lo faceva apparire una specie di celebrità.
La solitudine in cui visse mia mamma può spiegare la sua rabbia verso mio padre, assente al momento della mia nascita. Mamma, che viveva con i suoceri, sfogò il proprio risentimento cambiando casa. Conosceva una coppia di ebrei, Sammy e Leah Sharp, musicisti di origine australiana che vivevano con il figlio in una grande stanza, e così noi due ci trasferimmo da loro. Leah mi prese sotto la sua protezione. Io non me la ricordo, ma mamma la descriveva come «una di quelle persone che amavano fare il bagnetto, spingere la carrozzina e cose simili». Mamma, meno portata verso le «cose simili», e ancora impegnata con il lavoro di cantante, le era grata per l’aiuto.
Nel 1946 i miei genitori si riconciliarono e tutti e tre ci spostammo in una casa di Whitehall Gardens, ad Acton. Tra i nostri vicini di casa c’erano il grande pianista jazz cieco George Shearing e il fumettista Alex Graham, il cui studio, con gli ampi tavoli da disegno regolabili, i mucchi di fogli di carta, gli inchiostri e le penne complicate, mi affascinava ed è stato fondamentale nella mia scelta di frequentare poi la scuola d’arte.
Condividevamo la casa con i Cass, che vivevano al piano di sopra e che, come molti dei più stretti amici dei miei genitori, erano ebrei. Ricordo le Pesach gioiose e casiniste, con un sacco di gefilte fish, fegato tritato e punta di vitello fatta arrostire lentamente. Ogni famiglia aveva tre stanze, una cucina e un bagno, ma senza il wc all’interno. Il nostro era nel cortile sul retro e la carta igienica si riduceva ad alcuni pezzi di giornale appesi a un chiodo. Tra freddo e ragni, le mie puntate in quel posto non duravano mai a lungo.
Dormivo in sala da pranzo. I miei genitori sembravano non comprendere la mia necessità di avere un posto tutto per me, dove avrei potuto lasciare in giro i giocattoli o i disegni senza sentirmi come un invasore del territorio degli adulti. Non avevo alcun senso della privacy, nemmeno pensavo di meritarmi una mia intimità.
Mamma rinunciò a cantare, cosa di cui poi si pentì, però ha sempre lavorato. Aiutava nella gestione degli Squadronaires dal loro ufficio in Piccadilly Circus e spesso mi portava con sé in trasferta, sul pullman dei musicisti, dove mi beavo dell’atteggiamento disinvolto degli orchestrali e mettevo in ordine le bottiglie di birra vuote. I nostri viaggi finivano sempre in piccoli alberghi sul mare, in quelle strutture chiamate holiday camps o in un teatro pieno di decorazioni, scale segrete e corridoi sotterranei.
Charlie, che gestiva l’orchestra in questi viaggi, era il bersaglio di molti scherzi, ma era chiaro che gli Squadronaires gli erano affezionati. Il controllo che i miei genitori avevano su di me nella vita quotidiana svaniva un po’ quando eravamo in mezzo all’orchestra, che assomigliava a un gruppo di ragazzi in gita scolastica. Mamma era la bella cantante fissa e il talento musicale di papà le dava uno status speciale tra i colleghi. Papà si è sempre esercitato almeno un’ora ogni mattina su scale e arpeggi e questa pratica mi pareva un complesso rituale magico. Oggi nel mondo del rock, dove usiamo un linguaggio più diretto, diremmo che papà era uno «giusto».
Gli holiday camps erano strutture tipicamente britanniche, meta per i membri della classe operaia che vi passavano una settimana estiva di baldoria e che spesso includevano balli con orchestre come gli Squadronaires. La disposizione prevedeva un bungalow per famiglia e non sembrava favorire i rapporti sessuali clandestini. Ma se in una di queste capanne, invece di una famiglia, mettete un gruppetto di giovanotti e in un’altra un gruppetto di signorine, è facile comprendere cosa può succedere.
Negli holiday camps si respirava un’aria di uguaglianza, eppure io mi sentivo sempre un po’ superiore alla gente comune che cambiava a ogni settimana. In fondo io ero parte del gruppo orchestrale e restavo lì per tutta l’estate, a volte anche quattro mesi. Stando dietro il sipario scoprii i trucchi che servono per catturare l’attenzione dei vacanzieri. Sono cresciuto imparando come si fa divertire il pubblico, vedendo da vicino quale prezzo a volte si paga per ottenere un po’ di attenzione. C’era una gag per far ridere la gente del campo: ogni pomeriggio alle due papà veniva spinto in piscina dal trampolino più alto, completamente vestito nella sua uniforme da orchestrale. Uscendo dall’acqua, non smetteva di suonare il suo vecchio clarinetto e fingeva un’aria triste, sconfitta. Ero un bambino e prendevo troppo a cuore quella scena. Mio padre, così brillante, si fa umiliare perché voi, plebe in vacanza, possiate farvi una risata.
Iniziai a stare alla larga da quella gente comune, da quei clienti che, pagando, ci fornivano indirettamente quanto a noi serviva per vivere. Ancora oggi quando vado a un concerto in cui non sono sul palco mi sento sempre un po’ smarrito. E penso sempre a mio padre.
Nel settembre 1949, all’età di quattro anni, fui iscritto all’asilo Silverdale di Birch Grove, ad Acton. Probabilmente mamma lo scelse perché gli ero sembrato carino nell’uniforme dell’asilo: giacca rossa e cappello. La mamma aveva un’eleganza naturale e quando, dopo la guerra, cessò il razionamento degli abiti, iniziò ad abbigliarsi come una star di Hollywood. I suoi suoceri non vedevano di buon occhio quell’abitudine. Perché buttava via i soldi che papà si sudava comprando vestiti e mandandomi in un asilo privato, quando avrebbe potuto tenermi a casa con lei?
Io però ero felice. Whitehall Gardens si tro...