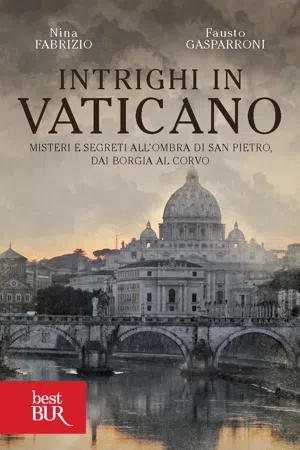![]()
Il Vaticano e le dittature
![]()
«L’irremovibile» cardinale Mindszenty
Il cardinale József Mindszenty, primate d’Ungheria che si schierò al fianco dei ribelli nella Rivoluzione ungherese del 1956, fu una figura eroica della resistenza cattolica contro i regimi comunisti legati all’Impero sovietico. Rappresentò, tuttavia, anche un grosso ostacolo alla politica di conciliazione con Mosca portata avanti dal Vaticano. Per questo la sua personalità, fuori e dentro la Chiesa, è sempre rimasta sospesa tra il giudizio di chi ne ha esaltato l’indomita fierezza e quello di chi ne ha sottolineato l’inflessibile ostinazione.
Strenuo oppositore del comunismo, dopo aver avversato ben tre regimi, Mindszenty, nel 1971, fu al centro di un caso diplomatico che mise in forte imbarazzo il governo ungherese, la Santa Sede e gli Stati Uniti, nella cui sede diplomatica di Budapest il cardinale si era rifugiato dal 1956.
A quel tempo, la politica di distensione nei confronti dei regimi comunisti dell’Est Europa di Paolo VI, chiamata «Ostpolitik,» imponeva di non cercare lo scontro frontale con i governi controllati da Mosca che applicavano forti restrizioni alla libertà religiosa. Una linea, di cui fu protagonista il futuro segretario di Stato Agostino Casaroli, non condivisa da tutti all’interno delle Mura Leonine e osteggiata soprattutto da alcuni vescovi locali dei Paesi sottoposti all’influenza russa che la ritenevano controproducente. Di questi, «l’irremovibile» Mindszenty fu quello che maggiormente si oppose al potere centrale del Vaticano.1 La vicenda della sua permanenza nella sede diplomatica statunitense, dove ricevette asilo, fu all’origine di un lungo braccio di ferro tra il primate ungherese e Paolo VI – sostenitore della soluzione dell’esilio del porporato – che non impedì però a papa Montini di scrivere a Mindszenty, nel 1974, una lettera colma di affetto in cui gli riconosceva di aver portato «la corona di spine» come Gesù.2 Tuttavia, quando il fiero cardinale morì, un anno dopo, nell’elogio funebre il Pontefice fautore della linea di apertura verso l’Impero sovietico affermò che la «storia» avrebbe saputo dare su di lui «un giudizio più pienamente equilibrato e oggettivo» e «alla sua figura il posto che gli spetta».3
Mindszenty, nato József Pehm, fu sgradito a quasi tutti i regimi politici ungheresi che si succedettero al potere dopo il crollo dell’Impero austro-ungarico, alla fine della Grande Guerra.4 Fu arrestato una prima volta agli inizi del 1919, quando era un giovane sacerdote ordinato da appena quattro anni e si era già distinto per le sue roventi omelie contro la politica laica del breve governo di Mihály Károlyi, simpatizzante del socialismo; rimase in carcere anche con il successivo regime comunista di Béla Kun, durato appena 133 giorni. Nominato vescovo, Mindszenty tornò in prigione nel novembre 1944, sotto il governo filonazista e antisemita delle «Croci frecciate». Liberato nell’aprile 1945, dopo la conquista sovietica della città, divenne nel 1946 arcivescovo di Esztergom, primate d’Ungheria e cardinale. Ma la libertà per lui durò appena due anni.
Nel 1948 fu arrestato e trascinato in giudizio dal nuovo regime. In un processo-farsa fu riconosciuto colpevole di avere complottato con gli Stati Uniti, congiurato con gli Asburgo, sabotato la riforma agraria e trafficato in valuta straniera. Mindszenty venne sottoposto a interrogatori umilianti e brutali e infine condannato all’ergastolo. Il Vaticano apprese l’accaduto con profondo sgomento e Pio XII scomunicò chiunque avesse preso parte, in qualunque forma, al processo. Il cardinale rimase tuttavia in carcere fino all’ottobre del ’56, quando scoppiò la rivoluzione a Budapest. Gli insorti liberarono il primate che rientrò trionfalmente nella capitale ungherese accolto da una grande folla. Appoggiò quindi, in funzione antisovietica, il governo di Imre Nagy, il leader comunista schieratosi al fianco dei ribelli, anche se, in base ad alcune ricostruzioni recenti, non mancava nell’amministrazione americana di Eisenhower, specialmente in ambienti della Cia, chi lo riteneva l’uomo adatto ad assumere la guida del Paese in quelle circostanze tumultuose.5
Di nuovo, la libertà per Mindszenty durò poco. Il 4 novembre i carri armati sovietici entrarono a Budapest occupando la città e riaffermando il potere di stampo sovietico. Nagy consigliò a Mindszenty di rifugiarsi in un luogo sicuro. Il cardinale, dopo aver constatato in Parlamento che la situazione stava precipitando, trovò asilo nell’ambasciata degli Stati Uniti, trasformandola per quasi quindici anni in una prigionia volontaria. Il primate, non volendo lasciare la sua patria, non riteneva di dover obbedire a Paolo VI che gli ordinava di abbandonare l’Ungheria, ormai deciso a tentare una linea di distensione con i regimi dell’Est per consentire alla Chiesa locale un più sereno modus vivendi e anche nella speranza di poter andare in pellegrinaggio al monastero di Jasna Góra, in Polonia. Ma l’impresa non andò a buon fine e l’unico Papa che riuscirà a recarsi al monastero sarà Giovanni Paolo II nel giugno 1979.
Sul rigido cardinale, monsignor Casaroli confidò: «Mindszenty crede di vivere nel tempo in cui il primate della Chiesa magiara assumeva il potere in caso di assenza del monarca».6
Mindszenty, sempre più d’impaccio alla diplomazia vaticana, al governo ungherese e agli stessi padroni di casa statunitensi, a loro volta interessati a non acuire le tensioni con Mosca, resistette nell’ambasciata americana fino al 1971. Alla fine, dopo le molte «fraterne insistenze» di Paolo VI, accettò il lasciapassare che Budapest era disposto a concedergli.7 Ma quando accolse l’esilio, fissando la sua residenza a Vienna, tentò per alcuni mesi almeno di conservare la carica di primate di Ungheria respingendo gli «inviti» del Papa a rinunciarvi.
Si spense il 6 maggio 1975, a 83 anni, nella capitale austriaca. Il giorno dopo, in un discorso in sua memoria, Paolo VI lo ricorderà per «l’ardente fede», non meno che per il suo carattere «irremovibile in ciò che gli appariva dovere e diritto».
![]()
«Operazione Rabat»: Hitler e il rapimento di Pio XII
Nei drammatici giorni della Seconda guerra mondiale, in particolare dopo il tradimento di Badoglio, di cui Hitler considerava complice la Chiesa, circolava in Vaticano il terrore che il Führer volesse invadere il piccolo Stato, sede neutrale del Papa, e persino rapire Pio XII, Eugenio Maria Pacelli. Se sui timori di un’occupazione da parte delle truppe naziste non ci sono dubbi (a un certo punto il Papa fece addirittura nascondere le sue carte personali nei doppi pavimenti vicini ai suoi appartamenti privati per sottrarle a una possibile requisizione tedesca),1 a lungo è rimasto un mistero il progetto, o meglio, i progetti che Hitler avrebbe preso in considerazione o addirittura elaborato personalmente per deportare Pio XII. Alcuni storici ritengono questi piani reali, altri meno, ma il giallo rimane. Alimentato dal fatto che il Papa preparò una lettera di dimissioni in caso di cattura da parte dei nazisti, dando istruzioni di tenere l’eventuale conclave a Lisbona.
L’intenzione segreta di rapire il «Pastore angelico» è stata rivelata dal generale delle SS Karl Wolff in una deposizione rilasciata al processo di beatificazione di Pacelli, il 9 aprile 1974, nel tribunale arcivescovile di Monaco di Baviera, in seguito contestata per mancanza di riscontri. Wolff affermò di essere stato incaricato, il 13 settembre 1943, direttamente dal Führer, dell’ambizioso e potenzialmente dirompente «Piano vaticano»: occupare nel minor tempo possibile la Città del Vaticano, asportare e mettere al sicuro i tesori artistici e gli archivi, trasferire il Papa in Germania o nel neutrale Liechtenstein. Un progetto rimasto lettera morta anche per il celato ostruzionismo dello stesso Wolff che lo riteneva folle.
Solo recentemente, invece, sono venuti alla luce i particolari dell’«Operazione Rabat,» un piano altrettanto ardito, quasi la trama di un film di fantastoria, partorito, nel 1944, dalla mente delirante del nazista belga Léon Degrelle, feroce antisemita, che non solo voleva rapire Pio XII, ma anche costringerlo a firmare un’enciclica antigiudaica.2
La storia dell’«Operazione Rabat» riaffiora da documenti e testimonianze messi insieme da Frédéric Rossif, regista franco-montenegrino che aveva partecipato alla Liberazione di Roma e che, a metà degli anni Ottanta, intendeva girare un documentario sulla vicenda ancora in gran parte sconosciuta. Protagonista è il belga Degrelle. Leader di un partito conservatore, Christus Rex, che si ispirava al nazionalsocialismo, Degrelle esercitava un forte fascino sul Führer che non seppe dirgli di no quando l’uomo, nei primi mesi del 1944, mise a punto il progetto che prevedeva di rapire Pio XII, portarlo in Germania e imporgli la firma di una lettera enciclica che, condannando il giudaismo, avallasse l’ideologia nazionalsocialista.
Il piano era stato studiato nei minimi dettagli, una vera messinscena in due fasi. Travestiti da agenti sionisti in combutta con i partigiani comunisti italiani, un gruppo di soldati delle SS sarebbe dovuto penetrare di notte in Vaticano e sequestrare papa Pacelli. Poi sarebbe entrata in azione la Wehrmacht, le forze armate tedesche, fingendo di sventare il rapimento e di salvare il Papa, prendendolo a propria volta in custodia per proteggerlo da ulteriori pericoli. Una volta in Germania, Pio XII sarebbe stato forzato con tutti i mezzi, anche quelli più violenti, ad apporre la sua firma indelebile sul documento consacratore del nazismo.
Hitler si appassionò al progetto incaricando dell’esecuzione, oltre Karl Wolff, il generale Wilhelm Burgdorf, non fidandosi del tutto di nessuno dei due. I sospetti di Hitler erano fondati. Wolff, infatti, in un colloquio confidenziale avvenuto la notte del 10 maggio 1944 informò di persona Pio XII; il piano però andò avanti sotto le direttive di Burgdorf, fedelissimo del Führer. I finti rapitori dovevano essere credibili nei loro ruoli, evitando di tradirsi con linguaggi e gesti incongruenti. Per questo motivo, i nazisti travestiti da agenti sionisti furono scelti tra le SS ucraine in modo da passare per ebrei provenienti da Odessa.
I finti partigiani italiani furono invece addestrati dal generale Enea Navarrini dei reparti speciali della Rsi, esperti di controguerriglia. Venne quindi reclutato in gran segreto un commando scelto e le esercitazioni si svolsero nel castello di Bracciano, dove destarono i sospetti della famiglia Orsini, proprietaria della tenuta. All’interno del castello, infatti...