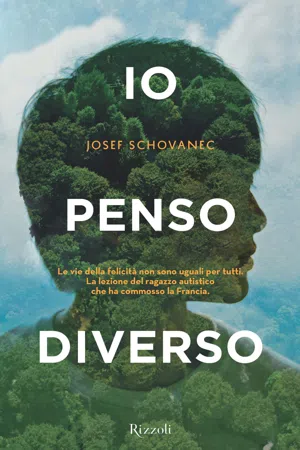![]()
1
L’infanzia
In certe culture antiche, come quella degli Inuit, era diffuso un genere letterario a prima vista assai strano: i ricordi della nascita, cioè della vita intrauterina. Rammenterò a lungo l’effetto che mi procurò, in occasione di un simposio, l’incontro imprevisto con una delle maggiori autorità in materia, Bernard Saladin d’Anglure, che riuscì a raccogliere queste memorie nel Nunavik* poco prima che cadessero nell’oblio. Personalmente, non ho serbato alcun ricordo affidabile e distinto di quei primi tempi… Qualche immagine, forse, ma come essere certi della loro autenticità? Mia sorella, più fortunata, ricorda alcuni istanti della sua più tenera infanzia. Il suo fratellino, meno precoce, non sa cosa raccontare.
La maggior parte dei miei vecchi ricordi è legata a paesaggi svizzeri. Pochissime facce o persone, e solo per la loro figura, laddove aveva dei tratti facilmente identificabili. La Svizzera comparirà senz’altro a più riprese in queste pagine. Non sono cittadino elvetico, né titolare di un conto bancario da quelle parti. Semplicemente, le lunghe vacanze trascorse sulle Alpi della Svizzera tedesca hanno plasmato la mia infanzia, e non potrei mai dimenticarle.
Parlare, camminare: primi anni
Si racconta che, all’ingresso di molti monasteri buddisti, al postulante viene chiesto prima di tutto se sia un essere umano o uno spirito. Nella cultura occidentale il criterio di umanità varia, ma sembra ci sia un consenso unanime attorno alle abilità linguistiche. Nel test di Turing, che per il momento nessun computer ha superato, l’operatore dev’essere incapace di distinguere, in una conversazione, quale dei suoi interlocutori è umano e quale invece una macchina. Un criterio in apparenza molto sensato. Supponiamo, però, che io sia stato, su questo punto, ancora più cocciuto del solito, o che i fattori di rischio ambientale l’abbiano deciso per me… per farla breve, non ho parlato per diversi anni. Posso essere considerato umano? Una profezia che si autoavvera, notate bene, perché un bambino giudicato inabile alla parola non beneficerà spesso del suo insegnamento, finendo così per diventarlo davvero.
Io ho avuto la fortuna di imparare a parlare, bene o male. Non so dire in che momento ho cominciato. Il progressivo miglioramento del mio eloquio è stato relativamente complicato per molto tempo – e lo è tutt’ora, diranno le malelingue come la mia. Verso i sei o sette anni, una cerchia familiare ristretta – i miei genitori e mia sorella – era in grado di comprendere quello che dicevo, ma gli altri facevano parecchia fatica; ricordo ancora scene in cui la persona mi faceva ripetere più volte la frase, prima di girarsi verso i miei genitori per l’«interpretazione».
Prima di pretendere alcunché da un bambino, bisogna intendersi sul significato di «parlare». Si vuole che emetta dei suoni come fanno gli adulti? Come fanno, o si presume che facciano, i suoi coetanei? Che capisca determinate cose? Se sì, quali? Questi interrogativi sono tutt’altro che oziosi. Un bimbo capace di leggere documenti medievali in latino e di commentarli per iscritto, pur non sapendo parlare, è un ritardato mentale? E se il medesimo bambino non fosse mai stato messo di fronte a un documento medievale in latino? Ci avviamo pian piano verso la questione che assilla l’istruzione scolastica: se un alunno non sa giocare al cerchio né allacciarsi le scarpe, ma lo appassiona il calcolo differenziale, ha le competenze per essere ammesso alla classe successiva della scuola materna? È «entrato negli apprendimenti», come si usa dire in Francia, sottintendendo quelli della maestra?
Non ho sicuramente avuto un profilo atipico quanto quello di certi bambini autistici. Eppure, avevo le mie specificità, per dirla in maniera diplomatica. Cose di cui oggi si può sorridere, e che tuttavia all’epoca rappresentavano dei piccoli drammi. Ai miei disturbi del linguaggio si aggiungevano altri problemi. Quando aprivo bocca, raccontavo cose che, anche con una dizione perfetta, molti interlocutori non avrebbero probabilmente compreso. Elenchi di nomi di stelle, per esempio. Supponiamo che siate uno psicologo e che vi portino in studio un bambino autistico che esordisce con queste parole: «Alnitak, Alnilam, Mintaka». Ne concluderete che si tratta di una qualche forma di psicosi infantile? Di autismo che compromette qualunque comunicazione umana? Oppure riconoscerete i nomi di tre stelle della cintura di Orione e intavolerete una discussione in materia? È una situazione che ho vissuto, non con uno psicologo, ma con altre persone. E che dire di quella signora, amica di famiglia, con la quale mi ero ritrovato solo per qualche istante, e a cui avevo domandato in ceco per quali ragioni la Francia non era tornata a essere una monarchia? Dopo le inevitabili ripetizioni affinché potesse comprendere il mio balbettio, era rimasta in silenzio. Non ci si imbarca in conversazioni simili con dei bambini che a malapena camminano. Un altro ricordo analogo: i miei genitori, di origine ceca, partecipavano regolarmente agli incontri della minuscola comunità presente a Parigi, durante i quali io mi lanciavo in «dissertazioni» su ciò che mi interessava, vale a dire l’astronomia, la grande passione a cui ho consacrato tanto del mio tempo a partire dai sette, otto anni di età. I presenti erano forse divertiti nel vedere un ragazzino alto come un soldo di cacio che parlava loro delle particolarità di questa o quell’altra stella; più verosimilmente, non gli prestavano la minima attenzione, pensando di avere a che fare con un bambino un po’ agitato. Magari uno psichiatra, assistendo alla scena, mi avrebbe offerto delle molecole in grado di aiutarmi di fronte a questa psicosi interstellare. All’epoca, però, ero pressoché inadatto al discorso sociale, quello che crea i legami e che – cosa fondamentale – fa passare il suo autore per un essere umano sano di mente.
Credo che scrivere sia più facile che parlare. La sincronizzazione dei movimenti è meno ardua. Potete rallentare e fermarvi, se lo desiderate. E ciò anche prima dell’avvento di quegli aggeggi dove basta premere un tasto. Sarà per questo che, al pari di altri bambini autistici, sapevo leggere e scrivere prima di saper parlare «come si deve»? Lo ignoro. Per ora, non ho ancora letto degli studi sull’argomento.
Non sono in grado di dire quando e come ho imparato a leggere e a scrivere. Non resta che qualche riferimento temporale. Per il mio secondo compleanno, o per Natale, nel dicembre del 1983, i miei genitori avevano ricevuto un pacco. Alcuni amici avevano spedito a me e a mia sorella dei doni, tra i quali diversi camion, che di solito si regalano ai maschietti, e una specie di piccolo peluche adatto ai bimbi piccoli. Conserviamo ancora, negli archivi di famiglia, un mio disegno – certamente assai rudimentale, ma non meno evoluto degli scarabocchi di cui sono capace oggi – di quel bambolotto di peluche, su cui avevo segnato la data di «nascita» (arrivo) e qualche altra parola. In caratteri maiuscoli e capovolgendo certe lettere, per esempio una «A», che era finita a testa in giù. Detto per inciso, mi riesce alquanto difficile distinguere la destra e la sinistra, così come l’est e l’ovest; credo di avere una vaga idea della carta dell’Europa, e se mi chiedete di citare un Paese a ovest della Germania, otterrete come risposta un silenzio imbarazzato di parecchi secondi, il tempo che mi serve per raffigurarmi correttamente la posizione dell’est sulla cartina.
Sul retro dello stesso disegno, un’altra particolarità di quello che avevo scritto: «Per i bambini piccoli – Scrivi il tuo nome». Poi avevo aggiunto «Schovanec», il mio cognome. Di solito, i bambini di due anni non si autodesignano con il loro cognome, ma con il nome di battesimo, o addirittura con uno pseudonimo, un soprannome.
Il mio apprendimento si è dunque compiuto tramite la lettura e la scrittura. E finora per me è sempre stato più agevole accedere a un testo quando è in forma scritta, anziché orale. Lo stesso se devo produrre un elaborato: mi risulta molto più semplice scriverlo, batterlo al computer, che pronunciarlo. Non posso quindi che nutrire un certo affetto per il progetto di «grammatologia» di Derrida, una scienza della scrittura proprio come la linguistica pretende di essere una scienza della lingua parlata.
Ciò nonostante, nello scritto e nel parlato, non è il semplice gesto che conta. Dietro ogni intervento verbale, più forti delle parole sono le aspettative sociali. Quanto alcune domande o richieste sono abbastanza precise («Qual è la lunghezza in centimetri del segmento AB?»), tanto altre sono vaghe, con un significato non codificato in parole. Se qualcuno urla il vostro nome, che cosa fate? Non vi ha chiesto di voltarvi. E forse non ha chiamato voi, poiché, con grande orrore di tanti bambini autistici, persone diverse possono avere lo stesso nome; è per questo che, a volte, alcuni identificano la gente grazie alla targa dell’auto o al numero della previdenza sociale. Non bisogna ridurre le persone a dei numeri, si dice; ma ridurle a un nome non è di per sé più lusinghiero. Nella mia primissima infanzia, una volta, in Svizzera, i miei genitori hanno vissuto un momento traumatico: mi ero perso. In realtà, mi trovavo in un cespuglio proprio davanti a loro. Ma avevano omesso di chiedermi di cacciare un urlo quando gridavano il mio nome…
Iniziare a camminare è stato altrettanto complicato. Ho imparato a farlo tardi, per la disperazione dei miei genitori, che cercavano di tenermi per le braccine mentre io non facevo che dimenare le gambette in aria. E senza la sincronizzazione dei movimenti la cosa non funzionava. Le diapositive di famiglia sono piene di queste scene. Ancora oggi, cammino in modo bizzarro. Sembri danzare, diceva una mia compagna di classe, tentando di mostrarsi gentile. Ciò che non aveva mai visto è che ogni tanto, da solo in un corridoio o su una scala, mi faccio sopraffare dalla mia antica passione: camminare con le braccia alzate – si dice «in aria», credo – e lasciarle così, qualunque cosa accada.
Oggi, discorrendo con i genitori di un bambino con autismo, mi rendo conto del loro sconforto: non cammina. O cammina male, o ha un’andatura che non è giudicata corretta. Non più tardi di stamattina ero con una mamma il cui figlio cominciava sì a muovere i primi passi, ma in maniera troppo impacciata per la sua età. E quindi cadeva spesso, alla minima asperità del terreno, come capita a certe persone molto anziane.
Gaffe di vita scolastica
Alcune domande, temo, non avranno mai risposta. Le ragioni profonde della necessità di frequentare la scuola rientrano in questa categoria. C’è la risposta ufficiale, cioè che si va a scuola per imparare quello che dice la maestra o il maestro. C’è la risposta foucaultiana, che evoca la disciplina dei corpi. E quella della Chiesa, in qualche modo legata alla precedente, che fa riferimento alla virtù. Da parte mia, ho preso in considerazione innanzi tutto l’arbitrio dell’obbligo scolastico. D’altronde, paradossalmente, è per questo che apprezzavo la scuola, malgrado tutti i suoi difetti. Oggi, credo che sia davvero un luogo di apprendimenti necessari: solo che non sono sempre quelli che il programma esplicitamente prevede.
A più riprese hanno proposto che mi ritirassi dalla scuola o che almeno ripetessi l’anno. Il soggetto di quell’«hanno» è qui deliberatamente indeterminato. Non credo che ci fosse una sorta di «grande Satana» che lottasse per il mio fallimento, piuttosto delle persone, peraltro assolutamente stimabili, convinte della fondatezza della loro posizione, o che allora seguivano le non meno legittime direttive di altre persone dotate di autorità. Molti genitori hanno di continuo l’impressione di combattere contro un blocco onnipresente ma invisibile, come se ogni tappa del percorso scolastico dei loro figli si trasformasse in un nemico sornione.
Il mio primo contatto con la scuola è stato l’anno di grande section,* che frequentavo solo part-time, la mattina. Andarci di pomeriggio era impossibile, al di là delle mie capacità. Ricordo benissimo il colloquio con la direttrice, durante il quale, naturalmente, non avevo capito nulla; solo più tardi i miei genitori mi avevano spiegato che si era mostrata riluttante al compromesso proposto, anche se poi aveva accettato. Alla fine della grande section, tutti, a cominciare dalla maestra, volevano che ripetessi l’anno, perché non avevo affatto le competenze richieste per passare in prima elementare. A posteriori mi dico che se avessero aspettato che le acquisissi, forse sarei ancora all’asilo! Possiamo saper leggere e scrivere, appassionarci alle diverse specie di muffe e non essere capaci di giocare al cerchio con i compagni. Il problema è che, nella scuola materna, i bambini vengono valutati in base ad attitudini che sono tra le più complesse per i soggetti autistici. Spesso, poi, tali attitudini esercitano su di loro una scarsa attrattiva: la principale differenza tra gli integrali tripli e il karaoke non sta nel fatto che ambedue sono difficili, ma nell’interesse che molti giovani autistici nutrono per i primi, non cogliendo la necessità di lottare per godere del secondo. Questo non vuol dire – ci torneremo sopra – che le persone con autismo non cerchino il contatto, al contrario; il piacere che si trae dalle urla e dai gesti concitati dei bambini nel cortile della ricreazione può, però, risultare incomprensibile per loro.
Sul piano sociale, io ero solo. Avevo paura degli altri bambini… e, ahimè, avevo ragione, o quantomeno avevo le mie buone ragioni. La paura era qualcosa di razionale e ragionevole. Tutti i santi giorni prendevo la mia dose di botte. Certi giochi di gruppo ruotavano espressamente attorno ai modi più appropriati per sfogarsi su di me. Non bisogna credere che il fenomeno delle violenze scolastiche esista soltanto nei cattivi istituti: io frequentavo scuole di piccole dimensioni, giudicate buone, se non addirittura ottime. All’epoca, i sorveglianti non erano così reattivi da vigilare affinché nessun bambino venisse pestato. Oggi lo sono? Oso sperarlo, ma non ne sono sicuro. Peggio ancora, avendo io un handicap, la colpa delle mie avverse fortune sociali mi veniva ovviamente addossata. Se in un gruppo di quattro bambini, A, B, C e D, gli ultimi tre si rifiutano di giocare con il bambino con autismo A, la «colpa» o comunque la causa del fenomeno verrà attribuita a una particolarità di A, e non a una decisione riprovevole di B, C e D. Una doppia sofferenza, dunque, che incontreremo in tutte le tappe, o quasi.
I miei genitori, lucidi e osservatori, avevano escogitato una temibile contromossa: dire che ero straniero o ceco. Ecco che tutto si spiegava chiaramente! Parlavo in modo scorretto? Nulla di più normale. Non comprendevo le regole? Più che naturale. Così come il fatto che non mangiassi in mensa, visto che ero abituato alla strana dieta di quelle contrade lontane. Qualche anno fa, ho incontrato un signore di origini svedesi, il quale mi ha spontaneamente raccontato una storia molto simile alla mia, ma in cui i cechi erano sostituiti dagli svedesi. Evidentemente, i miei genitori non erano stati gli unici a pensarci!
I miei piccoli compagni, ovvero il momento della ricreazione
Ritenere che i bambini si sentano a loro agio con i compagni di scuola è una tra le convinzioni più radicate. E anche una delle più funeste per i bambini con autismo. Non si dice forse ai bimbi che non vogliono andare a scuola che potranno rivedere i loro «compagni»? I miei genitori no, ma penso che ciò non avrebbe fatto altro che esasperarmi. Che cosa poteva significare il termine «compagno»? Perché utilizzarlo quando la maestra di quarta elementare ci aveva chiaramente spiegato che non dovevamo impiegarlo nei nostri temi? Per non parlare del fatto che i «compagni» in questione, per un bambino autistico, erano piuttosto dei piccoli mostri che lo picchiavano.
In linea con questa convinzione, il momento migliore, il più sognato, non può che essere quello della famosa, mitica ricreazione. Un incubo. Echeggia il suono stridente di una campanella. Non appena cessa o, a dire il vero, ben prima che sia cessato, i bambini si mettono a urlare e a correre, si precipitano fuori in fretta e furia, smaniosi di giocare.
Io non sapevo giocare a pallone, o meglio, a quel gioco strano, un miscuglio non autorizzato di regole ufficiali e pratiche ad hoc. Inoltre, per praticarlo occorre possedere un certo numero di doti fisiche: saper visualizzare in tre dimensioni la traiettoria della palla, avere una buona motricità… tutte cose alquanto problematiche per me, ancora oggi. I miei genitori erano soliti dire, a proposito degli oggetti che non riuscivo ad afferrare, che avevo due mani sinistre. Sul campo, i bambini usavano parole molto più cattive. L’elemento più paralizzante per me è la mancanza di percezione del significato. Qual è lo scopo di questo gioco del pallone? Che senso ha tirare calci a una palla che diventa subito sporca, e mandarla in una direzione o nell’altra? Non ditemi che il calcio è «cool». La palla è a temperatura ambiente, non più fredda (cool, nella sua accezione primaria), dunque la vostra argomentazione non è valida.
I bambini con autismo hanno sovente un’andatura e un comportamento generale un po’ strambi. Gli altri scolari notavano che in classe non reagivo alla stessa maniera alle sollecitazioni dell’insegnante. Osservatori com’erano, si facevano ben presto un giudizio sul loro piccolo compagno. I bambini capiscono all’istante chi sarà popolare o amato dal gruppo, e chi invece verrà messo ai margini. La società degli adulti è simile, ma l’ipocrisia sociale è più raffinata: anziché picchiare direttamente, si utilizzano determinati atteggiamenti, certe frasi esclusorie, per ottenere all’incirca lo stesso risultato. Era quindi pressoché impensabile per gli altri alunni che io partecipassi ai loro giochi di gruppo. Anche supponendo che venisse organizzato un gioco adatto a me, erano così abituati a vedermi escluso che mi accettavano a fatica nel gruppo.
Mio padre e mia madre se ne rendevano perfettamente conto, quando tornavo a casa tutto sporco, con la divisa imbrattata di fango. Non portavo ancora gli occhiali, all’epoca: per fortuna. L’ultima volta che mi hanno menato dev’essere stata alla fine della seconda media. Ma che cosa potevano farci i miei genitori? La colpa era loro; a ricordarglielo c’erano, sulle pagelle, le menzioni relative alla mia non partecipazione alla «vita scolastica».
Con il mio cinismo crescente potrei arrivare a credere che, forse, la presenza di un avversario, o di un essere considerato da tutti spregevole, contribuisca alla coesione generale. Una volta, all’inizio di un gioco che non avevo capito, avevo osservato gli altri bambini radunarsi urlando: «Caposquadra! Caposquadra!». Ovviamente, ciascuno voleva essere il caposquadra, ma io non sapevo perché. Così, avevo strillato: «Schiavo della squadra!». Dopo un attimo di silenzio e sbigottimento, il mio ruolo era chiaro: avevo dato senso e coesione al gruppo. Sapevano quel che avrebbero fatto, ovvero sfogarsi su di me. Strano modo di ringraziarmi per aver fatto loro un favore.
Dovevo ricorrere ad altre astuzie. Combattere frontalmente era impensabile, non fosse altro perché ero sempre il più gracile della mia classe. Schivare era la regola. Il cortile dell’istituto era molto grande; spesso mi rifugiavo in un angolo a leggere. Mi nascondevo con i miei libri, che potevo infilare nelle tasche. Purtroppo, questa tecnica era un’arma a doppio taglio, perché potevate starvene tranquilli in un angolo, ma se vi trovavano per voi era finita.
Più tardi, in quarta o in quinta elementare, ho notato che, commettendo qualche piccola sciocchezza o addossandomi la colpa di quelle dei miei compagni, potevo essere privato della ricreazione e tenuto in classe. Ci ho provato diverse volte, e quando ci riuscivo per me era il paradiso. Non so se i miei insegnanti avessero mangiato la foglia. Non sempre i non autistici possiedono quella mente sviluppata che si attribuiscono.
Col tempo, poco per volta, si finisce per abituarsi quasi a tutto, ma quando un bambino, autistico o meno, si abitua a essere rifiutato, questo ha degli effetti sul suo sviluppo personale. La cosa in grado di traumatizzarlo di più è cercare di mettere in atto delle strategie per comunicare e poi constatare il sistematico fallimento di ogni tentativo. Per esempio, per instaurare un contatto con un vostro compagno di classe, fate lo sforzo, quando arriva, di dirgli «buongiorno», come si conviene. Solo che fate fiasco, perché il vostro interl...