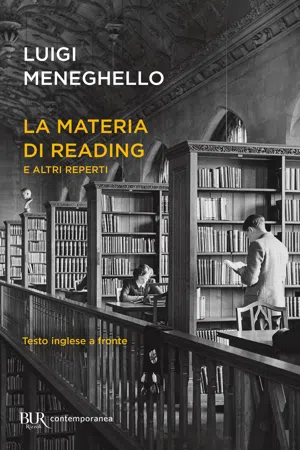Mi devo scusare con quelli di voi che potrebbero aver pensato che vi dicessi qualcosa di molto utile o pratico per i vostri studi, perché non sarà così: ho fatto poche cose pratiche e utili nella mia vita, e anche questa non so se riuscirei a farla. Mi sono accorto che sarà inevitabile che mi riferisca a certe mie esperienze o mezze esperienze di traduzioni; però, si tratta spesso di esperienze che riguardano l’inglese da una parte come lingua di partenza, ma una diversa lingua neolatina come lingua d’arrivo, cioè il vicentino, che conosco meglio dell’italiano e dell’inglese, anzi, mi piace dire che è la sola lingua che conosco.
Qualche tempo fa ho ricevuto una lettera d’insulti per qualcosa che avevo detto in un libro pieno di osservazioni sulle corrispondenze tra l’inglese e l’italiano – in pratica sulla traduzione. Erano insulti graduali; cominciavano con un sarcastico «bravo! bravo!», poi si aggravavano nella prima pagina, diventavano a mano a mano più pesanti e culminavano in un insulto supremo a metà della seconda pagina, scritto in maiuscole molto grandi. È un insulto ordinario in italiano, una parola fecale che preferirei non ripetere qui, con due punti esclamativi: e sotto, e questo è il punto, purtroppo, c’era scritto, quasi riprendendo e concludendo la lettera, «e ora traducilo in inglese». Si dà il caso che io lo sappia tradurre in inglese con una certa precisione, me l’hanno insegnato i miei studenti, o piuttosto le mie studentesse, che raccontavano – una di loro una volta raccontava in dettaglio – gli incontri di gruppo con i loro ragazzi (parola che non si usava per dire boyfriends quando sono andato io in Inghilterra, cento anni fa): i loro “ragazzi”, in senso tecnico, acquisiti in Italia nell’anno all’estero. Incontrandosi si salutavano festosamente con questa parola, fecale in italiano e fecale anche in inglese. In italiano è di due sillabe, in inglese di una sola; sono i soliti tre fonemi – e come sempre mi meraviglia la potenza di questi bonsai inglesi. C’è poi la complicazione in inglese che all’insulto-epiteto si aggiunge un pittoresco participio presente.
Il fatto è che quella frase, «e ora traducilo in inglese», mi ha un po’ ferito. Mi sono accorto di uno sgradevole sottinteso da parte della persona che mi scriveva, come se ci fosse qualcosa di intrinsecamente meschino e pedantesco, di non del tutto fondato, di inane, nel tradurre, nell’esercizio del tradurre, o perlomeno nel mio interesse troppo intenso per la traduzione. Questi sono dubbi che vengono ogni tanto a chi ha avuto pratica della cosa. Si ha paura che a occuparsi con troppo gusto delle corrispondenze tra le lingue ci sia qualcosa di poco genuino o reale. Un po’ di dubbio di questo tipo c’è, e ve ne parlo così all’inizio con intenti apotropaici, scaramantici, per tenere lontana l’idea.
In verità avevo mezzo proposto una specie di titolo per questa chiacchierata, e il titolo sarebbe stato Il turbo e il chiaro. [La “mezza proposta” è stata poi adottata per la versione scritta.] “Turbo” e “chiaro” sono parole di Dante. Siamo in Paradiso, secondo canto, le macchie lunari, in cui Beatrice, in un canto a tratti un po’ ostico al nostro orecchio moderno, spiega che la causa delle macchie lunari non è questa ma quest’altra. È un «formal principio» che le determina, e non la differenza di densità. Una “virtù diversa” di cui si dice: «Essa è formal principio che produce, / conforme a sua bontà, lo turbo e ’l chiaro». Avevo proposto il turbo e il chiaro perché non volevo fare una citazione, ma volevo indicare un tema: in pratica ciò che ho fatto si può considerare una traduzione. Vedete quanto strambo e sottile diventa il concetto di traduzione, se ci mettiamo a pensarci. Inutile dire che mi rendo conto delle associazioni anche comiche e grottesche che ci sono oggi nel mio titolo: “il turbo”, o, in vicentino, el turbo, è un termine che ha a che fare con macchine automobili che hanno un certo tipo di propulsione. Avrei poi pensato a un sottotitolo, qualcosa come Rilevamenti sulle frontiere della traduzione letteraria, ma capisco che è un po’ pretenzioso, un po’ solenne. Ecco un altro esempio degli eccessi e degli errori a cui siamo esposti: ma lasciamo stare. La mia idea è basata sulla nozione che ciascun testo ha una parte torbida: “turbo” vuol dire questo in Dante – lo turbo è ciò che è torbido, contrapposto a ciò che è chiaro.
Io penso che ogni testo abbia parti chiare e parti oscure, non soltanto in superficie, quelle visibilmente chiare e visibilmente oscure, ma in tutta la sua costituzione, per la natura della nostra mente. Secondo me, il senso di qualunque testo è intrinsecamente problematico. Cioè, nessuno, neanche l’autore, sa veramente ciò che vuol dire, tutto ciò che vuol dire. È la cagione non è superficiale, ma è «formal principio», come tanti secoli fa diceva Dante a proposito di questa faccenda delle macchie lunari. È la natura delle nostre lingue che la determina, è la natura, in sostanza, della nostra mente. Per me tradurre significa spostare gli equilibri interni di un testo, che nel testo stanno lì, e nella vostra comprensione immediata e diretta del testo li vedete stabili, ma non appena tentate di tradurre vi può venir fuori dalla traduzione qualche cosa che non sapevate nemmeno che c’era nel testo: almeno questo è ciò che capita continuamente a me. Si va, traducendo, a colpire punti nevralgici del testo; si fanno emergere aspetti che non erano in rilievo, che forse nella lingua originale non potevamo nemmeno sapere se c’erano o no. Insomma, la traduzione è quasi un nuovo testo, in verità; ha la potenza, ai miei occhi, di un nuovo testo. Ovviamente questo non è il solo proposito della traduzione com’è esercitata in pratica, ma è forse l’aspetto che mi interessa di più.
Mi sono occupato poco, direttamente, di traduzioni come tali. Sul piano teorico non avevo mai messo a fuoco la faccenda. Ripensandoci per questa occasione, e riguardando certi testi, mi sono riconfermato nell’idea che ci sono aspetti quasi metafisici nel tradurre, come se la natura, non soltanto del leggere, ma anche del comunicare e del capire, fosse intimamente intrecciata con la natura del tradurre. È un’idea che è esposta per esempio in quel libro che molti di voi certamente conoscono, di George Steiner, che si chiama After Babel, e che tratta della molteplicità delle lingue e di cento argomenti connessi con questo. È un libro farraginoso, ma straordinariamente ricco e stimolante, e contiene, tra l’altro, delle idee sulla traduzione simili a quella che vi ho esposto. Questo sul piano teorico.
Sul piano pratico, cioè per quanto riguarda l’esercizio effettivo della traduzione e la parte che ha avuto nella mia esperienza, se non è troppo solenne chiamare la nostra vita “esperienza”, io ho sempre sottovalutato il ruolo della traduzione. Non avevo mai pensato che fosse importante, la consideravo un aspetto marginale, quasi trascurabile della mia vita letteraria. E invece non è così.. Proprio nel ripensarci, nel controllare certi dati per questa occasione, ho avuto delle strane sorprese. Sono stato anche sbilanciato un po’. La traduzione c’è dappertutto nella mia vita, a ogni svolta di strada e a tutti i livelli: da una lingua all’altra e dall’altra alla prima, in frammenti, coscientemente, come esercizio, incoscientemente, in mille cose; una specie di falso bordone che va dietro alla melodia o alla mancanza di melodia nelle nostre vite almeno nel mio caso.
Vorrei dirvi qualcosa dell’esperienza pratica di traduttore che ho avuto. Ho tradotto parecchia roba, tutto sommato, una mezza dozzina di libri, un migliaio e mezzo almeno di pagine. Sono traduzioni pubblicate, e pubblicate con altro nome, come quasi tutto quello che ho scritto fino al momento che mi sono messo a scrivere le mie cosucce personali, con quel primo libro, Libera nos a malo, una trentina di anni fa. È stato un periodo, quello delle traduzioni – e come ho detto non sono poche –, durato solo due o tre anni, dal 1960 al 1963. Periodo brevissimo, quindi di intensa attività, e mi sono accorto, riguardando queste traduzioni per la prima volta dopo tanti anni, che hanno avuto una notevole importanza per me personalmente. È lì che ho – non dirò imparato a scrivere, ma disimparato a scrivere male. Scrivevo tanto male da ragazzo, e non forse per ragioni puramente linguistiche, ma perché pretendevo di spiegare l’universo a me stesso, e a chi eventualmente mi leggesse, non nella prima frase, ma nel primo pezzetto della prima frase, le prime due o tre righe, e questo è un grave disturbo, e non permette di scrivere bene. Facendo il traduttore, ho potuto sciogliere la mano, perché non avevo più la responsabilità di spiegare niente a nessuno: il testo c’era già.
Non sono libri strettamente letterari: uno di analisi politica, uno su psicanalisi e religione, di Erich Fromm, un libro di saggi sull’intelligenza e le razze umane, un libro di polemica sociale, politica e civile, La forca in Inghilterra è il titolo, di Arthur Köstler, sulla pena di morte che allora c’era ancora lassù; e finalmente il più importante di questi libri, un testo che ha un proprio costrutto letterario. È il libro di un giornalista che si chiamava Henry Wickham Steed, un giornalista di primissimo ordine. Era stato direttore del «Times» di Londra subito dopo la prima guerra mondiale, ma aveva prima fatto il corrispondente del «Times» in giro per l’Europa. Scrisse le sue memorie alla metà degli anni Venti. Questo libro, tradotto con il titolo di Trent’anni di storia europea, ha un suo modesto rilievo letterario, è ben scritto. È il giornalismo di una volta, di alto stile, di grande finezza, sia culturale che di orecchio nello scrivere, e io mi sono impegnato lì, ma anche negli altri libri che vi ho citato che non hanno speciali pregi letterari, come se fossero opere letterarie di qualità, almeno sul piano linguistico. Cioè: mi sono proposto di tradurli come se fossero testi non dico eccelsi, ma di una certa importanza letteraria. Questo per ragioni mie, proprio perché avevo voglia di sciogliermi la mano, di imparare a scrivere. Quindi ho cercato di tradurli con la proprietà idiomatica e quel tanto di vivezza espressiva che ci ho potuto metter dentro e quel tanto di grazia che potevo, insomma con l’impegno che si riserva di solito per una traduzione dove si ha davanti un testo esemplare.
C’era in questo anche una polemica privata contro la prosa accademica, una buona parte della prosa accademica corrente allora in Italia, che era pomposa e pretenziosa, e che trovavo oscura e insopportabile nei bravi, anche nei bravissimi; non voglio far nomi, non è il caso. Oscura e insopportabile nei bravi, ma nei non bravi veramente oscena. Ero giovane ancora, e si esagera in queste cose, però la sostanza era questa. Allo...