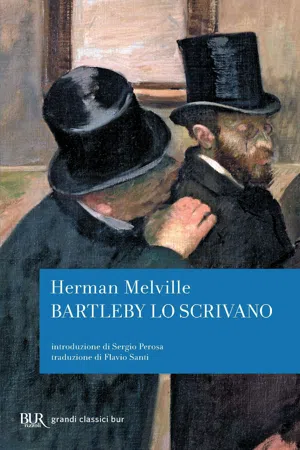![]()
BARTLEBY LO SCRIVANO
UNA STORIA DI WALL STREET
![]()
Sono un uomo piuttosto anziano. Nelle ultime tre decadi gli impegni di lavoro mi hanno portato a frequentare, in maniera tutt’altro che sporadica, un singolare stampo d’uomini degni di un certo interesse, di cui finora nessuno – che io sappia – ha mai scritto: parlo dei copisti di documenti legali, altrimenti detti scrivani. Ne ho conosciuti molti, sia sul lavoro che in privato, e se mi venisse il ghiribizzo potrei raccontare storie a iosa, di fronte alle quali gli uomini benevoli indulgerebbero al sorriso e quelli sentimentali alla lacrima. Ma rinuncio volentieri alla biografia di tutti gli altri scrivani per qualche saggio della vita di Bartleby, che è stato lo scrivano più strano che abbia mai visto o di cui abbia mai sentito parlare. Mentre degli altri copisti potrei stilare senza alcuna difficoltà la vita intera, con Bartleby tutto ciò sarebbe impossibile. Credo che non esista materiale sufficiente per una biografia completa di un simile individuo. Una grave perdita per la letteratura, ahimè. Bartleby era uno di quegli esseri di cui nulla è accertabile se non dalle fonti originarie – che nella fattispecie risultano essere alquanto esigue. Tutto ciò che so di lui è quanto registrarono i miei occhi colmi di stupore, eccezion fatta, in effetti, per un vago referto che si paleserà nel prosieguo.
Ma prima di parlare dello scrivano, di come si presentò al mio cospetto, è il caso di fare qualche cenno a me, ai miei impiegati, ai miei affari, al mio ufficio e all’ambiente in generale, poiché una siffatta descrizione è indispensabile per un’adeguata comprensione del personaggio principale che verrà poi presentato.
In primis: sono sempre stato convinto, fin dalla giovinezza, che nella vita la strada più facile è sempre la migliore. Indi per cui, benché appartenga a una categoria notoriamente iperattiva e nevrastenica, talora ai limiti della molestia, non ho mai tollerato che qualcosa del genere venisse a turbare la mia pace. Sono uno di quegli avvocati privi di ambizione che non fanno mai appello alla giuria né cercano il plauso del pubblico, ma che nel quieto vivere di un rifugio accogliente si barcamenano tra obbligazioni di clienti facoltosi, ipoteche e titoli di proprietà. Chi mi conosce mi ritiene una persona sommamente cauta. La buon’anima di John Jacob Astor,1 persona poco propensa alle esuberanze poetiche, non esitò a riconoscere nella prudenza il vertice delle mie virtù – segue, in seconda posizione, il metodo. Non parlo per vanità, ma semplicemente per constatare un dato di fatto: nella mia professione non venni mai sottoutilizzato dal buon John Jacob Astor, un nome che – lo ammetto – amo ripetere, perché ha un suono rotondo e sferico, come se riecheggiasse da un lingotto d’oro. Inoltre, mi pregio di aggiungere che non potevo non compiacermi della stima che il defunto John Jacob Astor mi manifestava.
Un po’ prima del periodo in cui ha inizio la nostra breve storia, il volume dei miei impegni era aumentato notevolmente. Avevo ricevuto quel buon vecchio incarico, ora scomparso nello Stato di New York, di magistrato dell’Alta Corte di Giustizia. Si trattava di una mansione non particolarmente gravosa, ma assai ben remunerata. Di rado perdo la pazienza, e ancor più di rado indulgo in fragorose indignazioni per i soprusi e gli oltraggi, però mi sia concesso di essere ardito e dichiarare che reputo la repentina e violenta abrogazione della carica di magistrato dell’Alta Corte di Giustizia da parte della nuova Costituzione un… be’, un atto prematuro, in quanto avevo contato di godere dei vantaggi per il resto della vita, mentre ne ricevetti i benefici soltanto per pochi anni. Ma tutto ciò sia detto en passant.
Il mio ufficio era ubicato al n. ** di Wall Street, al piano superiore. A un’estremità si affacciava sul muro bianco di un ampio condotto di aerazione interno che tagliava l’edificio da cima a fondo culminando in un lucernario. Questa vista poteva essere considerata alquanto noiosa, priva di ciò che i pittori di paesaggi chiamano “vita”. Ma la vista dall’altra estremità offriva perlomeno un contrasto – se non altro. Da quella parte le finestre si affacciavano direttamente su un alto muro di mattoni, nero per gli anni e l’ombra perenne, muro che non richiedeva alcun cannocchiale per apprezzarne le recondite bellezze, ma a beneficio degli spettatori miopi si ergeva ad appena tre metri dalle mie finestre. Per la ragguardevole altezza degli edifici circostanti e per il fatto che il mio ufficio era al secondo piano, lo spazio tra quel muro e il mio assomigliava non poco a un’enorme cisterna quadrata.
Nel periodo immediatamente precedente all’arrivo di Bartleby, alle mie dipendenze lavoravano due persone in qualità di copisti e un promettente giovanotto come fattorino. Il primo si chiamava Turkey, il secondo Nippers, il terzo Ginger Nut. Possono sembrare nomi difficilmente reperibili all’anagrafe. In effetti si trattava di soprannomi che i mie tre impiegati si erano affibbiati reciprocamente, ed erano ritenuti indicativi delle rispettive caratteristiche personali. Turkey – Tacchino – era un inglese tarchiato e pingue, all’incirca della mia età, cioè non lontano dalle sessanta primavere. La mattina si poteva affermare con certezza che il viso fosse di un bel colorito florido, ma dopo le dodici – la sua ora di pranzo – divampava come un camino a Natale carico di carboni, e continuava a divampare, ma – per così dire – scemando gradualmente, fino alle sei di sera, o giù di lì, dopodiché non vedevo più niente del proprietario di quella faccia, che con il sole raggiungeva il culmine, con l’aureo pianeta sembrava tramontare, per poi risorgere, toccare di nuovo lo zenit e declinare l’indomani, con la stessa regolarità e perpetua gloria. Ho conosciuto molte singolari coincidenze nel corso della vita, non ultima il fatto che esattamente quando Turkey spandeva i suoi raggi più luminosi dal viso rubicondo e raggiante, proprio allora in quel momento cruciale cominciava anche il periodo quotidiano in cui mi rendevo conto che le sue capacità lavorative erano gravemente compromesse per il resto delle ventiquattr’ore successive. Non che fosse perdutamente pigro o ricalcitrante al lavoro – anzi, tutt’altro. Il problema era piuttosto che tendeva a essere troppo attivo. Le sue azioni sfoggiavano una strana, infiammata, agitata, volubile avventatezza. Intingeva distrattamente il pennino nel calamaio. Tutte le sue macchie sui miei documenti cadevano puntualmente dopo le dodici. Del resto, nel pomeriggio non solo era sbadato e tristemente occupato a spargere macchie, ma talora andava oltre e diventava alquanto molesto. In simili frangenti il suo viso sfolgorava di una vampa più intensa, come se del carbone a fiamma lunga fosse stato aggiunto all’antracite. Con la sedia produceva uno sgradevole stridore, rovesciava il contenitore del polverino, mentre sistemava i pennini, li spezzava con impazienza in mille pezzi e li lanciava a terra con una furia improvvisa; scattava in piedi e chino sul tavolo sfogliava le sue carte in un modo assai indecoroso e triste da vedere in un uomo anziano come lui. Nondimeno, visto che per me era una persona per molti aspetti preziosa e per tutto il tempo fino a mezzogiorno anche la creatura più pronta ed equilibrata, svolgeva una gran mole di lavoro con uno stile non facile da eguagliare: per questi motivi ero disposto a soprassedere alle sue bizzarrie, anche se di tanto in tanto mi toccava rimproverarlo. Comunque lo facevo con molta delicatezza, perché, sebbene al mattino fosse, oh sì, la persona più civile, mite ed educata sulla faccia della terra, poi però nel pomeriggio tendeva, se provocato, a essere un po’ temerario con la lingua, indi per cui insolente. Ora, stimando il suo operato mattutino, e non volendo per nulla al mondo perderlo, eppure trovandomi al tempo stesso a disagio per i suoi modi infiammati; essendo un uomo pacifico, non volendo con i miei ammonimenti provocare inconsulte repliche da parte sua, un sabato a mezzogiorno (il sabato versava sempre in condizioni peggiori) mi presi la briga di suggerirgli, molto gentilmente nevvero, che forse stava invecchiando e sarebbe stato meglio ridurre il lavoro: indi per cui non era necessario che venisse in ufficio anche dopo mezzogiorno, ma, una volta terminato il desinare, era meglio che tornasse a casa a riposarsi fino all’ora del tè. Macché: insistette sui suoi doveri pomeridiani. Si infervorò in modo eccessivo, mentre con fare retorico cercava di convincermi – gesticolando con un lungo righello all’altro capo della stanza – che, se i suoi servigi al mattino erano utili, quanto erano indispensabili allora quelli del pomeriggio?
«Con il dovuto rispetto, sir» disse Turkey in quell’occasione. «Mi considero il suo braccio destro. La mattina mi limito a marciare e a disporre le colonne, ma è al pomeriggio che mi metto alla loro testa e attacco coraggiosamente il nemico, così!» e diede una violenta stoccata con il righello.
«Ma le macchie, Turkey…» gli ricordai.
«Touché. Ma con il dovuto rispetto, sir, guardi questi capelli! Sto invecchiando. Di certo, sir, una macchia o due in un caldo pomeriggio non sono da imputare troppo severamente a questi capelli grigi. La vecchiaia – anche se macchia una pagina – è pur sempre onorevole! Con il dovuto rispetto, sir, stiamo invecchiando entrambi.»
Questo appello alla mia solidarietà era praticamente irresistibile. In ogni caso, capii che non se ne sarebbe andato. Così decisi di lasciarlo lì, cercando, perlomeno, di controllare che nel pomeriggio avesse a che fare con documenti di minore importanza.
Nippers – Pince-nez – il secondo dell’elenco, era un giovane di circa venticinque anni con un bel paio di favoriti, dal colorito giallastro, con un aspetto nel complesso piuttosto piratesco. L’ho sempre ritenuto vittima di due implacabili flagelli: l’ambizione e la cattiva digestione. L’ambizione si intuiva da una certa impazienza nello svolgere i compiti di un semplice copista, da un’ingiustificabile usurpazione di mansioni strettamente giuridiche, quale la stesura originale di documenti legali. La cattiva digestione, invece, sembrava palesarsi in occasionali scatti di nervosismo e in smorfie di insofferenza, che gli facevano digrignare i denti in modo distinto per gli errori commessi nel copiare, in gratuite imprecazioni, sibilate più che pronunciate nel fervore del lavoro, e soprattutto in una costante insoddisfazione per l’altezza del tavolo su cui copiava. Per quanto dotato di un gran senso pratico, Nippers non riusciva mai ad adattare la foggia della scrivania a sé. Sotto vi infilava schegge di legno, zeppe d’ogni genere, pezzi di cartone, e alla fine arrivò perfino a provare ardite soluzioni con strisce ripiegate di carta assorbente. Ma nessuna invenzione era risolutiva. Se, per dar sollievo alla schiena, sistemava il piano del tavolo ad angolo retto, sollevandolo fino al mento, scrivendo come un uomo che usasse il tetto spiovente di una casa olandese per scrivania, allora proclamava che così gli si bloccava la circolazione alle braccia. Se abbassava il tavolo all’altezza della vita, piegandosi per scrivere, un dolore straziante gli infiammava la schiena. In sostanza, la verità era che Nippers non sapeva ciò che voleva. O, se mai avesse voluto qualcosa, era una sola: liberarsi del tavolo da copista. Tra le manifestazioni della sua morbosa ambizione c’era una certa qual propensione a ricevere visite da parte di loschi individui imbacuccati in cenciosi cappotti, tipacci che lui chiamava suoi clienti. Nella fattispecie sapevo che non solo, talora, si calava nei panni di un politicante da strapazzo, ma occasionalmente svolgeva anche qualche lavoro in tribunale, e il suo ceffo non era sconosciuto sui gradini delle Tombe.2 Comunque, ho buoni motivi di credere che un tale che lui riceveva nel mio ufficio e che, dandosi delle arie, insisteva a chiamare suo cliente, altri non fosse che un creditore, e il preteso titolo di proprietà un debito da pagare. Ma nonostante tutte le sue pecche e le grane che mi procurava, Nippers, come il suo compatriota Turkey, mi era assai utile: era in possesso di una mano svelta e una grafia nitida, e quando era in vena non mancava di un certo qual savoir faire da gentleman. A ciò si aggiunga che vestiva con una certa cura...