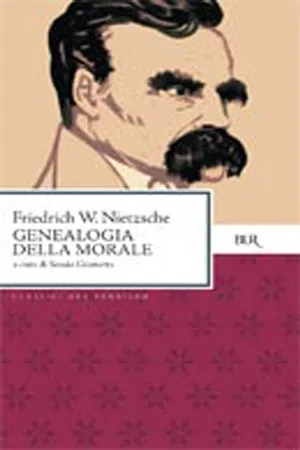
- 220 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Genealogia della morale
Informazioni su questo libro
Con il suo alito infuocato, quest'opera "di stile abbagliante, di una psicologia sempre più radicale, scintillante di ardite offese contro il suo tempo e irraggiante una bianca luce che abbacina" (per usare le parole di Thomas Mann), può essere considerata, in senso speculativo, il testamento spirituale di Nietzsche. Nelle tre dissertazioni che la compongono, il filosofo tedesco combatte le tre forme del nichilismo che si annidano nel cristianesimo: il risentimento, la cattiva coscienza e l'ideale ascetico. La Genealogia rappresenta un passaggio obbligato per comprendere quel pensiero della crisi che Nietzsche espresse con forza e incomparabile sensibilità.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Genealogia della morale di Friedrich W. Nietzsche in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Storia e teoria della filosofia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
TERZA DISSERTAZIONE
CHE COSA SIGNIFICANO GLI IDEALI ASCETICI?
Incuranti, beffardi, violenti – così ci
vuole la saggezza: essa è femmina e ama
sempre e solo il guerriero.
Così parlò Zarathustra
dp n="142" folio="142" ? dp n="143" folio="143" ? vuole la saggezza: essa è femmina e ama
sempre e solo il guerriero.
Così parlò Zarathustra
1
Che cosa significano gli ideali ascetici? – Negli artisti niente o troppe cose; nei filosofi e dotti qualcosa come il fiuto e l’istinto per le condizioni preliminari più favorevoli a un’alta spiritualità; nelle donne, nel migliore dei casi, una grazia di seduzione in più, un po’ di morbidezza sulle belle carni, l’angelicità di un leggiadro e ubertoso animale; nella gente fisiologicamente disgraziata e sgraziata (la maggioranza dei mortali) un tentativo di trovarsi «troppo buona» per questo mondo, una sacra forma di sregolatezza, il suo strumento principale nella lotta con il lento dolore e con la noia; nei preti la vera e propria fede pretesca, il loro migliore strumento di potere e anche la «suprema» legittimazione del potere; nei santi, infine, un pretesto per il letargo, la loro novissima gloriae cupido, la loro pace nel nulla («Dio»), la loro forma di insania. Ma che l’ideale ascetico in genere abbia tanto significato per l’uomo, in ciò si esprime il fatto fondamentale della volontà umana, il suo horror vacui: egli ha bisogno di una meta – e preferisce ancora volere il nulla al non volere. Mi si comprende?... Mi si è compreso?... «Assolutamente no, signore!» – Allora cominciamo dal principio.
2
Che cosa significano gli ideali ascetici? O, per prendere un caso particolare sul quale sono stato consultato piuttosto spesso, che cosa significa per esempio che un artista come Richard Wagner abbia, nei suoi giorni tardi, reso omaggio alla castità? In un determinato senso, certo, egli lo ha sempre fatto; ma soltanto alla fine lo ha fatto in un senso ascetico. Che cosa significa questa trasformazione di «senso»? questo radicale ribaltamento di senso? – giacché tale esso fu, con esso Wagner saltò dritto dritto nell’opposto di sé. Che cosa significa che un artista salti nell’opposto di sé?... Qui ci sovviene tosto, sempreché vogliamo soffermarci un poco su questa questione, il ricordo del tempo migliore, più forte, più lieto, più coraggioso che c’è stato forse nella vita di Wagner: è stato quando egli si travagliava intimamente e profondamente con l’idea delle nozze di Lutero. Chissà mai da quali strani casi è dipeso che noi oggi possediamo, invece di quella musica nuziale, I maestri cantori; e quante note di quella echeggiano forse ancora in questi. Ma non ci può essere dubbio sul fatto che anche in queste «Nozze di Lutero» si sarebbe trattato di un elogio della castità. E però anche di un elogio della sensualità – e proprio così esso mi sarebbe sembrato giusto, proprio così sarebbe anche stato «wagneriano». Perché tra castità e sensualità non v’è necessaria opposizione; ogni buon matrimonio, ogni vera passione amorosa va al di là di questa opposizione. Wagner avrebbe fatto bene, come mi sembra, a raccomandare di nuovo caldamente ai suoi Tedeschi, con l’aiuto di una bella e ardita commedia su Lutero, questa piacevole realtà, giacché ci sono e ci furono sempre fra i Tedeschi molti calunniatori della sensualità; e forse in niente Lutero ha un merito più grande che proprio in ciò, nell’aver avuto il coraggio della sua sensualità (allora la si chiamava, con una certa delicatezza, la «libertà evangelica»...). Ma anche nel caso in cui vi sia veramente opposizione tra castità e sensualità, non v’è di gran lunga alcun bisogno, per fortuna, che si tratti di un’opposizione tragica. Ciò dovrebbe valere almeno per tutti quei mortali di più sana costituzione e di spirito più lieto, i quali sono lungi dall’annoverare senz’altro fra gli argomenti contro l’esistenza il loro labile equilibrio tra «l’animale e l’angelo» – i più sottili e solari, come Goethe, come Hafis, vi hanno addirittura visto un’attrattiva in più della vita. Proprio tali «contraddizioni» invitano a vivere... D’altra parte s’intende fin troppo bene che, se un giorno i porci falliti vengono portati ad adorare la castità – e tali porci ci sono! – essi vedranno e adoreranno in essa soltanto il loro opposto, l’opposto del porco fallito – oh, con quale tragico grugnito e zelo! lo si può immaginare – quell’increscioso e superfluo opposto che, al termine della sua vita, Richard Wagner ha voluto ancora, incontestabilmente, mettere in musica e portare sulla scena. Ma a che scopo? come ci si può giustamente domandare. Giacché, che cosa importava a lui, che cosa importa a noi dei porci?...
3
Con tutto ciò, non si può certo eludere l’altra questione: che cosa gli importasse in realtà di quella virile (ah, così poco virile) «semplicità campestre», di quel povero diavolo, di quella creatura selvatica di Parsifal, che viene infine da lui, con mezzi così insidiosi, cattolicizzato – ma come, era inteso in genere questo Parsifal sul serio? Si potrebbe cioè essere tentati di presumere, anzi di augurarsi il contrario – che il Parsifal wagneriano fosse inteso in senso giocoso, quasi come epilogo e dramma satiresco con cui il Wagner tragico avesse voluto prendere congedo, in una maniera appunto a lui confacente e degna, da noi e anche da se stesso, ma soprattutto dalla tragedia, cioè con un eccesso di suprema e maliziosissima parodia sul tragico stesso, su tutta l’orribile serietà e strazio terreni di prima, sulla forma più grossolana di contronatura dell’ideale ascetico, infine superata. Proprio così la cosa sarebbe stata degna, come ho detto, di un grande tragico, il quale, come ogni artista, attinge l’estremo culmine della sua grandezza solo quando riesce a vedere sé e la sua arte sotto di sé – quando riesce a ridere di sé. È il Parsifal di Wagner il suo segreto riso di superiorità su se stesso, il trionfo dell’ultima, suprema libertà artistica, ulteriorità artistica da lui conquistata? Ce lo vorremmo, come ho detto, augurare; giacché che cosa sarebbe il Parsifal inteso sul serio? C’è veramente necessità di vedere in esso (come è stato detto contro di me) «il prodotto di un odio impazzito contro la conoscenza, lo spirito e la sensualità»? una maledizione contro i sensi e lo spirito in un solo soffio d’odio? un’apostasia e una conversione a morbosi e oscurantistici ideali cristiani? e infine addirittura una negazione di se stesso, una cancellazione di se stesso da parte di un artista che fino allora si era impegnato con tutta la forza della sua volontà per il contrario, ossia per la massima spiritualizzazione e sensualizzazione della sua arte? e non solo della sua arte, ma anche della sua vita? Si ricordi con quale entusiasmo Wagner seguì a suo tempo le orme del filosofo Feuerbach. La parola di Feuerbach della «sana sensualità» – negli anni trenta e quaranta essa suonò per Wagner al pari che per molti Tedeschi (questi si chiamavano i «giovani Tedeschi») come la parola della redenzione. Ha egli alla fine imparato al riguardo qualcosa d’altro? Dato che sembra, almeno, che abbia avuto alla fine l’intenzione di insegnare al riguardo qualcosa d’altro... E non solo con le trombe del Parsifal dall’alto della scena – nella torbida, altrettanto vischiosa che confusa attività di scrittore dei suoi ultimi anni vi sono cento passi in cui si tradisce un segreto desiderio e intento, una sgomenta, insicura, inconfessabile volontà di predicare in tutto e per tutto il ritorno, la conversione, la negazione, il cristianesimo, il medioevo, e di dire ai suoi discepoli: «Non vale! Cercate la salvezza da un’altra parte!» Una volta viene invocato addirittura il «sangue del Redentore»...
4
In un tale caso, che ha molto di increscioso – ed è un caso tipico – voglio dire la mia opinione: la cosa migliore da fare è certamente di separare l’artista dalla sua opera in modo tale da non prendere lui stesso sul serio allo stesso modo della sua opera. Egli è in definitiva soltanto la condizione preliminare della sua opera, il grembo materno, il suolo, in certi casi il concime e lo sterco su cui e con cui essa cresce – e quindi, nella maggior parte dei casi, qualcosa che si deve dimenticare se si vuol prendere diletto all’opera stessa. La ricerca dell’origine di un’opera compete ai fisiologi e vivisettori dello spirito; mai e poi mai agli uomini estetici, agli artisti! Al poeta e plasmatore del Parsifal non furono risparmiati un profondo, radicale e finanche terribile rivivere e calarsi nei contrasti spirituali del medioevo, un ostile appartarsi da ogni altezza, rigore e disciplina dello spirito, una sorta di perversità intellettuale (se mi si passa la parola) più che non siano risparmiate a una donna gravida le nausee e i capricci della gravidanza: che, come ho detto, si devono dimenticare per prendere diletto al figlio. Bisogna guardarsi dalla confusione, nella quale fin troppo facilmente cade l’artista stesso, per contiguity psicologica, per parlare con gli Inglesi, quasi che fosse egli stesso quello che deve rappresentare, ideare, esprimere. In realtà le cose stanno in modo che, se egli fosse quello appunto, assolutamente non lo rappresenterebbe, ideerebbe ed esprimerebbe; un Omero non avrebbe poetato un Achille, un Goethe non un Faust, se Omero fosse stato un Achille e Goethe un Faust. Un artista perfetto e completo è separato dal «reale», dall’effettuale, per tutta l’eternità. D’altra parte si capisce come egli possa talvolta stancarsi fino alla disperazione di quest’eterna «irrealtà» e falsità della sua esistenza più intima – e che ben faccia poi, una volta, il tentativo di sconfinare in ciò che gli è più vietato, nel reale, di essere reale. Con quale risultato? È facile intuirlo... È questa la tipica velleità dell’artista: la stessa velleità di cui cadde vittima, in vecchiaia, anche Wagner, e che egli dovette scontare a così caro prezzo, in un modo così disastroso (perse a causa di essa la parte migliore dei suoi amici). Ma alla fine, anche prescindendo del tutto da questa velleità, chi non si augurerebbe, proprio per amore di Wagner, che egli avesse preso congedo da noi e dalla sua arte diversamente, non con un Parsifal ma in un modo più vittorioso, più sicuro di sé, più wagneriano – meno fuorviante, meno ambiguo in relazione a tutto il suo volere, meno schopenhaueriano, meno nichilistico?...
5
Che cosa significano dunque gli ideali ascetici? Nel caso dell’artista, a poco a poco ce ne rendiamo conto: un bel nulla!... O tante di quelle cose che è come se non fosse nulla!... Cominciamo con l’eliminare gli artisti. Essi sono in una posizione di gran lunga non abbastanza indipendente nel mondo e contro il mondo perché le loro valutazioni e l’evoluzione di queste meritino di per sé partecipazione. Furono in tutti i tempi i servitori di una morale o filosofia o religione; anche prescindendo del tutto dal fatto di essere stati, purtroppo, piuttosto spesso cortigiani fin troppo malleabili dei loro ammiratori e mecenati, e adulatori di gran fiuto di fronte ai poteri antichi o di nuova e fresca costituzione. Come minimo hanno sempre bisogno di una salvaguardia, di un appoggio, di un’autorità già costituita. Gli artisti non fanno mai parte per se stessi, lo star soli va contro i loro istinti più profondi. Così, per esempio, Richard Wagner prese il filosofo Schopenhauer, «quando ne fu giunto il tempo», come suo battistrada, come sua salvaguardia – chi potrebbe ritenere anche solo pensabile che egli avrebbe avuto il coraggio di professare un ideale ascetico senza l’appoggio che gli veniva dalla filosofia di Schopenhauer, senza l’autorità di Schopenhauer affermatasi saldamente in Europa negli anni settanta? (senza ancora domandarsi al riguardo se nella nuova Germania sarebbe stato in genere possibile un artista senza il latte di una mentalità devota, devota all’impero). E con ciò siamo giunti alla più seria questione: che cosa significa che un vero filosofo indulga all’ideale ascetico, uno spirito che veramente riposi su se stesso come Schopenhauer, un uomo e un cavaliere dallo sguardo di bronzo, che ha il coraggio di far parte per se stesso, che sa stare da solo e non sta ad aspettare battistrada e cenni dall’alto? Consideriamo qui subito la singolare, e per più d’un tipo d’uomo addirittura affascinante, posizione di Schopenhauer sull’arte; perché fu questa, evidentemente, quella per la quale, in primo luogo, Wagner passò a Schopenhauer (a ciò persuaso da un poeta, come si sa, Herwegh), e ciò in misura tale c...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- LA GENEALOGIA DELLA MORALE NELL'OPERA DI NIETZSCHE
- LA VITA DI NIETZSCHE AL TEMPO DELLA GENEALOGIA DELLA MORALE
- BIBLIOGRAFIA
- PREFAZIONE
- PRIMA DISSERTAZIONE - «BENE E MALE», «BUONO E CATTIVO»
- SECONDA DISSERTAZIONE - «COLPA», «CATTIVA COSCIENZA» E SIMILI
- TERZA DISSERTAZIONE - CHE COSA SIGNIFICANO GLI IDEALI ASCETICI?