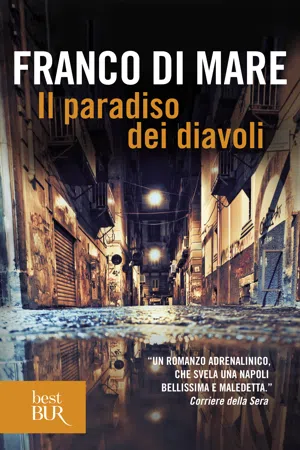![]()
Sedici
All’inizio, quand’era solo un ragazzino, il soprannome gli stava stretto. Lo portava male, non se lo sentiva addosso, provava disagio come quando uno mette una giacca che gli tira sulle spalle e gli fa aprire gli spacchi dietro. Non gli piaceva, insomma, così come non gli erano mai piaciuti i pantaloni di suo fratello più grande, che invece era costretto a portare perché in casa la lira non era mai girata e loro erano quattro figli e non c’era di che scialare, bisognava arrangiarsi.
A quel tempo provava a consolarsi dicendosi che il soprannome uno non se lo sceglie: quando te lo danno te lo devi tenere, punto e basta. Se non ti piace puoi solo sperare che non abbia successo, che non attecchisca, che non piaccia a nessuno e muoia da solo senza far danni, come certi bengala fasulli, quelli che a Capodanno si spengono in un fischio sfiatato, senza eruttare stelline filanti. Se invece uno comincia a chiamarti in quel modo e altri gli vanno dietro, allora la cosa prende piede, esce dai confini della scuola, si diffonde inesorabile tra gli amici del quartiere e un brutto giorno scopri che perfino il salumiere sotto casa ti chiama così. A quel punto lì non c’è più niente da fare e il soprannome, qualunque sia, ti rimane addosso per sempre, come il destino.
Proprio com’era accaduto a lui, che si chiamava Antonio Giordano ma per tutti era Tonino “Valentino”, come il sarto, per via della sua passione per ago e filo.
Il soprannome glielo avevano affibbiato in terza media, quella volta che stava giocando a pallone nel cortile della scuola durante l’intervallo e, mentre tentava di deviare un cross in rete, gli erano caduti dalla tasca un rocchetto di filo di cotone bianco e un ditale. A scuola tutti sapevano che sua madre faceva piccoli lavori di cucito, rammendi, asole, orli ai pantaloni. Ma nessuno aveva mai sospettato che anche lui avesse a che fare con ago e filo. Era stato Giulio Gelasi, quell’infame della terza B che gli aveva giusto parato la deviazione di testa, a raccogliere rocchetto e ditale e a urlargli dietro: «Te si’ scurdato l’ago, Valentino! Guardate qua che si porta dentro ’a sacca…».
E così dicendo aveva mostrato a tutti quello che aveva appena raccolto da terra. Gli altri avevano riso, Tonino ci aveva pure provato a dire che era roba di mammà, ma era servito a poco, i commenti sarcastici si erano sprecati. Quel giorno lui era diventato Valentino. Vagli a spiegare, però, com’era cominciata la faccenda. Il fatto è che, in tutta la sua infanzia, Tonino non aveva mai avuto niente che fosse veramente suo. Tutto quello che indossava era roba di suo fratello Ciro: maglioni, pantaloni, camicie, scarpe, cappotto. Perfino i calzini erano quelli del fratello, schiariti sui talloni e rammendati all’altezza degli alluci. Sua mamma diceva sempre «chello d’o gruosso passa ’o piccerille». Quello piccirillo dei quattro figli di casa Giordano (due maschi e due femmine) era lui e dunque a lui toccava portare la roba che a Ciro non andava più perché era cresciuto. Era mamma Assunta che sistemava tutto. Con la macchina per cucire era brava, con stoffe, lana, ago e filo ci sapeva fare. Quando i gomiti dei maglioni si usuravano, lei li copriva con le toppe di velluto o di camoscio, che il maglione sembrava ancora più bello di prima. I colletti consumati delle camicie venivano smontati, ricuciti al contrario e tornavano come nuovi, nessuno si accorgeva di niente. I pantaloni che diventavano lisi sulle ginocchia venivano tagliati e trasformati in bermuda all’inglese, stretti al ginocchio. Non c’era capo d’abbigliamento che non venisse riadattato e al quale Assunta non riuscisse a regalare una seconda vita, una nuova possibilità.
Piegata sulla Singer a pedale, mentre la radio diffondeva nella stanza la voce di Massimo Ranieri, Assunta Lo Cicero in Giordano allungava le vocali di Erba di casa mia e accorciava gli orli dei pantaloni.
Tonino restava spesso a guardarla incantato, in piedi accanto a lei, mentre sollevava la macchina per cucire sul perno fisso scoprendone il cuore meccanico, infilava il rocchetto del filo all’interno, faceva passare il bandolo per una piccola grata e poi gli chiedeva di inserire il filo nella cruna dell’ago, perché «tu tieni gli occhi buoni, a mammà».
Lui la guardava avviare lo stantuffo che spingeva l’ago pigiando sulla pedaliera della macchina e facendogli acquistare velocità. La mamma governava con maestria il passaggio della stoffa i cui lembi, d’incanto, combaciavano, saldati dalla cucitura di un ago che si muoveva tanto veloce da diventare invisibile. Tonino pensava che se avesse imparato, se fosse venuto a capo di quell’arte e di quei segreti, un giorno sarebbe stato capace di cucirseli lui stesso gli abiti, tutto da solo; avrebbe potuto fare dei pantaloni finalmente solo suoi, tagliati proprio per lui, nuovi di zecca.
Quando la mamma non c’era, lui a volte toglieva la copertura di cotone a fiori dalla macchina per cucire e restava lì a guardarla, lucida e misteriosa, bellissima, con le sue cromature dorate che disegnavano ghirigori sul fondo di metallo nero smaltato. Si chiedeva come facesse sua madre a governare un oggetto così complesso, un miracolo della meccanica, usando mani e piedi con una sincronia che a lui pareva ineguagliabile, simile a quella che aveva visto compiere a un pianista quella volta che la scuola aveva organizzato un concerto nella palestra per la visita ufficiale del Provveditore agli studi di Napoli, e lui aveva capito solo in quel momento che per suonare il piano – che è già così difficile – c’è bisogno anche dei piedi.
Un giorno che sua madre era andata a consegnare una giacca a cui aveva applicato delle toppe, Tonino aveva provato a metterla in funzione, quella macchina geniale. Aveva ripetuto tutti i gesti che le aveva visto fare: il rito di avviamento, l’ago, il rocchetto di filo in alto, sopra la macchina, e un altro giù in basso, incastrato dentro la pancia di ferro, tra le molle e i perni. Aveva controllato le ruote e il volano, la cinghia di cuoio che trasferiva il movimento della pedaliera alla meccanica interna. Aveva fatto passare il filo nella cruna dell’ago. Tutto era a posto. Allora si era sistemato alla pedaliera e l’aveva avviata, l’ago era partito con il suo su e giù sempre più veloce. Ma dopo pochi secondi i due pezzetti di stoffa che stava tentando di cucire insieme si erano bloccati e lui non era riuscito a farli scivolare sotto l’ago, che aveva continuato a infilarsi sempre nello stesso punto, aggrovigliando il filo di cotone in una piccola matassa inestricabile. La macchina s’era bloccata.
Quella volta si era preso un brutto spavento. Aveva temuto di aver rotto la Singer e compromesso per chissà quanto tempo il lavoro di sua madre.
Quando lei era tornata a casa le aveva confessato, impaurito, il guaio che aveva combinato. Lei era corsa a vedere, aveva preso le forbici, aveva tagliato quel groviglio e in un paio di minuti aveva sistemato tutto. Poi lo aveva guardato e gli aveva detto: «Vieni qua, che ti faccio vedere comme se fa. Tanto ’sti cose ccà, ormai, nun ’e fanno solamente ’e femmene».
Erano passati quarant’anni da quel giorno e Antonio Giordano, per tutti, era ancora Tonino Valentino. Ma nessuno più lo chiamava così per prenderlo in giro, perché intanto lui era diventato un piccolo imprenditore del tessile, titolare di quattro negozi di abbigliamento e di una piccola azienda con quattordici dipendenti che sfornava capi da lui disegnati. Macchine per cucire, tagliatrici e telai elettrici ora non avevano segreti per lui. Nel corso degli anni aveva creato una piccola linea che vendeva direttamente nei suoi negozi e piazzava anche ad altri punti vendita dislocati lontano, così evitava di farsi concorrenza. La sua fortuna si basava sulla velocità e l’inventiva, più che sulla qualità. Era una scelta precisa. Non poteva certo permettersi un vero stilista o l’impiego di tessuti pregiati, e allora, appena uscivano le novità delle grandi firme della moda, lui le imitava usando tessuti meno nobili, modificando qualche particolare qua e là, più per orgoglio che per paura della Guardia di Finanza, va riconosciuto.
«Tonino Valentino non fa falsi, fa il quasi uguale a un prezzo che è cinque volte meno» diceva di sé e del suo lavoro. «E le modifiche che faccio sono correzioni che migliorano l’originale.»
Il suo vero orgoglio però consisteva in una piccola linea produttiva che aveva chiamato “Napoli Italia”. Erano capi che prendevano spunto dalla cronaca e dall’attualità. In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per esempio, aveva prodotto delle camicette estive bianche, con una manica rossa e l’altra verde. In un anno ne aveva vendute dodicimila a venticinque euro l’una, anche fuori dai confini regionali, e a lui erano costate appena quattro euro. Vale a dire che aveva realizzato più di duecentocinquantamila euro di ricavo netto grazie a un’idea. Da quello stesso progetto era scaturita la serie delle bandiere storiche: delle vere e proprie bandiere di venti centimetri per trenta, realizzate in cotone e seta, che venivano cucite sul dorso di camicie e maglioni. Un successo durato due anni, che gli aveva dato grandi soddisfazioni.
Quando gli capitavano cose del genere, Tonino era davvero orgoglioso di sé. Gli spunti gli venivano spesso dalla lettura dei giornali. Il giorno che aveva visto la foto di Trapattoni, all’epoca allenatore della Nazionale di calcio, che bagnava il campo con una boccettina di acqua benedetta prima della partita, si era inventato il pantalone cargo con una tasca dotata di una piccola borraccia di alluminio su cui aveva fatto incidere la scritta: «Acqua santa, usare solo in caso di necessità.» Anche quello era stato un piccolo successo commerciale: di quei pantaloni ne aveva piazzati oltre tremila a settanta euro l’uno. A lui erano costati nove euro, borraccia inclusa, il che faceva un ricavo netto di centottantatremila euro.
Insomma, se Tonino Giordano non era Valentino, di certo poteva considerarsi un uomo di talento. La sua inventiva gli aveva regalato la sicurezza economica. Aveva acquistato un bell’appartamento a Posillipo, con un terrazzo da cui si vedeva Capri, girava con l’Audi, i suoi due figli erano impegnati nella gestione dell’azienda, così come la moglie Maria Concetta, che, pratica com’era, controllava l’amministrazione dei negozi e della produzione.
E siccome, secondo lui, l’innovazione deve andare a braccetto con la tradizione, aveva tirato su Vincenzo e Andrea, i figli, nel solco di questo precetto, spiegando loro che ogni cambiamento necessita della conoscenza delle proprie radici. «Se non sai da dove vieni, non sai nemmeno dove vai» diceva sempre. E allora aveva insegnato loro anche i rudimenti della parlesia, l’antico e misterioso linguaggio dei musicisti napoletani di cui si erano appropriati anche i vecchi negozianti del mercato, e che lui aveva appreso quando era garzone. Era un idioma cifrato, una lingua che non aveva alcun apparentamento con altre, un codice segreto che veniva usato quando era necessario comunicare senza farsi capire dai clienti: «appunisci ’a jamma», controlla quella signora; «’o jammo è bacaro», quell’uomo non mi convince, e via parlando con un linguaggio da setta carbonara che aveva anche il compito di creare unione, cementare la relazione tra gli adepti. Come avveniva per la famiglia Giordano, dove tutti si sostenevano e si spalleggiavano.
Tonino poteva dirsi un uomo soddisfatto. Tutto andava per il meglio. I guai – come spesso succede – erano cominciati proprio quando nessuno poteva aspettarselo, mentre era all’apice della sua vita professionale e stava accarezzando l’idea di acquistare un motoscafo, un Aprea mare semicabinato, un usato garantito, un vero affare che poteva avere a un prezzo d’occasione. Se ne avesse pagato una parte in nero, gli avevano promesso anche un ulteriore sconto.
Quel maledetto giorno, erano arrivati nel negozio di corso Umberto in due. Erano sotto la trentina. Avrebbe dovuto capirlo subito, Tonino, che erano portatori di sventura. Avevano detto che lavoravano nelle assicurazioni, ma senza dire quale. Gli avevano offerto la copertura dagli incidenti e avevano mostrato un tariffario unico: centocinquanta euro a vetrina a settimana. «Quali incidenti?», aveva chiesto Tonino.
«Quelli che possono capitare quando uno non se l’aspetta» aveva risposto uno dei due. E aveva aggiunto: «Passiamo la prossima settimana, mentre voi vi organizzate. Ma vi conviene accettare l’offerta così come ve l’abbiamo fatta oggi, perché adesso è molto conveniente, ma se fate passare tempo il costo sale di sicuro».
I due camorristi erano appena usciti dal negozio che erano arrivate le telefonate di Andrea e Vincenzo. Anche nei negozi del Vomero e di Fuorigrotta si erano presentati gli assicuratori. E siccome le disgrazie non vengono mai sole, le brutte notizie non erano finite lì. Il telefono aveva squillato di nuovo. Era Maria Concetta. Agitatissima. Nel laboratorio di Barra, dove c’erano i telai, erano arrivati due uomini che avevano offerto una polizza contro infortuni e danni, ma a lei quei due non sembravano proprio per niente assicuratori. L’unica cosa che avevano assicurato era che sarebbero tornati.
Non poteva essere casuale. Quelle visite erano il frutto di un’azione coordinata. E questo voleva dire una sola cosa, rifletté Tonino: erano finiti nel mirino del racket.
Quella sera, a casa, la famiglia Giordano si era riunita per decidere cosa fare. Andrea aveva fatto i conti: i loro quattro negozi contavano dieci vetrine (tre quello di corso Umberto, quattro quelli di via Cilea e via Luca Giordano e tre il negozio di via Leopardi), il che significava millecinquecento euro a settimana, vale a dire seimila euro al mese. Per il laboratorio di Barra, che vetrine non ne aveva essendo ricavato dal sottoscala di un deposito – ma che era il cuore produttivo dell’azienda – gli assicuratori, diciamo così, avevano fatto una richiesta forfettaria: mille euro a settimana.
«So’ diecimila euro al mese, papà» aveva tirato le somme Vincenzo, che da suo padre aveva ereditato l’inventiva e dalla madre il senso pratico. «Che dobbiamo fare?»
Tonino se n’era rimasto in silenzio, a pensare.
«Dobbiamo pagare, Toni’. Tu non li hai visti quelli che sono venuti a Barra. Erano facce brutte assai. La prossima volta vengono armati» aveva detto Maria Concetta, con la voce che ancora le tremava al ricordo della visita.
Tonino aveva guardato i figli, che gli avevano restituito lo sguardo senza parlare, aspettando che fosse lui a indicare una possibile via d’uscita, una soluzione.
Tonino Valentino si teneva la testa tra le mani. Se proprio avesse dovuto descrivere se stesso, non si sarebbe certo definito un uomo avaro. Dava un obolo fisso alla mensa dei poveri di Sant’Antonio e alla processione del santo, ogni anno, regalava mille euro. Ma le ristrettezze da cui veniva ne facevano una persona attenta al suo, come si dice. Il benessere in cui si muoveva era dovuto unicamente al suo lavoro, alla conoscenza tecnica della materia, alla sua abilità commerciale e, certo, bisognava ammettere, anche a qualche aggiustatina contabile qua e là, una cosa che del resto facevano un po’ tutti. Però la loro agiatezza, la tranquillità della famiglia erano frutto del suo lavoro, e lui non doveva dire grazie a nessuno, se si esclude l’abilità del suo commercialista, se proprio vogliamo dire.
È per questo che più ci aveva pensato e più gli era sembrato di impazzire: aveva faticato una vita intera per arrivare dove si trovava e adesso venivano questi qua, questi fetenti, e gli volevano mettere le mani in tasca? A lui, che si faticava col sudore della fronte ogni centesimo di quello che entrava nelle casse dell’azienda?
Si era passato una mano sul viso, per cancellare stanchezza e cattivi pensieri. Ma dove stavano quei pezzi di merda, si era chiesto, mentre lui faceva il ragazzino di bottega e si caricava le pezze di stoffa sulle spalle intanto che il titolare faceva gli inventari di magazzino? Ogni lira, e poi ogni centesimo di euro che aveva messo da parte e che aveva investito nei suoi progetti erano frutto dei sacrifici e delle privazioni che aveva affrontato. E adesso questi uommini ’e mmerda ci volevano mettere le mani sopra? No, non avrebbe permesso a nessuno di approfittare delle sue fatiche, nessun parassita gli avrebbe succhiato il sangue.
«Non paghiamo» aveva detto drizzando la schiena e dando voce alla sua rabbia. «Non gli diamo neanche un centesimo. I soldi a noi non ce li regala nessuno, noi ce li fatichiamo.»
La moglie e i figli lo avevano guardato senza parlare. Poi Maria Concetta aveva detto: «Toni’, chella è brutta gente… Io non dico che dobbiamo pagare tutto, magari ci possiamo accordare, possiamo arrivare alla metà…».
«Niente Conce’, neanche ’nu centesimo. Si accomminciammo accussì, chissà addò fernimmo. Comme se dice? Si te fai pecora, ’o lupo te magna. ’A fatica nostra non va int’ ’a sacca ’e chesta gente ’e mmerda.»
«E allora quando tornano che facciamo, papà? Quelli hanno detto che tra una settimana vengono un’altra volta» aveva chiesto Andrea.
«Quando tornano gli diciamo che ci sta la crisi e i guadagni sono pochi. Gli diciamo che la loro assicurazione noi non ce la possiamo permettere, perché se paghiamo, dopo tre mesi chiudiamo baracca e burattini. Per il momento però tu resti a casa, Concetta, e ’o laboratorio ce lassammo soltanto ’o ragiuniere e le dodici ragazze. Per un poco di tempo andiamo avanti così. Poi, quando le cose si sono sistemate, torni a Barra. Davanti a una reazione decisa vedrete che quelli capiscono e lasciano stare.»
E così avevano fatto. Quando gli assicuratori erano tornati, avevano spiegato loro che quelle condizioni erano irricevibili. Loro non potevano permettersi di pagare cifre del genere senza fallire, senza chiudere bottega. Grazie lo stesso e arrivederci. «Senza assicurazione possono essere guai pesanti» aveva detto allora uno di loro.
«E secondo voi ci sta un guaio più pesante che...