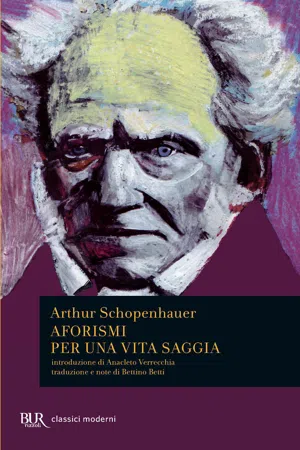Non mi propongo di essere esauriente, qui meno che mai; perché dovrei ripetere quanto hanno detto, formulando le loro numerose e in parte eccellenti norme di vita, i pensatori di tutti i tempi, da Teognide e dallo pseudo Salomone91 fino a La Rochefoucauld; e ciò facendo non potrei evitare di riprodurre molti, risaputi luoghi comuni. Insieme con la completezza viene a mancare, in gran parte, anche un ordinamento sistematico degli argomenti; due limiti di cui ci si potrà consolare pensando che in scritti di questo genere la completezza e la sistematicità danno luogo, quasi inevitabilmente, alla noia. Ho perciò annotato, di ciò che mi veniva in mente, ciò che mi sembrava meritevole di essere divulgato, e che, a quanto potevo ricordare, non era mai stato detto da nessuno, o era stato detto meno esplicitamente e in altra forma. Insomma, questa non è che un’aggiunta rivolta a integrare quanto, in quel campo sterminato, è stato già fatto da altri.
Tuttavia, per organizzare in qualche modo la grande molteplicità delle idee e dei suggerimenti attinenti all’argomento, li ripartirò come segue. La prima sezione sarà dedicata a considerazioni generali; seguiranno considerazioni riguardanti il nostro comportamento: verso noi stessi; verso gli altri; e, infine, verso il mondo e il destino.
A) Considerazioni generali
1) La norma suprema di tutta l’umana saggezza è conte nuta, a mio parere, in una sentenza pronunciata incidentalmente da Aristotele nell’Etica Nicomachea (VII, 12): ὁ ϕρóνιμoς τὸ ἄλυπoν διώκει, oὐ τὸ ἡδύ (quod dolore vacat, non quod suave est, persequitur vir prudens). La versione latina è scialba; in tedesco si può tradurre meglio: «Nicht dem Vergnügen, der Schmerzlosigkeit geht der Vernünftige nach»: «L’uomo ragionevole cerca non il piacere, ma l’assenza del dolore». La verità di tale sentenza sta in questo: ogni piacere, ogni felicità è di natura negativa, mentre il dolore è di natura positiva. Questa tesi è stata sviluppata e dimostrata nella mia opera principale (voi. I, § 58);92 tuttavia la voglio qui illustrare con un fatto che si può constatare ogni giorno. Quando tutto il corpo è sano e sta bene, a parte una piccola ferita, o, comunque, un punto dolorante, non si ha più coscienza del fatto che il corpo, nel suo complesso, sta bene; l’attenzione è costantemente rivolta al dolore che avverte la parte colpita, e si annulla, in tutto l’organismo, ogni sensazione di benessere. Così, quando tutte le nostre faccende vanno nel senso da noi desiderato, salvo una sola, che va nel senso opposto, è quest’ultima che ci torna sempre in mente, anche se è di scarsa importanza, e pensiamo spesso a essa e poco a tutte quelle altre, più importanti, che procedono come desideriamo. In entrambi i casi, a subire il danno è la volontà, in quanto oggettivata, nel primo nell’organismo, nel secondo nelle aspirazioni dell’uomo; e in entrambi i casi vediamo come la soddisfazione della volontà abbia sempre e soltanto un effetto negativo, e non venga, quindi, percepita direttamente, ma, al più, giunga alla coscienza attraverso la riflessione; il momento positivo, quello che si manifesta direttamente, sta, invece, in un impedimento della volontà. Ogni piacere consiste solamente nella soppressione di tale impedimento, nel liberarsi di esso, ed è, quindi, di breve durata. Appunto su ciò poggia la sullodata massima di Aristotele, che ci invita a non rivolgere la nostra attenzione ai piaceri e agli agi della vita, ma a vedere di sottrarci, per quanto è possibile, ai suoi innumerevoli mali. Se questa non fosse la via giusta, dovrebbe essere falso, mentre, in realtà, è verissimo, quanto dice Voltaire: Le bonheur n’est qu’un rêve, et la douleur est réelle.93 Perciò chi voglia trarre le somme della propria esistenza con riguardo all’eudemonologia non dovrebbe fare il conto delle gioie di cui ha goduto, ma quello dei mali ai quali è sfuggito; e anzi, l’eudemonologia dovrebbe insegnare, per prima cosa, che il suo stesso nome è un eufemismo, e che l’espressione «vivere felici» non vuol dire altro che «vivere meno infelici», vivere, cioè, in modo sopportabile. Comunque, la vita non è fatta per essere goduta, ma è una cosa da sopportare, una faccenda da sbrigare; ciò è espresso anche in taluni modi di dire, come degere vitam, vita defungi,94 o, in italiano, si scampa così, e, in tedesco, man muss suchen, durchzukommen, er wird schon durch die Welt kommen,95 e simili. È un conforto, nella vecchiaia, avere dietro di sé i travagli della vita. Quindi, la sorte più fortunata è quella di chi trascorre la vita senza eccessivi dolori sia spirituali che fisici, e non di colui a cui sono toccate le gioie più intense o i più grandi piaceri: chi volesse misurare da questi ultimi la felicità di una vita si varrebbe di un criterio sbagliato. I piaceri sono e restano fattori negativi; che siano motivo di felicità è un’illusione alimentata dall’invidia a proprio castigo. I dolori, invece, vengono sentiti positivamente; il criterio di misura della felicità della vita è, quindi, la loro assenza. Se, poi, all’assenza del dolore si aggiunge l’assenza della noia, si può dire che, in sostanza, è stata raggiunta la felicità; tutto il resto è una chimera... Ne consegue che non bisogna mai perseguire piaceri che si pagano col dolore: ciò vuol dire pagare con qualcosa di positivo e di reale un bene negativo e illusorio. Si è, invece, in attivo quando si sacrificano dei piaceri per sfuggire al dolore; in entrambi i casi è indifferente se il dolore preceda il piacere o lo segua. Non c’è, veramente, stoltezza più grande del voler trasformare questa valle di lacrime in un luogo di delizie, e del proporsi per meta, come pure fanno molti, la gioia e il piacere, anziché aspirare a un’esistenza il più possibile priva di dolore. Erra assai meno chi, troppo accigliato, guarda a questo mondo come a una specie d’inferno, e si preoccupa soltanto di procurarsi una stanza a prova di fuoco. Lo stolto corre dietro ai piaceri della vita e si ritrova ingannato; il saggio cerca di evitare i mali e, anche se ciò non gli dovesse riuscire, non sarà stata colpa della sua stoltezza, ma del destino; e quando vi riesce, anche soltanto in parte, non si ritrova ingannato, perché i mali che ha saputo evitare erano più che reali. Se poi, per evitarli, avesse fatto un giro troppo lungo, sacrificando inutilmente taluni piaceri, in fondo non avrà perso nulla; perché tutti i piaceri sono illusori, e sarebbe meschino, e anzi ridicolo, rattristarsi per esserseli lasciati sfuggire.
Non riconoscere tale verità, come fa chi indulge all’ottimismo, è fonte di grande infelicità. Quando, infatti, siamo liberi da dolori, siamo agitati da desideri che ci prospettano le illusioni di una inesistente felicità, e ci inducono a perseguirle; in tal modo attiriamo su di noi il dolore, che è, invece una innegabile realtà. Allora rimpiangiamo la nostra condizione di prima, quell’assenza di dolore, che ci siamo lasciata alle spalle come un paradiso perduto, e vorremmo che fosse possibile tornare indietro. È come se, attraverso le immagini illusorie dei nostri desideri, un demone malvagio e astuto cercasse continuamente di attirarci fuori da quello stato, che è la realtà più felice. Il giovinetto inesperto crede che il mondo sia fatto per essere goduto; che sia sede di una felicità positiva che sfugga soltanto a coloro che non sono abbastanza abili per impadronirsene; e in quell’idea è confortato da romanzi e poesie, come pure dall’ipocrisia (su ciò ritornerò fra poco) con cui il mondo, in ogni suo aspetto e in ogni circostanza, si riveste di belle apparenze. Di lì in avanti la sua vita è una caccia, condotta più o meno ponderatamente, alla felicità positiva, che, come tale, dev’essere fatta di piaceri positivi; e ciò lo espone a rischi di cui non si può non tener conto. Quella caccia a una selvaggina che neppure esiste approda, di solito, a un’infelicità, positiva, questa, e molto reale, in forma di dolore, di sofferenze, di malattie, di perdite, di preoccupazioni, di indigenza, di disonore, e di mille altri travagli; e quando si aprono gli occhi è ormai troppo tardi.
Se, invece, secondo la norma qui presa in considerazione, il progetto dell’esistenza è diretto a evitare ogni sofferenza, e dunque a tener lontani il bisogno, le malattie, e ogni travaglio, quella a cui si tende è una meta reale; e in tal caso si può giungere a risultati positivi, tanto più concreti quanto meno quel progetto sarà stato ostacolato dalla ricerca di una chimerica felicità positiva. Con ciò si accorda quello che Goethe, nelle Affinità elettive,96 fa dire a Mittler, sempre preoccupato dell’altrui felicità: «Chi vuole liberarsi da un male sa sempre quello che vuole; chi vuole qualcosa di meglio di ciò che ha ha le cateratte negli occhi». Quelle parole ricordano un bel detto francese: le mieux est l’ennemi du bien. A questo pensiero si può, anche, far risalire l’idea fondamentale della filosofia cinica, quale è stata da me esposta nella mia opera principale (vol. 2°, cap. 16). Infatti, che cosa induceva i cinici a ripudiare tutti i piaceri, se non il pensiero dei dolori più o meno strettamente congiunti con essi? ed evitare quei dolori appariva loro assai più importante che entrare in possesso dei piaceri. I cinici, profondamente convinti del carattere negativo del piacere e di quello positivo del dolore, cercavano in ogni modo di evitare i mali; ma per evitarli ritenevano necessaria una totale e volontaria rinuncia ai piaceri, in cui non vedevano che delle trappole montate per darci in pasto ai dolori.
È vero che, come dice Schiller, siamo tutti nati in Arcadia: che, cioè, ci avviamo alla vita pieni di aspirazioni alla felicità e al piacere, e nutriamo la folle speranza di farle valere. Ma poco dopo ecco che arriva il destino, ci agguanta brutalmente, e ci insegna che nulla ci appartiene, perché tutto è suo; e che ha diritti incontestabili non soltanto su tutto ciò che possediamo e guadagniamo, sulle nostre mogli e sui nostri figli, ma persino sulle nostre braccia e sulle nostre gambe, su occhi e orecchi; e che è suo anche il naso che portiamo in mezzo alla faccia. Poi viene l’esperienza, e, con essa, la capacità di comprendere che felicità e piacere sono miraggi che è dato scorgere soltanto di lontano, e scompaiono quando uno sta per raggiungerli, mentre la pena e il dolore sono realtà; parlano con la propria voce, senza bisogno di intermediari né di essere preceduti da illusioni o da attese. Se l’esperienza ci ha insegnato qualcosa, noi smettiamo di andare in caccia della felicità e del piacere, e pensiamo piuttosto a sbarrare la strada, per quanto è possibile, alle sofferenze e al dolore. Allora comprendiamo che il meglio che possa offrire la vita è un’esistenza priva di dolore, sopportabile, tranquilla, e a quella limitiamo le nostre aspirazioni, per poterle realizzare tanto più sicuramente; e il mezzo più sicuro per non essere molto infelici è la rinuncia a pretendere di essere molto felici. Lo aveva compreso anche Merck, l’amico di gioventù di Goethe, quando scriveva: «In questo mondo ciò che guasta tutto è quella sciagurata pretesa di raggiungere la felicità, e di raggiungerla nella misura da noi sognata. Chi riesce a liberarsene, e non desidera se non ciò che ha davanti, può tirare avanti abbastanza bene» (carteggio di Merck, p. 100). Quindi è consigliabile moderare quanto più è possibile le proprie aspirazioni al piacere, al possesso, al rango, agli onori, ecc.; perché è proprio l’affannosa ricerca della felicità, delle pompe, del piacere, ad attirare le grandi disgrazie. Ma quell’atteggiamento è saggio e opportuno già in quanto essere molto infelici è assai facile, mentre è non soltanto difficile ma del tutto impossibile essere molto felici. È quindi nel giusto il poeta della vita saggia quando dice:
Auream quisquis mediocritatem
diligit, tutus caret obsoleti
sordibus tecti, caret invidenda
sobrius aula.
Saevius ventis agitatur ingens
pinus, et celsae graviore casu
decidunt turres, feriuntque summos
fulgura montes.97
Chi ha assimilato appieno gli insegnamenti della mia filosofia, e perciò sa che tutta la nostra esistenza è qualcosa che sarebbe meglio non ci fosse, e che la più grande saggezza consiste nel negarla e nel rifiutarla, non si aspetterà molto da nessuna cosa, da nessuna situazione; non si sentirà appassionatamente attratto da nessuna cosa al mondo; non leverà alti lamenti a ogni suo insuccesso, ma sarà profondamente compreso delle parole di Platone: oὔτε τι τῶν ἀνθρωπίνων ἄξιoν μεγάλης σπoυδῆς (Rep. X, 604).98 Si veda, anche, l’epigrafe del Gulistan di Sadi:
Se ti è venuto a mancare il possesso di un mondo
non crucciartene: non è nulla.
Se sei venuto in possesso di un mondo
non rallegrartene: non è nulla.
Passano i dolori, passano le gioie,
tu passa davanti al mondo: non è nulla.
(Anwari Soheili)
Ciò che rende particolarmente difficile giungere a questi salutari convincimenti è l’ipocrisia del mondo, di cui già si è detto, e di cui si dovrebbe rendere edotta per tempo la gioventù. Nella loro stragrande maggioranza, gli splendori del mondo sono mere scenografie di teatro, a cui non corrisponde alcuna realtà. Per esempio, le navi imbandierate e inghirlandate, le salve di cannone, le luminarie, gli squilli di tromba e i rulli di tamburo, gli evviva e le urla di giubilo e via dicendo: tutto ciò non è che l’insegna, il simulacro, il geroglifico della gioia; ma la gioia per lo più, è assente; essa sola ha disertato la festa. Là dove compare davvero, essa giunge, di solito, senza essere invitata e senza farsi annunciare; giunge sola e sans façon, strisciando, anzi, silenziosamente, spesso per i motivi più insignificanti e più futili, nelle circostanze più comuni, in occasione di avvenimenti tutt’altro che brillanti o solenni; è sparsa qua e là come l’oro in Australia, secondo il capriccio del caso, senza regola né legge, e per lo più in minuscoli granelli, assai raramente in grandi quantità. Del resto, lo scopo di tutte le manifestazioni di gioia sopraelencate è soltanto di far credere che là sia entrata la gioia; quella è l’intenzione, indurne l’apparenza nella mente degli altri.
Le cose non stanno diversamente quando si tratti della tristezza e del lutto. Come avanza mesto e lento quel lungo corteo funebre! la fila delle carrozze non finisce mai. Ma guardate dentro quelle carrozze: sono tutte vuote. Ad accompagnare il defunto alla sepoltura non ci sono che loro, tutti i cocchieri della città. È, quello, un ritratto parlante di ciò che sono, in questo mondo, l’amicizia e la stima; tali sono la falsità, la vacuità, l’ipocrisia dei comportamenti umani.
Un altro esempio viene offerto da uno splendido ricevimento con tanti invitati in abito da festa; essi rappresentano la nobiltà e la raffinatezza della vita di società; ma invece di quelle si sono dati qui convegno il senso di costrizione, il fastidio, la noia: dove ci sono molti ospiti lì c’è molta plebaglia — anche se tutti quanti avessero il petto coperto di decorazioni.
La vera buona società, infatti, è, dovunque e inevitabilmente, assai poco numerosa. Ma, in genere, le feste e i divertimenti più brillanti e più chiassosi hanno in sé, sempre, qualcosa di vuoto e di stonato; già perché sono in stridente contrasto con l’infelicità e con la miseria della nostra esistenza; e quel contrasto fa risaltare la realtà. È vero che, visto dal di fuori, tutto ciò fa effetto; e quello era, appunto, lo scopo. Dice, molto efficacemente, Chamfort: la société, les cercles, les salons, ce qu’on appelle le monde, est une pièce misérabie, un mauvais opéra, sans intérêt, qui se soutient un peu par les machines, les costumes, et les décorations.99 Lo stesso si può dire delle accademie e delle cattedre di filosofia: sono l’insegna, la parvenza esteriore della saggezza; ma la saggezza, per lo più, ha declinato l’invito, e va cercata altrove. Gli scampanii, i paramenti sacerdotali, la pia mimica, gli atteggiamenti istrionici sono l’insegna, la falsa apparenza della devozione religiosa; e così è per tante altre cose. Quasi tutto, nel mondo, è come una noce bacata: è raro che ci sia il gheriglio, e ancora più raro che sia dentro il guscio. Va cercato in tutt’altro posto, e per lo più lo si trova soltanto per caso.
2) Quando si vuole valutare la situazione di un uomo sotto l’aspetto della felicità non ci si deve chiedere che cosa lo rallegri, ma che cosa lo rattristi; l’uomo, infatti, è tanto più felice quanto meno importanti sono, in sé, i motivi della sua tristezza: per essere sensibili alle inezie bisogna trovarsi in uno stato di benessere; quando siamo infelici non ce ne accorgiamo nemmeno.
3) Bisogna guardarsi dal fondare la propria felicità, condizionandola al soddisfacimento di molte pretese, su di una base troppo larga: l’edificio così costruito crollerà tanto più facilmente, in quanto offrirà assai più occasioni agli infortuni; e questi non mancheranno. Sotto tale aspetto si comporta, quell’edificio, al contrario di tutti gli altri, che stanno più saldamente in piedi quando hanno larghe fondamenta; e perciò il modo più sicuro di evitare una grande infelicità è tenere più basso possibile il livello delle proprie aspirazioni in rapporto ai mezzi, di qualunque specie, di cui uno dispone.
Una delle stoltezze più grandi e più diffuse consiste nel fare, per la propria vita, progetti a lungo termine, in qualunque forma. Prima di tutto, infatti, si conta, così facendo, di vivere per un tempo corrispondente alla durata massima della vita umana; e ciò succede a ben pochi. In secondo luogo, anche per quei pochi, la vita è troppo breve in relazione ai loro progetti, la cui realizzazione richiede sempre assai più tempo del previsto; inoltre...