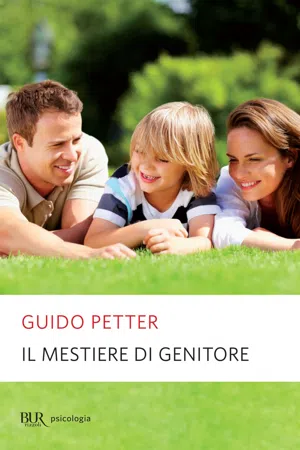![]()
PARTE TERZA
L’ETÀ DELLA SCUOLA ELEMENTARE
dp n="218" folio="218" ? dp n="219" folio="219" ? ![]()
21
ALLA SCUOLA ELEMENTARE
«Mio figlio è in prima, ed è contento. Ma ancor più contenti siamo noi, è stata una liberazione. Finalmente c’è qualcun altro che si occupa di fargli imparare le cose. »
«Mia figlia è in terza. I suoi maestri vorrebbero che anche noi collaborassimo, ma io dico: questo è un compito vostro, no? E poi non voglio interferire con le cose che mia faglia fa a scuola. Finirei col creare della confusione. La scuola di oggi è molto diversa da quella che ho fatto io quand’ero piccola. No, non ci capirei gran che. »
È arrivato il momento in cui nostro figlio fa il suo ingresso nella scuola elementare. È un momento importante. Può darsi che, visto che è vivace, curioso e che ha già imparato molte cose da noi o guardando la TV, ci venga in mente di fargli anticipare la sua esperienza scolastica. Temiamo infatti che, inserito in una normale prima classe, finisca con l’annoiarsi.
1. IL «SALTO DELLA CLASSE»
Che fanno alcuni genitori, in questi casi? Cercano di ottenere che, al momento dell’iscrizione, il figlio venga inserito direttamente in seconda. Per far questo, gli fanno frequentare un corso privato o fanno comunque in modo che impari a leggere, a scrivere e a calcolare un anno prima, mettendolo in grado di superare un esame di ammissibilità alla seconda. È saggio comportarsi in questo modo?
Io penso che la situazione sia più complessa di come questi genitori la vivono, e che occorra riflettere bene e distinguere fra situazioni che possono essere assai diverse prima di prendere una decisione del genere.
È ben vero che vi sono casi in cui in realtà l’anticipo si riduce a pochi giorni o a poche settimane (per esempio, per chi è nato poco prima della data fissata: è questa una situazione in cui la decisione dell’anticipo può risultare ragionevole). Ed è pure vero che l’anticipo nell’acquisizione di conoscenze e di abilità pone il bambino di cui parliamo più o meno alla pari degli altri sul piano degli apprendimenti cognitivi. Questo però non cancella il fatto che egli, sul piano fisico, e spesso anche su quello emotivo e sociale (che è collegato allo sviluppo corporeo, alle abilità motorie, al grado di forza fisica), sia invece in ritardo di un anno, salvo casi particolari di bambini che sono fisicamente più precoci degli altri. E si tratta di un ritardo che permane anche negli anni seguenti. Il bambino che ha fatto il salto rischia dunque di restare per vari anni «il più piccolo della classe», cosa che può sviluppare in lui un senso di inferiorità e creargli difficoltà psicologiche e di socializzazione che divengono assai rilevanti nella scuola media, quando v’è un’accelerazione dello sviluppo e le differenze fra chi è pubere e chi ancora non lo è divengono molto evidenti.
Queste difficoltà sono aggravate se il bambino ha uno sviluppo fisico più lento della media. Come vedremo nei capitoli 35 e 36, vi sono forti differenze individuali nel ritmo dello sviluppo, soprattutto nella preadolescenza: un quarto dei ragazzi sono, più o meno, in anticipo sulla media, un altro quarto in ritardo, mentre i due quarti sono «nella norma». Bisognerebbe dunque per lo meno accertare a quale di queste tre categorie appartiene nostro figlio, prima di prendere decisioni che possono avere effetti collaterali spiacevoli.1
Inoltre, c’è da chiedersi se sia giusto togliere al bambino un anno di quelle esperienze ludiche e ludiformi che può vivere nella scuola per l’infanzia, sottoponendolo a un’attività più disciplinata, come quella richiesta per la preparazione al «salto di classe». E se sia saggio togliergli anche, per tutti gli anni della scuola dell’obbligo, quel senso di sicurezza che gli potrebbe derivare dal fatto di sentirsi «bravo», o «più bravo di altri», e quel piacere di «aiutare gli altri» che di solito lo accompagna, entrambi assai importanti quando un bambino è per sua natura timido e riservato.
Dobbiamo dunque stare attenti, anche a questa età dei sei anni, ai possibili errori. E il «salto della classe» può essere appunto il primo di tali errori, al quale sono esposti i genitori di quei bambini che, per doti naturali e per l’educazione ricevuta, appaiono intellettualmente più vivaci e meglio forniti di conoscenze e di abilità rispetto ai loro coetanei.
2. È GIUSTO DELEGARE TUTTO ALLA SCUOLA?
Un secondo errore nel quale stavolta tutti i genitori possono cadere è quello di credere che, con l’inizio della scuola elementare, ci sarà finalmente qualcuno a cui delegare il compito di occuparsi dell’alfabetizzazione del figlio.
Questo errore è grave, per almeno due motivi. Anzitutto, perché nostro figlio trascorre quattro o cinque ore a scuola, ma rimane per il resto del tempo a casa, tutti i giorni, oltre alla domenica e alle vacanze. Il tempo trascorso con noi è dunque più consistente di quello passato a scuola ed è anch’esso un «tempo educativo», da utilizzare cioè per favorire il suo sviluppo psicologico e culturale. Abbiamo già visto quante cose si possono fare con nostro figlio: dal raccontargli fiabe al conversare delle cose lette, o viste alla televisione, al giocare con lui, all’osservare insieme il mondo della natura e quello umano. E non c’è ragione che non si debba continuare.
Pensare di delegare interamente alla scuola i compiti educativi sarebbe un errore anche per un’altra ragione. Vi sono moltissime attività che cominciano nella scuola ma si prolungano nella vita familiare. Per esempio: a scuola i bambini hanno letto una filastrocca di Rodari; poi la maestra ha spiegato che cos’è una filastrocca, e alla fine li ha invitati a interrogare la mamma, il papà, i nonni, per stabilire quali filastrocche conoscano e ricordino da quando erano piccoli e le ascoltavano anche come ninne-nanne prima di dormire. Il bambino torna a casa armato di buona volontà, pronto con quaderno e matita, quasi come un piccolo giornalista. Possiamo trattarlo con fastidio, o sbrigarci con poche battute, tanto per accontentarlo? O non è più giusto dedicargli del tempo e compiere sforzi di memoria? Oppure: si parla a scuola di come mutano i paesi e le città da un secolo all’altro o anche da un decennio all’altro, e l’insegnante invita poi i bambini a portare a scuola delle vecchie foto del paese dalle quali risulti appunto com’era la vita trenta o cinquanta anni fa. Ogni famiglia ha del materiale di questo tipo. Che dovrebbero fare i genitori? Non certo, credo, imprecare: «La tua maestra è un po’ matta! Invece di insegnarti a leggere e a scrivere!»; oppure: «Mai e poi mai permetterò a queste foto di uscire di casa»; o ancora: «Lascia che lo facciano gli altri, quello che porteranno basterà». Il bambino, infatti, ci rimarrebbe malissimo; e il giorno dopo, a scuola, si sentirebbe diverso dagli altri. Anche qui è dunque giusto aiutarlo nella ricerca, trovare con lui le foto più significative e affidargliele, e chiedere poi che effetto hanno fatto sugli altri, quali osservazioni hanno reso possibili. Lo stesso potremmo dire per altre ricerche, che riguardano i giochi di un tempo, il cielo notturno, la piantina dell’appartamento, gli oggetti che non si usano più e stanno in soffitta, certe trasmissioni televisive, pomeridiane o serali, e così via.
Però non basta aiutare il bambino nelle sue ricerche; bisogna anzitutto cercar di capire la logica che sta alla base di tale attività di ricerca e cioè perché l’insegnante tenda a coinvolgere attivamente i bambini; bisogna capire qual è lo spirito che anima la programmazione degli insegnanti, quali sono i contenuti di quest’ultima, quali i metodi utilizzati, quali gli obiettivi formativi. Solo così, infatti, saremo in grado di aiutare nostro figlio nel modo giusto, senza fare noi i passi che spettano a lui, mettendolo però nella condizione di poterli fare.
Dobbiamo dunque mantenerci sempre informati su quanto si fa a scuola, e seguire e aiutare nostro figlio nelle sue attività di studio e nelle sue ricerche; e dobbiamo a nostra volta informare gli insegnanti degli echi che le esperienze scolastiche hanno nella vita che il bambino trascorre a casa.
Credo dunque importante offrire qui anzitutto una visione d’insieme della nuova scuola elementare. Cercheremo poi di approfondire il discorso e di vedere che cosa possiamo fare per seguire nostro figlio nelle varie aree della sua esperienza scolastica, venendo così incontro a quello che già ora è un desiderio di non pochi genitori.
3. LA SCUOLA ELEMENTARE
Soffermiamoci su quattro aspetti molto importanti.
a) La nuova scuola elementare si pone con chiarezza due obiettivi fondamentali. Il primo è un obiettivo formativo: si tratta di favorire lo sviluppo del bambino in tutti i suoi aspetti (il corpo e le abilità motorie, la percezione, l’intelligenza, la creatività, la capacità di comunicare con gli altri, l’affettività, la socialità, la sensibilità morale, il gusto estetico) avviandolo a diventare un uomo e un cittadino, alla luce dei valori indicati dalla nostra Costituzione. Di quest’ultima va poi tenuto in particolare considerazione l’articolo 3, ove si afferma che «la Repubblica (e quindi la scuola, come una delle sue istituzioni) deve rimuovere tutti gli ostacoli... che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana».
Il secondo obiettivo è quello dell’alfabetizzazione culturale. Si tratta cioè di fornire al bambino le principali forme di linguaggio (quello orale, quello scritto – nella sua lingua, e in una lingua straniera – quello grafico, quelli specifici della matematica, delle scienze o della musica) e tutte quelle conoscenze che possono permettergli di comprendere il mondo in cui vive e di inserirvisi in modo attivo e creativo.
La vecchia scuola insisteva soprattutto sul secondo di questi obiettivi. La nuova invece li considera di pari importanza e strettamente collegati l’uno con l’altro, nel senso che ciascuno di essi può essere raggiunto attraverso l’altro. Per esempio: proprio affrontando in un certo modo lo studio delle scienze o della storia (alfabetizzazione) si promuove in modo efficace lo sviluppo percettivo, intellettuale, sociale (formazione).
b) Gli esperti sostengono che questi due obiettivi possono essere raggiunti più facilmente se la scuola si ispira ad alcuni principi di fondo.
Prima di tutto le attività proposte dalla scuola dovrebbero essere motivanti, cioè tali da suscitare l’interesse dei bambini, la loro piena partecipazione. L’«atmosfera» della scuola dovrebbe essere dunque tale da affascinare i bambini, e tutt’altro che noiosa, come spesso era un tempo: un’atmosfera gioiosa, viva, ricca di novità, di attività stimolanti, e con una piena possibilità, per i bambini, di muoversi e di esprimersi liberamente, di autorealizzarsi. Tutto questo ben si concilia anche con un lavoro faticoso, che un bambino affronterà volentieri se motivato a farlo (proprio come affronta con entusiasmo anche un gioco impegnativo che pur costa fatica).
In secondo luogo, bisogna dare ampio spazio al capire. Tutti i bambini sono potenzialmente in grado di capire e l’insegnante deve dunque trovare le vie adatte per sviluppare queste potenzialità, per mettere cioè i suoi allievi (compresi quelli che incontrano maggiore difficoltà rispetto agli altri) nella condizione di capire veramente ciò che ascoltano o studiano o fanno. Niente dovrebbe essere appreso in modo puramente meccanico, per semplice ripetizione, senza che vi sia anche comprensione. Ciò non significa affatto che non si debba lasciare spazio alla formazione di molti automatismi cognitivi (per esempio, la conoscenza delle tabelline, la tecnica delle operazioni aritmetiche, la memorizzazione di filastrocche o poesie). Gli automatismi, infatti, sono importanti nella nostra vita mentale; ma devono sempre essere preceduti, o accompagnati, da un atto di comprensione.
Un terzo principio consiste nel sollecitare il bambino, in ogni momento, a essere protagonista della sua formazione e della sua alfabetizzazione, ad agire in prima persona. Immagini del bambino come «un vaso da riempire» (di conoscenze) o come «una molle cera» (da plasmare dall’esterno) appartengono al passato. Abbiamo già visto che i bambini sanno scoprire dei problemi, porre delle domande e anche elaborare i dati che l’esperienza offre. La scuola deve stimolare questo loro atteggiamento naturale, aiutandoli a conquistare l’autonomia.
Fra i principi ispiratori vi è poi quello di garantire sia delle forme di convergenza (tutti devono arrivare a possedere certe abilità e certe conoscenze), sia delle forme di divergenza (ognuno deve anche poter sviluppare un suo stile personale, un suo modo tipico di atteggiarsi di fronte alla realtà e agli altri, che lo rendano inconfondibile, gli diano «personalità»).
Voglio infine ricordare anche un principio che riguarda l’organizzazione della classe come una comunità collaborativa, strutturata democraticamente, con largo spazio per la discussione di gruppo e l’assunzione da parte dei bambini di compiti che riguardino la vita di classe. E significativo che vi sia nei programmi una parte intitolata «Educazione alla convivenza democratica»: un’educazione che non può essere svolta solo a parole ma anche – come già si è detto per l’educazione morale – in una forma concreta, vissuta.
c) Altre novità riguardano poi i contenuti. Vi sono discipline che solo pochi anni fa non c’erano, come l’educazione motoria, l’educazione all’immagine, l’educazione al suono e alla musica, e una lingua straniera. Alcune discipline tradizionali si sono arricchite di contenuti (come l’aritmetica, che ha ospitato elementi di logica, di statistica e di informatica) o hanno subito una trasformazione piuttosto radicale (la storia, come vedremo nel capitolo 25, o le scienze). Per ciascuna disciplina c’è poi l’invito ad andare al di là delle semplici notizie, a cogliere anche i loro concetti-base e i metodi che le caratterizzano (a capire cioè come lavora lo storico o lo scienziato o il linguista). E c’è l’invito a realizzare collegamenti fra le discipline (per esempio, l’analisi di un ponte ad arco, compiuta per l’aspetto fisico o geometrico, geografico o storico).
d) Ulteriori novità della nuova scuola elementare riguardano poi la sua struttura organizzativa. Essa non ha più un insegnante unico, ma più maestri, e vedremo più avanti quali sono i vantaggi di questa soluzione. Essa dovrà arricchirsi di aule specificamente attrezzate per le varie discipline (le scienze, l’educazione all’immagine, alla musica, e così via). Dovrà collegarsi col mondo extrascolastico e cioè con le famiglie, con gli enti locali e con tutte le opportunità esistenti nel territorio (biblioteche, musei, fabbriche, eccetera).
Questa nuova scuola non è tutta già esistente, è in buona parte da costruire. E i genitori possono fare p...