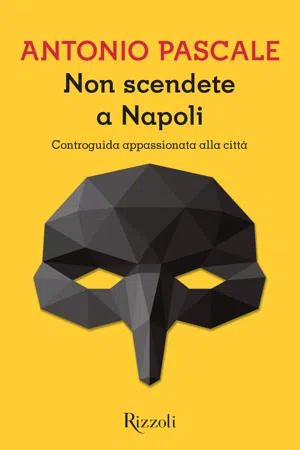![]()
I santi
Il 13 giugno ricevo tanti auguri per il mio onomastico. Non è come il compleanno. Per l’onomastico me ne arrivano molti, e tutti dall’area Napoli-Caserta.
Mi arrivano da persone che non vedo da tempo e mai rivedrò, che tutt’al più posso incontrare durante le vacanze di Natale. Compagni di scuola, colleghi di lavoro, altri, di cui devo leggere più volte il nome e fare mente locale, lasciar perdere ogni attività e concentrarmi solo su quel nome, ripeterlo come un mantra.
Il 13 giugno, Sant’Antonio da Padova, non è un giorno come gli altri, è il mio onomastico, e gli auguri me li fanno tutti, anche vecchi compagni di partito, tra l’altro, atei come me, e cattolici con i quali ho fatto il corso per la comunione.
Non c’è nessun toscano, lombardo, laziale che mi faccia gli auguri, ma ci sono napoletani, casertani che vivono in Lombardia, in Toscana e nel Lazio e che si ricordano di Sant’Antonio da Padova.
In genere, e siccome non ricordo gli onomastici degli altri (San Francesco, Sant’Anna, Sant’Assunta eccetera), non posso usare la stessa creanza che altri usano verso di me, quindi cerco di affrontare la cosa con un po’ di sotterfugi ironici, tipo: noi non crediamo ai santi, ma al Sud…
Poi a pensarci bene, quando nacqui, quarantotto anni orsono, nella mia famiglia ci fu una piccola diatriba. Il lato contadino aveva scelto come santo protettore Antonio Abate, l’altro lato, invece, quello più urbanizzato, preferiva Antonio da Padova.
Per anni non ho indagato sulla diatriba – cose del Sud –, finché non mi è capitato sotto mano un volume molto divertente e agile, Malattie delle piante che segnarono la storia, di Giuseppe Belli.
V’era riassunta appunto la questione.
Sant’Antonio Abate è il santo protettore dal fuoco sacro. Malattia che ora è associata all’herpes zoster, il fuoco di Sant’Antonio, ma prima, e per molto tempo, ha identificato quel complesso di sintomi che vanno sotto il nome di ergotismo. Una di quelle malattie alimentari che ha flagellato l’Europa fin dal Medioevo.
La segala cornuta, insomma. Claviceps purpurea, un fastidioso ascomicete che infetta varie specie di graminacee, ma è particolarmente fissato con la segala.
Le spore del fungo, trasportate da insetti o dal vento, raggiungono i piccoli fiori del cereale e germinano: inizia così il ciclo, trenta-quaranta giorni e il fungo invade la pianta, e infine forma dei piccoli sclerozi (nella sostanza contenitori per spore), a forma di cornetti che sporgono come ombre nere dalla spiga. Da qui il nome di segala cornuta.
Gli sclerozi contengono diversi alcaloidi, tra cui l’ergotossina (somiglia all’LSD).
Se la segala contaminata è ingerita una volta ogni tanto, va bene, si hanno allucinazioni e vari sintomi da intossicazione, ma la continua ingestione porta appunto all’ergotismo cronico, che presenta questi sintomi: gonfiori e forti bruciori a carico soprattutto degli arti, che assumono dapprima colore rosso-violaceo e piano piano vanno verso la cancrena per arresto della circolazione sanguigna, insomma, diventano dei monconi e si staccano dal corpo.
Il famoso quadro di Bruegel, Gli storpi, pare rappresentasse proprio alcuni malati cronici di ergotismo.
Leggiamo un cronista, Sigeberto di Gembloux, 1089: «A molti le carni cadevano a brani, come li bruciasse un fuoco sacro che divorava loro le viscere; le membra, a poco a poco rose dal male, diventavano nere come carbone. Morivano rapidamente tra atroci sofferenze oppure continuavano, privi dei piedi e delle mani, un’esistenza peggiore della morte; molti altri si contorcevano in convulsioni».
Sta di fatto che l’ergotismo ha funestato le campagne francesi e la valle del Reno (857 d.C.) poi, per tutto il Medioevo, Belgio, Olanda, Germania, Russia, Inghilterra (chissà quante cacce alle streghe venivano scatenate per effetto dell’ergotismo, quante donne contaminate e in preda alle convulsioni sono state uccise perché si pensava fossero possedute).
Ora i seguaci di sant’Antonio Abate, un santo antico, III-IV secolo d.C., avevano fondato l’ordine ospedaliero degli Antoniani e, tra le tante cose, si occupavano di lenire le sofferenze dei poveri malati.
Allevavano maiali e usavano il lardo come unguento per le ferite – non per niente l’iconografia prevede sempre un maialino, placido, tra i piedi di sant’Antonio. Dunque, sparsa la voce, in tanti dal Nord Europa venivano nei monasteri italiani per affidarsi alle cure dei monaci e alla protezione del lardo.
Naturalmente che succedeva?
Cambiando Stato o regione, i pellegrini cambiavano anche alimentazione, passavano dalla segala, cereale dei Paesi freddi, al frumento, e guarivano semplicemente perché non si avvelenavano con la segala cornuta.
A parte che ci sarebbe tutto un discorso da fare sui famosi prodotti di una volta, e i sapori tipici del tempo che fu, la Napoli passata eccetera, a parte questo, sant’Antonio Abate è stato considerato per tanto tempo un santo contadino.
Così un giorno, dopo istruttiva lettura del suddetto libro, ho chiesto alle mie zie urbanizzate (ormai molto anziane) perché mai avessero scelto di farmi proteggere da sant’Antonio da Padova, che tra l’altro è stato l’inquisitore che ha sconfitto i catari, e loro mi hanno risposto semplicemente così: «Non c’è paragone, sant’Antonio da Padova fa più miracoli. E di tutti i tipi, sant’Antonio Abate è limitato».
In effetti, le doti miracolose di sant’Antonio Abate, con le innovazioni tecniche in agricoltura e il maggior controllo sugli alimenti, sono venute meno, al contrario, pare che sant’Antonio da Padova faccia sentire ancora la sua influenza in molti settori.
Queste sono state allora le motivazioni. Che spiegano in parte l’importanza di alcuni santi nel Sud Italia. Pensiamo per esempio a uno dei più famosi sketch della Smorfia che vede Troisi chiedere una grazia a san Gennaro.
In proposito, ha valide giustificazioni. Sostiene di essere un buon cliente, di aver rinunciato ad andare nell’altra chiesa, dunque sente di avere il diritto di chiedere al santo l’accelerazione di quella pratica (la grazia, appunto).
La richiesta è però disturbata da Lello Arena, che, a sua volta, avanza la sua postulazione: lui non può lavorare (Troisi sostiene che anche se avesse lavoro non andrebbe a lavorare) e ha bisogno di quei soldi (Troisi fa cenno a san Gennaro che Lello Arena si ubriaca).
Scoppia una lite: Lello Arena gradirebbe vincere, una settimana sì e l’altra no, un ambo sulla ruota di Napoli, 15 e 58, tanto che Troisi durante la discussione avanza il sospetto che Lello Arena sia in realtà devoto a san Ciro.
La turbolenza va avanti, ognuno promette un’attenzione al santo – accendere le candele o seguire una processione – e intanto si scopre che anche Troisi è venuto per chiedere i numeri, 5 e 25. Pur di ottenerli, arriva a minacciare il santo di buttarlo giù dal baldacchino.
Lo scontro è interrotto dall’arrivo del prete Enzo Decaro che caccia entrambi dalla chiesa e, rimasto solo, a sua volta, chiede a san Gennaro un ambo: 6 e 21.
Non furono pochi i napoletani che risero a questo bellissimo e serissimo sketch, molto preciso nel delineare alcune dinamiche di postulazione. Tra l’altro, il giorno dopo lo sketch, qualcuno si giocò davvero i tre ambi proposti dal trio, e per tre settimane consecutive, come vuole la procedura tradizionale.
Santi, santi e santi. Siamo cresciuti devoti a qualche santo. Di generazione in generazione.
Non sono pochi gli antropologi che hanno sottolineato quest’aspetto, e cioè che la maggiore particolarità di Napoli – a parte i filosofi, i caffè, il tempo che si perde allegramente, i pescatori sugli scogli, la camorra, a parte questo – fosse proprio la speciale impronta della santità diffusa e del culto dei santi, un lascito della Riforma cattolica.
Come non sono pochi gli antropologi che hanno citato questo aneddoto raccontato dal medico Paul-Louis Simond nel suo viaggio in Italia e in Sicilia: «È morta la scorsa settimana una religiosa il cui sangue non si è coagulato e per molti giorni si dice che ella abbia conservato l’aspetto della vita. I preti hanno gridato al miracolo; il popolo in processione si è radunato attorno al corpo della beata, e sua maestà – re Ferdinando I – in tutta buona fede è andato come gli altri a mettersi in ginocchio. Una cosa che re Murat non avrebbe mai fatto; non che egli avesse più temperamento di sua maestà legittima, ma aveva quello spirito forte che percorre le vie di Francia e non ammette i miracoli».
È un aneddoto citato molte volte perché sintomatico: c’era un abisso culturale tra l’Europa del Nord, scristianizzata – sarebbe meglio dire che lì la religione era un affare privato – e quella mediterranea.
È vero, Napoli ha avuto la sua rivoluzione illuminista – d’accordo, poi fallita – ma, nonostante il grande spessore dell’intellighenzia filosofica, non sono mai nati dei Voltaire e Diderot capaci di affrontare i santi. Ancora oggi si sente. Altrimenti non riceverei così tanti auguri il giorno del mio onomastico.
La Riforma cattolica ebbe una fortissima accoglienza a Napoli, praticamente la città le aprì le braccia.
Certo le controversie ci sono.
Per esempio, l’episodio raccontato da Simond è rappresentativo del suddetto solco? Da una parte la civiltà, dall’altra la superstizione? Oppure fu una conseguenza di un periodo storico molto vivace e acceso, e dunque con effetti imprevedibili?
Perché, se consideriamo l’accumulo di santi, l’opera devozionale, i re e i viceré spagnoli in adorazione, dobbiamo anche dire che nel periodo cosiddetto barocco, tra il 1540 e il 1640, Napoli (sotto il vicereame spagnolo) raggiunse il massimo della sua potenza, 300 mila abitanti, una vera capitale europea, come Londra o Parigi.
Cereali e olio dai feudi pugliesi, viti e frutta dalla Campania, gelso e baco da seta dalla Calabria, tutta questa mercanzia arriva a Napoli: grande porto e mercato – insomma alcune regioni del Sud presentano i caratteri di un’economia di mercato aperta, globale e redditizia, e in più ci sono tanti nobili e c’è il clero, quanto basta per finanziare la splendida architettura barocca, per esempio in Puglia.
Altro che città arretrata. Semmai città vibrante. Le vibrazioni, si sa, attirano una gran massa di immigrati, ma dove li sistemiamo? Chi dirige i lavori?
Feudatari e grandi ufficiali di Stato all’opera. Anche se fanno poco o niente. In genere, lasciano le loro dimore principesche in provincia, costruite sui cucuzzoli, e scendono a Napoli, ma solo per realizzare altre dimore eleganti. Per loro, s’intende.
E ci credo, si trovano maluccio entro il perimetro delle mura, già particolarmente affollato. E allora spingono verso via Toledo, o verso nord, Chiaia e Mergellina, o a sud, in direzione Porta Nolana.
I ricchi in direzione centrifuga, i poveri centripeta. Chi verso l’aria, chi verso il caldo e movimentato centro della terra: il popolo se ne sta nei quartieri Mercato, Vicaria, Pendino o viene spedito nei famosi quartieri spagnoli, citazione obbligata per ogni intellettuale napoletano in preda a commozione popolare, e non solo loro.
I quartieri diventeranno location cinematografica di tanti film, ricercati perché animano gli inseguimenti tra buoni e cattivi, commissari e delinquenti, per vicoli, vicoletti, scale, blocchi stradali voluti o accidentali, curriculum da esibire per camorristi doc, per fan dei neomelodici vecchi e nuovi.
Se da sceneggiatore o scrittore dovessi costruire un personaggio popolare, come potrei farlo crescere fuori dai quartieri spagnoli? Posso mai raccontare la storia di un poliziotto, faccio per dire un Falco, e di un camorrista, se non gli costruisco un passato in comune di lazzari n’copp i quartieri?
I quartieri spagnoli: un lazzaretto costruito dal viceré spagnolo per ospitare le truppe e poi colonizzato da immigrati poveri, meridionali, francesi, spagnoli, greci, schiavi e musulmani.
E in questo clima promiscuo e sofferto, in questo clima dove il problema del prossimo diventa la sua eccessiva prossimità, Napoli si trasforma in città santa.
Si costruiscono cappelle e cappellette, chiese, ex voto, altarini, monasteri maschili e femminili – 140 monasteri – tutto a spese della nobiltà.
E dovunque reliquie, processioni, liturgie, agiografie, vita e opera dei beati, messe e pratiche religiose. Il tutto nel giro di un secolo, prima in città e dopo anche nelle campagne.
Tutto questo movimento religioso, diciamo, asse pubblicitario della Chiesa tridentina, aveva capito come lottare contro quegli antipatici di calvinisti e luterani, come cioè ridare identità a una religione messa in discussione: attraverso il culto dei santi, appunto.
C’è qualcosa di più forte di un santo?
Ci puoi parlare a tu per tu, come Troisi, Arena e Decaro, nello sketch. Come ci parlavano le mie zie. Puoi fare calcoli strategici, conviene più sant’Antonio Abate o sant’Antonio da Padova? Dipende dalle situazioni.
Sono avvocati, intercedono per le cause, si fanno anche concorrenza tra loro, ognuno ha il suo campo d’azione, più ce ne sono, più il mercato sembra funzionare. Compiono miracoli, guariscono le persone dall’ergotismo.
Insomma, i santi penetrarono, con l’appoggio e i denari dei ceti colti e nobiliari, tra le masse popolari, fra l’altro, masse popolari meridionali, sospettate di paganesimo. E allora quale migliore esempio di forza persuasiva, zelo missionario evangelico?
Jean-Michel Sallmann, in Santi barocchi, ricostruisce con molta precisione e attenzione alle fonti tutti i modelli di santità e le pratiche devozionali a Napoli, in un periodo che va dal 1540 al 1750.
Dimostra come queste pratiche – che ora vediamo eccessive ma si dovrebbero fare le dovute comparazioni: sembrano infatti ancora eccessive, per lo meno a giudicare dal numero di telefonate che ricevo per il mio onomastico e dal culto del Beato Pio – siano andate di pari passo con la prosperità economica. Finché, a prosperità finita – la caduta del vicereame e la peste del 1656, 150 mila vittime, popolazione dimezzata – sono rimaste come un lascito, un’abitudine radicata che arriva fino a oggi.
A un certo punto Jean-Michel Sallmann dice: «Due sono le figure che riscuotono maggiore successo, Sant’Antonio da Padova e la Vergine. Il primo si conferma anche come il santo più popolare e polivalente ed egli gode del sostegno di una fitta rete di monasteri francescani. A Napoli il suo prestigio è tale che nel 1799 viene promosso difensore della fede, della monarchia e dell’ancien régime per essere miracolosamente intervenuto nella cacciata dalla città delle truppe francesi e dei giacobini.» Poi, aggiunge Sallmann, anche la Vergine ha la sua importanza: ricopre il suo ruolo di avvocata universale. Universale perché ha molti titoli – Benevento elegge nel 1700 a propria protettrice la Vergine dei miracoli, Su...