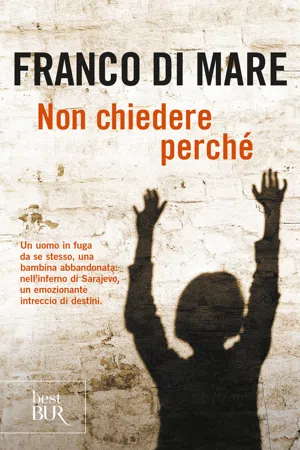Edin
Dicembre 2009
Solo nuvolaglia lì sotto, densa, pastosa e grigia come panna rancida. L’hostess avanzava lenta col suo carrellino di paccottiglie e un mesto sorriso d’ordinanza in cerca di clienti dell’ultim’ora: penne stilografiche, liquori, collanine placcate d’oro, rasoi elettrici, profumi, orsetti di peluche con lo stemma della compagnia per farsi perdonare la dimenticanza di un regalo vero, pensato e cercato, e le immancabili Marlboro, un tempo merce di scambio, la vera carta moneta delle terre che correvano laggiù in basso, seimila metri sotto le nuvole.
Marco si stiracchiò sul sedile, tormentò un po’ la fede, come gli capitava quando era nervoso, appoggiò la fronte al finestrino e guardò giù. Non si vedeva nulla. Neanche uno squarcio, una crepa attraverso cui sbirciare. La coltre compatta nascondeva ogni cosa ma, dopotutto, cosa importava? La prevedibilità delle nuvole era simile a quella del terreno. Gli sembrò comunque di vedere tutto. Lì sotto la macchia mediterranea stava già lasciando posto ai rilievi carsici dei Balcani e di lì a poco, già qualche decina di chilometri oltre la costa, la terra si sarebbe gonfiata, diventando più alta e aspra, e i pini sarebbero spariti, sostituiti dagli abeti. I paesi e le cittadine si sarebbero snodati con una monotonia simile a quella delle nuvole che ne celavano pietosamente la vista: apparivano tutti uguali, una teoria irregolare di casette grigie e fabbricati color polvere con i tetti di tegole.
Non c’era niente da vedere laggiù. Nessun mistero e nessuna rivelazione, conosceva già tutto. Distolse lo sguardo da quell’albume opaco e tornò a tormentare la fede.
L’ultima volta che aveva sorvolato quelle zone si trovava a bordo di un Hercules C-130 dell’Aeronautica militare canadese. Di fronte a lui uomini in mimetica sedevano silenziosi sulle minuscole brandine di tela rossa che correvano lungo le pareti della carlinga, le stesse su cui erano seduti lui e il cameraman. I militari erano armati. Loro due invece portavano zaini, telecamera, microfoni, decine di cassette, cavi e batterie. Indossavano elmetti antischeggia in kevlar come i soldati, ma i loro giubbotti antiproiettile erano blu e portavano una scritta col nastro adesivo bianco, davanti e di dietro, a caratteri grossi, perché si vedesse bene anche da lontano: Press/Novinari, giornalisti, in inglese e serbo-croato. Più che un salvacondotto, era un appello alla pietà dei cecchini serbi. Affidavano le loro vite a quella scritta e alla misericordia di chi l’avrebbe letta attraverso il cannocchiale di un fucile a canna lunga, da caccia all’uomo.
Erano passati molti anni da allora. Il mondo era cambiato. Lui era cambiato. Che cosa ci faceva ora a bordo di un velivolo di linea che era appena entrato nello spazio aereo della Bosnia-Erzegovina?
La telefonata era arrivata mentre si preparava per andare al lavoro. «È per te» gli aveva detto Aurora. «Qualcuno con accento straniero» aveva aggiunto, passandogli la cornetta con la gentilezza frettolosa del mattino.
«Sì?»
«Dobro jutro brate.»
La voce arrochita dal tabacco e ammorbidita dalla šljivovica: Marco non aveva avuto neanche un attimo di esitazione, sapeva benissimo a chi apparteneva. E tutto era così nitido e presente, come se si fossero salutati la sera prima. Sorrise.
«Buongiorno a te, fratello.»
Era il loro saluto, la frase di rito che si scambiavano ogni mattina, lui e Ljubo, davanti a una tazza di turska kafa, in un angolo sicuro dell’Holiday Inn, lontani dalle grandi vetrate che aprivano sulla prospettiva spettrale dei palazzi abbandonati di Grbavica e di Ulica Maršala Tita, il viale dei cecchini, la strada della morte.
Prima dell’ultimo sorso di caffè, Ljubo sistemava nella cartellina sdrucita l’agenda colma di numeri di telefono e indirizzi preziosi e l’inseparabile blocchetto per gli appunti: «E che anche questa giornata vada in culo a Milošević» sentenziava sollevando la tazzina. Era il suo viatico al lavoro, il motto che li avrebbe accompagnati in giro per Sarajevo alla ricerca di notizie e di immagini per il telegiornale, il talismano invisibile che avrebbe vigilato sulla rotta dei loro spostamenti proteggendoli anche quella volta dalle traiettorie dei proiettili e dalle parabole delle granate. Era un rito di cui ridevano, ma che non mancavano mai di celebrare prima di infilarsi in auto e sgommare il più velocemente possibile fuori dal bunker sicuro del garage.
Sarajevo. La guerra in Bosnia. La voce di Ljubo al telefono aveva smosso sedimenti, emozioni e paure dimenticate. Come neve che precipita a valle per un rumore improvviso, quel saluto lontano aveva dato una rovinosa spallata ad anni di ricordi, suoni, sensazioni sepolte che ora travolgevano Marco con la velocità e il furore di una slavina che si stacca dalla vetta dell’Igman.
Quanto tempo era passato dall’ultimo dobro jutro, dall’ultimo caffè preso insieme?
La frase successiva lo strappò all’onda rumorosa dei ricordi.
«Edin sta morendo. Ha chiesto di te.»
Il suo volto gli apparve all’improvviso. Ma chissà per quale ragione la memoria aveva pescato la sola immagine malinconica di Edin tra le mille che stipava da qualche parte nella testa. Lo rivide quella volta che entrò in auto, pronto a partire con la troupe per registrare un servizio, e disse: «Sapete cosa penso? Penso che morire proprio adesso, a un passo dalla fine dell’assedio, proprio quando questa guerra di merda sta per finire, be’, ecco, è una cosa che mi dispiacerebbe davvero molto». Marco e Ljubo lo avevano guardato stupiti. Edin aveva il carattere di un combattente, non si lasciava mai andare a un lamento. Nessuno lo aveva mai visto scoraggiato o, peggio ancora, triste. Mai, neanche una volta. Neppure quando sua moglie e le sue due bambine erano sparite per un giorno intero, bloccate a Skenderija da un bombardamento incessante, e tutti le avevano ormai date per morte.
«Ma va’ là,» gli aveva detto quella volta Marco, rompendo una pausa un po’ troppo lunga e tirandogli una pacca sulla spalla, «quelli cattivi come te non muoiono mai.» Ma la voce gli si era incrinata verso la fine della frase.
Cosa poteva uccidere un uomo che era sopravvissuto a tutto quello?
«Cancro ai polmoni. Cos’altro se no? Troppe sigarette.»
«Cristo...»
«Glielo dicevi sempre che avrebbe dovuto smettere di fumare, ricordi? Se ci penso, non ricordo di averlo mai visto senza una sigaretta all’angolo della bocca.»
«È già stato operato?»
«Hanno aperto e richiuso. Inoperabile, dicono. Si è già esteso alle ossa. Ha metastasi ovunque.»
«Potremmo cercare di farlo ricoverare in Italia. Conosco oncologi molto bravi. Magari si può rallentare la progressione della malattia. La radioterapia e la chemio possono fare miracoli a volte. Che so? Si potrebbe...»
«Marco...»
«... Tentare di ricoverarlo nel polo oncologico del Policlinico...»
«Marco...»
«... Mia cognata lavora lì. Potrei...»
«È troppo tardi Marco, non c’è più niente da fare.»
La voce di Ljubo aveva adesso il tono dimesso e lapidario delle verità ineluttabili. Non ammetteva dubbi né repliche. Marco si arrese.
«Quanto gli rimane?»
«Poco. Qualche settimana forse. Chi può dirlo? I medici allargano le braccia se lo chiedi a loro. Cosa ne sanno in fondo? Però ascolta...»
«Sì?»
«Se pensi di venire, parti prima possibile.»
Le ruote del carrello toccarono la pista bruscamente. L’aereo sussultò, si assestò, abbassò il muso e si avviò verso il terminal. Sarajevo Aerodrom: la scritta era tornata al suo posto. L’ultima volta che l’aveva vista mancavano tre o quattro lettere e le altre erano state usate per fare il tirassegno. Marco alzò il bavero del giaccone. Faceva freddo ma almeno non nevicava. Raccolse il bagaglio leggero e consegnò il passaporto al poliziotto nel gabbiotto. Ricordò che da qualche parte, in un cassetto della sua scrivania, a Roma, conservava ancora un vecchio passaporto pieno di visti. L’ultimo registrava un’uscita da Sarajevo, ma non era ufficiale, era una specie di scherzo inventato dai Caschi blu dell’Onu che gestivano le partenze dei voli militari, i soli autorizzati ad atterrare in Bosnia durante la guerra. La scritta rossa lasciata dal timbro del parà diceva Maybe Airlines: Aerolinee Può Darsi, Aerolinee Chissà. Non c’era inviato di rango che non ne esibisse almeno uno sul passaporto. Quel timbro era come una medaglia al valore, una croce al merito, valeva quanto una cicatrice per un reduce. Chi ne custodiva uno tra le pagine del passaporto poteva vantarsi di essere stato a Sarajevo e, soprattutto, di essere uscito vivo dalla sola città al mondo assediata dai tempi di Stalingrado. Quelli che non erano stati a Sarajevo, semplicemente, non erano veri inviati.
«Izvolite, gospodine De Luca.»
Il poliziotto sorrise consegnandogli il documento.
«H...