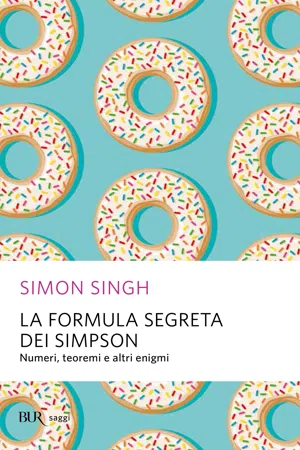![]()
1
Bart, il genio
Nel 1985 l’autore cult di cartoni animati Matt Groening fu invitato a un incontro con James L. Brooks, leggendario regista, produttore e sceneggiatore che aveva realizzato classici della televisione come The Mary Tyler Moore Show, Lou Grant e Taxi e un paio d’anni prima si era aggiudicato tre premi Oscar per la produzione, la regia e la sceneggiatura del film Voglia di tenerezza.
Brooks voleva parlare con Groening di una possibile collaborazione per il varietà televisivo The Tracey Ullman Show, che sarebbe diventato uno dei primi grandi successi dell’appena nata rete Fox. Il programma era costituito da una serie di sketch comici che avevano per protagonista l’attrice inglese Tracey Ullman e i produttori volevano utilizzare dei brevi spezzoni animati per fare da collegamento tra uno sketch e l’altro. La prima scelta per questi cosiddetti bumper era stata una versione animata di Life in Hell («Vita all’inferno»), striscia a fumetti di Groening che ha come protagonista un coniglio depresso di nome Binky.
Seduto in anticamera in attesa di incontrare Brooks, Groening considerò l’offerta che stava per ricevere. Sarebbe stata la sua grande occasione, ma l’istinto gli suggeriva di declinare. Life in Hell aveva lanciato la sua carriera e lo aveva aiutato a superare alcuni momenti difficili, e vendere Binky alla Fox gli sembrava un tradimento nei confronti del coniglio animato. D’altra parte come avrebbe potuto rifiutare un’opportunità tanto allettante? In quel momento, fuori dall’ufficio di Brooks, Groening si rese conto che l’unico modo per risolvere il dilemma sarebbe stato creare dei nuovi personaggi da offrire a Brooks al posto di Binky. La leggenda vuole che egli abbia concepito l’idea dei Simpson nel giro di qualche minuto.
A Brooks l’idea piacque e così Groening creò decine di brevi spezzoni animati che avevano per protagonisti i membri della famiglia Simpson. Gli episodi, della durata di uno o due minuti appena, accompagnarono il Tracey Ullman Show per tre stagioni. Quelle brevi apparizioni avrebbero potuto segnare l’inizio e la fine dei Simpson, ma il team di produzione dello show cominciò a notare uno strano fenomeno.
Spesso la Ullman ricorreva al trucco e a travestimenti incredibili per portare in scena i suoi personaggi e, poiché le riprese avvenivano davanti a un pubblico che assisteva in diretta allo spettacolo, questo costituiva un problema. Per intrattenere gli spettatori mentre l’attrice si preparava, qualcuno suggerì di cucire insieme e mostrare al pubblico in studio alcune delle animazioni che avevano per protagonisti i Simpson. Quegli spezzoni erano già stati trasmessi, perciò si trattava di un semplice recupero di vecchio materiale. Eppure, tra la sorpresa generale, gli spettatori sembravano apprezzare le sequenze ottenute unendo quei brevi spezzoni animati quanto gli sketch recitati dal vivo.
Groening e Brooks iniziarono a chiedersi se non fosse possibile utilizzare le buffonate di Homer, Marge e della loro prole per realizzare un’animazione completa e di lì a poco si associarono allo sceneggiatore Sam Simon per lavorare a uno speciale natalizio. La loro intuizione era giusta. «Un Natale da cani» fu mandato in onda il 17 dicembre 1989 e riscosse un enorme successo tanto in termini di audience quanto di critica.
A quella puntata speciale seguì, un mese più tardi, «Bart, il genio», che si può considerare il primo autentico episodio dei Simpson, dato che vi compariva la famosa e inconfondibile sigla introduttiva della serie – fino ad allora inedita – e che nell’episodio Bart pronunciava per la prima volta il suo celeberrimo motto «Ciucciati il calzino». L’aspetto più degno di nota è però il fatto che «Bart, il genio» contenesse una dose massiccia di matematica. Sotto molti punti di vista quell’episodio decretò insomma lo stile che avrebbe caratterizzato la serie nel corso dei due decenni successivi, in particolare per la presenza costante di riferimenti numerici e di accenni alla geometria che avrebbero fatto guadagnare ai Simpson un posto speciale nel cuore dei matematici.
Con il senno di poi, il sostrato di matematica che caratterizza I Simpson risultava evidente fin da principio. Nella prima scena di «Bart, il genio», gli spettatori scorgono un’immagine fuggevole dell’equazione più famosa della storia della scienza.
Nella scena d’apertura, Maggie sta impilando i suoi cubi con le lettere dell’alfabeto per costruire una torre. Dopo averne sistemati sei uno sopra l’altro, la piccola osserva la pila con gli occhi spalancati. La bambina condannata ad avere un anno per l’eternità si gratta la testa, succhia il ciuccio e ammira la sua creazione: EMCSQU. Non potendo rappresentare il segno di uguaglianza e non disponendo di cubi con i numeri, per Maggie quello era il modo per riprodurre nel modo più fedele possibile la famosa equazione di Einstein E = mc2.
Qualcuno potrebbe sostenere che la matematica sfruttata per la gloria della scienza è, in qualche modo, una matematica di serie B, ma nel prosieguo della storia narrata nell’episodio ci sono in serbo deliziosi bocconcini anche per i puristi.
Mentre Maggie sta rappresentando l’equazione di Einstein con i suoi cubi, vediamo Homer, Marge e Lisa giocare a Scarabeo con Bart, che con aria trionfante piazza sul tabellone le lettere KWYJIBO. Homer non ci sta: la parola kwyjibo non si trova in nessun vocabolario, fa notare infuriato a Bart, che ribatte definendo il kwyjibo «un stupido scimmione pelato del Nord America senza mento…».
Nel corso di questa partita piuttosto litigiosa a Scarabeo, Lisa ricorda a Bart che il giorno seguente avrà un test attitudinale a scuola. Così, dopo il fiasco di kwyjibo, la storia si trasferisce alla scuola elementare di Springfield, dove Bart sta sostenendo il suo esame. Il primo quesito a cui deve rispondere è un classico (e francamente noioso) problema di matematica. Riguarda due treni che partono da Santa Fe e da Phoenix, viaggiano a velocità diverse e hanno a bordo un numero diverso di passeggeri che sembrano salire e scendere in gruppi disomogenei e disorientanti. Bart non sa da che parte cominciare e decide di barare rubando il foglio con le risposte a Martin Prince, il secchione della classe.
Non solo il piano funziona, ma funziona così bene che Bart viene portato in fretta e furia nell’ufficio del preside Skinner per un incontro con il dottor Pryor, lo psicologo della scuola. Grazie ai suoi imbrogli, Bart ha ottenuto un punteggio nel test che indica un quoziente intellettivo pari a 216, e il dottor Pryor si domanda se per caso non abbia scovato un bambino prodigio. I suoi sospetti vengono confermati quando chiede a Bart se trova le lezioni noiose e frustranti. Bart risponde come si aspetta lo psicologo, ma per le ragioni del tutto sbagliate.
Il dottor Pryor convince Homer e Marge a iscrivere Bart al Centro di istruzione avanzata per bambini dotati; inevitabilmente, quell’esperienza si rivela un incubo. Durante la prima pausa pranzo, i compagni di classe di Bart fanno sfoggio delle proprie capacità intellettuali proponendogli baratti di ogni tipo espressi in termini matematici e scientifici. Uno scolaro gli prospetta: «Senti un po’, Bart, vorrei scambiare con te il peso di una palla da bowling sull’ottava luna di Giove preso dal mio pranzo con il peso di una piuma sulla seconda luna di Nettuno preso dal tuo».
Prima che Bart riesca a decifrare le implicazioni delle lune nettuniane e delle palle da bowling gioviane, un altro compagno gli fa una proposta che lo lascia altrettanto confuso: «Senti un po’, Bart, scambieresti mille picolitri del mio latte in cambio di quattro gill del tuo?». È un altro indovinello senza senso, che ha il solo scopo di schernire il nuovo arrivato.
Quando, il giorno dopo, Bart si rende conto che la prima lezione è di matematica, il suo umore peggiora ulteriormente. L’insegnante assegna agli studenti un problema ed è a questo punto che ci imbattiamo nel primo esempio di barzelletta matematica nei Simpson. L’insegnante scrive un’equazione alla lavagna e dice: «Così y è uguale a r al cubo fratto tre, e se voi determinate il tasso di variazione di questa curva correttamente, io credo che resterete piacevolmente sorpresi».
C’è una brevissima pausa prima che tutti gli studenti – cioè, tutti tranne uno – trovino la risposta e si mettano a ridere. L’insegnante cerca di dare una mano a Bart tra gli sghignazzi dei suoi compagni di classe scarabocchiando un paio di suggerimenti alla lavagna. Alla fine scrive per esteso la soluzione del problema, ma Bart è ancora perplesso e così l’insegnante si rivolge direttamente a lui: «Non ci arrivi, Bart? La derivata di y è uguale a tre r al quadrato diviso tre, cioè r al quadrato dr, cioè r dr r».
Lo schizzo alla pagina seguente mostra la spiegazione dell’insegnante. Ho però il sospetto che, pur disponendo di questo ausilio visuale, voi siate perplessi quanto Bart. In tal caso, potrebbe esservi d’aiuto focalizzare l’attenzione sull’ultima riga scritta alla lavagna. L’espressione (r dr r) non è solo la soluzione del problema, ma anche la presunta battuta che scatena l’ilarità della classe. Ciò solleva due domande: perché r dr r è così divertente e perché rappresenta la soluzione del problema matematico proposto?
Quando propone un problema di calcolo infinitesimale in «Bart, il genio», l’insegnante della scuola per bambini prodigio adotta una forma non convenzionale e una notazione incoerente, e fa persino un errore. Tuttavia, ottiene la risposta giusta. Questo schizzo riproduce quanto scritto dall’insegnante sulla lavagna, con la sola differenza che qui il problema di calcolo infinitesimale è esposto in modo più chiaro. Le equazioni importanti sono quelle disposte su sei righe sotto il cerchio.
La classe ride perché la pronuncia inglese di r dr r è har-de-har-har, onomatopea che è stata usata per esprimere una risata sarcastica in risposta a una pessima barzelletta. L’espressione har-de-har-har fu resa popolare da Jackie Gleason, che interpretava il ruolo di Ralph Kramden nella classica sitcom televisiva degli anni Cinquanta The Honeymooners. Poi, negli anni Sessanta, l’espressione divenne ancora più popolare quando lo studio di animazione Hanna-Barbera creò un personaggio a cartoni a cui diede il nome di Hardy Har Har, una iena con un’indole pessimista e un buffo cappellino a tesa stretta che fece coppia con il leone Lippy in decine di cartoni animati.
Dunque la battuta riguarda un gioco di parole basato sulla pronuncia dell’espressione r dr r; ma perché tale espressione è la risposta al quesito matematico? Il problema posto dall’insegnante rientra in un’area della matematica notoriamente difficile che prende il nome di calcolo infinitesimale. Si tratta di una materia che spaventa a morte molti adolescenti e suscita ricordi da incubo in alcuni adulti. Come spiega l’insegnante mentre espone il problema, uno degli scopi del calcolo infinitesimale è «determinare il tasso di variazione» di una quantità, in questo caso y, rispetto a un’altra quantità, r.
Se ricordate qualcosa delle regole del calcolo infinitesimale, riuscirete a seguire la logica della barzelletta senza grandi difficoltà e ad arrivare a r dr r, la corretta soluzione del problema.* Se invece siete tra coloro che ne sono terrorizzati o le cui reminiscenze al proposito provocano incubi, non preoccupatevi: per ora non è necessario che ci imbarchiamo in una lunga e noiosa lezione sull’essenza del calcolo infinitesimale. La questione più pressante, invece, è capire la ragione per cui gli autori dei Simpson decisero di inserire della complessa matematica nella loro sitcom animata.
Il nucleo centrale dei creatori della prima stagione dei Simpson era composto da otto tra i più brillanti commediografi di Los Angeles, gente che desiderava scrivere soggetti in cui comparissero riferimenti a sofisticati concetti tratti da ogni area dello scibile umano. Tra queste il calcolo occupava un posto speciale perché due degli autori erano appassionati cultori di matematica. Si deve a questi due nerd, in particolare, la barzelletta su r dr r e più in generale va a loro il merito di aver fatto dei Simpson un veicolo di freddure matematiche.
Il primo dei due nerd era Mike Reiss, che ho avuto l’opportunità di conoscere quando ho trascorso alcuni giorni con gli autori dei Simpson. Esattamente come Maggie, Mike manifestò fin dalla più tenera età il proprio talento per la matematica giocando con i mattoncini da costruzione. Egli ricorda distintamente il momento in cui si rese conto che questi obbediscono a una legge binaria, dato che due mattoncini più piccoli avevano la stessa dimensione di un mattoncino di grandezza media, mentre due mattoncini medi avevano la stessa dimensione di un mattoncino grande e due mattoncini grandi equivalevano a uno molto grande.
Non appena Reiss fu in grado di leggere, il suo interesse per la matematica si sviluppò in un amore per gli enigmi. Lo affascinavano in particolare i libri di Martin Gardner, il più grande esperto di matematica ricreativa del XX secolo. L’approccio giocoso di Gardner agli enigmi piaceva sia ai giovani sia agli adulti. Per citare le parole di uno dei suoi amici: «Martin Gardner ha trasformato migliaia di bambini in matematici e migliaia di matematici in bambini».
Reiss iniziò leggendo Enigmi e giochi matematici, vol. IV (il cui titolo originale è The Unexpected Hanging and Other Mathematical Diversions) e in seguito spese tutti i soldi delle sue paghette per acquistare altri libri di Gardner. A otto anni scrisse a Gardner spiegandogli che era un suo ammiratore e facendo un’acuta osservazione sui numeri interi che prendono il nome di quadrati palindromi, e cioè che tali numeri tendono ad avere un numero dispari di cifre. I quadrati palindromi altro non sono che numeri quadrati che possono essere scritti indifferentemente da sinistra a destra o da destra a sinistra, come accade per esempio con 121 (112) e con 5.221.225 (22852). L’intuizione di quel bambino di otto an...