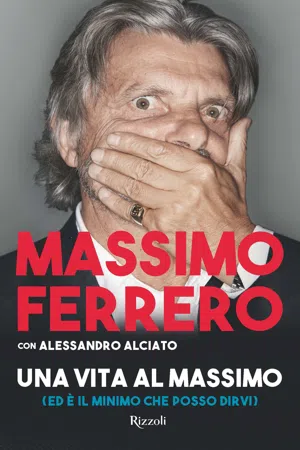![]()
Scena 1
Ambiente: Roma, Testaccio
Scappavo di casa. Non perché il nostro appartamento al Testaccio fosse così brutto, anche se in effetti il nostro appartamento al Testaccio faceva schifo, o perché mamma si giocasse tutto al Lotto, anche se in effetti mamma avesse potuto si sarebbe giocata anche me sulla ruota di Roma. Scappavo di casa perché il mio vicino Giuliano Gemma faceva l’acrobata a Cinecittà, ancora prima che l’attore, e io lo seguivo.
Erano gli anni Sessanta, si giravano cinquecento film l’anno, vedevo passare i signori con la Fiat 1400 e dicevo: «Anvedi questi, sono sfondati di soldi. Li mortacci loro». Mi incantavo a spiare le ragazzine, andavo ai Parioli dove c’erano le parioline, figlie di ricconi, con le gonnelline e le divise. Noi dei quartieri de Roma eravamo dei trucidoni. Ci raccontavano del boom economico ma a me non me ne fregava niente, perché ero uno che sognava di giorno da sveglio, e che la notte scappava per andare a Cinecittà. Già se avevi la bicicletta, dalle parti mie al Testaccio, prima pensavano “Chissà a chi l’ha rubata” e poi te la rubavano per davvero.
Ero un bambino poco alto, avevo appena compiuto dieci anni, andavo in giro per Roma tutto spettinato (e chi li aveva i soldi per comprare un pettine?), dentro di me c’era un pizzico di sana follia, sempre pronta a esplodere. Chi lo direbbe mai, vedendomi oggi… Non mi piaceva andare a scuola, volevo fare l’attore. Volavo con la fantasia. Ma siccome Giuliano volava e basta, considerata la sua attività del tempo, ne ho approfittato. Lui saltava sul trampolino e io saltavo i pranzi, avendo il portamonete sempre vuoto. Praticamente ogni mattina mi svegliavo con un pensiero fisso e non era quello della storia o della geografia o del latino, e a dire la verità neanche della matematica, anche se le tabelline le sapevo a memoria, senza studiarle.
Aprivo un occhio, poi l’altro, avrei dovuto vedere un muro scrostato e invece davanti a me immaginavo un set del cinema, perché mi sono sempre fatto i film, nella mia mente: la sedia di un regista, e poi il suo megafono, e ancora il regista in carne e ossa, e leggermente spostato un copione. Stavo nel letto eppure mi trovavo in mezzo alla scena, illuminato da un potente fascio di luce, perché quel regista stava dirigendo me. Non riuscivo a tenere a bada la mia fantasia, mi piacevano Sean Connery, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Walter Chiari, non volevo diventare come loro, ma mejo. Quindi pigliavo i calzoni, la maglietta e me ne andavo (le scarpe me le infilavo sul pianerottolo sennò mia mamma mi sentiva), mi lavavo il viso nella fontanella, correvo sotto casa di Giuliano con altri tre o quattro ragazzini, fischiavo. Ero felice. Poveri ma belli di Dino Risi, con Maurizio Arena e Renato Salvatori, era già nelle sale da tempo: in quel titolo mi identificavo molto. Pur non essendo bello, ma caruccio. Povero sì, in canna.
Sentivamo la voce di Giuliano dall’alto: «Sono pronto amici miei, sto a scenne».
Scenne, voce del verbo scendere.
Pur essendo un acrobata non si buttava direttamente giù dal balcone, scendeva le scale e insieme andavamo a San Giovanni, da dove tutti i giorni partivano i pullman per Cinecittà pieni di comparse già scelte dagli amici degli amici. La selezione dei soliti noti. Giuliano aveva il pass per lavorare e lo facevano passare, io che ero un illustre bambino sconosciuto venivo maltrattato.
«E basta, vattene a casa, che sei venuto a fare? Vattene affanculo, tutte le mattine sei qui a rompere i coglioni. Ma vai a scuola. A Giova’, stai attento a questo.»
Giova’, cioè Giovanni, era un capogruppo del cinema, addetto a selezionare le comparse – che si chiamavano figurazioni speciali – per i vari film, perché Cinecittà era sempre piena di produzioni e alla ricerca di facce nuove.
Facevo finta di niente: «Ma dai, trovatemi qualcosa da fare».
Quando si voltavano, mi imbucavo nel pullman, tanto ero piccoletto e ci stavo. Raggiungevo Giuliano. Una volta giunto a Cinecittà però mi scoprivano, perché per andare sul set dovevamo passare attraverso la sartoria. Per poterti vestire, in base al tipo di film, avevi bisogno di una marca, una specie di scontrino, che distribuivano proprio i capigruppo a San Giovanni. Ma io non ce l’avevo, essendomi imbucato. Allora correvo, scappavo, entravo lo stesso in sartoria. Cioè un posto fiabesco con vestiti e costumi di ogni genere, di ogni epoca, lì dentro potevi essere gladiatore o extraterrestre, o anche Massimo Ferrero, che nient’altro era che una via di mezzo fra le due cose. Insomma, una gran caciara. Ti trovavi sempre davanti delle signore che erano delle mamme, tutte ciccione e buone, tutte truccate, delle vere matrone, molto romane. Mi sgridavano: «Vattene a casa, ma chi t’ha fatto entra’, a regazzi’?».
Traduzione simultanea dal romanesco: a regazzi’ vuol dire bambino.
Le evitavo: «Ma che volete?». Mi travestivo e rimanevo me stesso, una magia sottile. Funzionava così: dalla sartoria si finiva al trucco, da dove si usciva poi con un altro biglietto, che dava diritto a prendere la paghetta oltre al cestino con dentro dell’acqua e la pagnottella con la mortadella. E io avevo fame. E io avevo bisogno di soldi, perché sennò poi mamma come giocava il 47 sulla ruota di Roma?
Le dicevo: «A ma’, perché giochi sempre ’sto 47 de merda, che non esce mai?».
«Perché è il morto che parla.»
«Ma i morti non parlano, che stai a di’?»
«Leggite un libro, che sei mezzo scemo.» Mezzo solo per via della statura.
Ma quale libro, io avevo voglia di sognare, quindi in qualche modo riuscivo a raggiungerla, quella benedetta sartoria. Chi si fermava era perduto. Mi nascondevo dentro a una delle mille ceste di vestiti che poi gli addetti avrebbero trasportato sui vari set e fantasticavo sulla destinazione finale. Perché se il luogo di partenza era certo, quello di arrivo no, nel senso che le ceste venivano caricate su diversi camion, ma poi dove sarebbero finiti quei camion lo sapeva solo il Signore. Anche se poi quasi tutti finivano ai Castelli Romani. A Frascati, Ariccia, Marino, posti ignoranti. A Marino c’era il vino buono, ad Ariccia la porchetta, a Frascati i francescani. Era tutto un film, anche la realtà. Le prime volte i responsabili delle troupe si incazzavano e mi mandavano via, ma siccome il giorno dopo mi ripresentavo, alla fine sono diventato una specie di mascotte. Andavo a comprare le sigarette per Franco Franchi e anche per altri, certe volte quando tornavo indietro dopo essere stato dal tabaccaro non trovavo più nessuno, perché era finita la scena e gli attori avevano cambiato set. Ero disperato: «E mo come cazzo vado a casa, cosa racconto a mi’ madre?». Le avevo detto che sarei andato a scuola. Mi mettevo sulla strada e facevo l’autostop, non mi prendeva nessuno, allora montavo sulla corriera senza pagare il biglietto e arrivavo a Roma.
Il giorno dopo ricominciava la stessa solfa e andavo a cercare gli attori che il giorno prima non avevo più trovato, avevo ancora le loro sigarette. Se li trovavo bene, altrimenti rivendevo le sigarette a qualcun altro, che mi dava la marca per girare qualche particina. Poi, finalmente, è arrivato il momento mio, il regista Blasetti mi ha scelto e mi ha fatto passare davanti a quattrocento ragazzini, tutti belli, eleganti, raccomandati e ben vestiti, e invece lui ha preso me. Nel provino bisognava fischiettare la canzone del Ponte sul fiume Kwai, tutti erano perfettini anche nel fischiare, invece io l’ho fatto alla pecorara, una versione tutta mia, incasinata ma bella. Mi riusciva piuttosto bene, e poi ero alto esattamente come Saito, il giapponese nano del film.
Ero molto felice di essere stato scelto, anche perché mi avevano preso per il culo in tanti quando dicevo che facevo l’attore. Nessuno mi credeva più. Ho fatto la parte insieme a Giovanna Ralli e sono tornato al Bar Veneto di via Ostiense da trionfatore. Ero l’idolo incontrastato delle ragazzine, andavo verso il juke-box appoggiato al muro, sceglievo la canzone e mi scatenavo, mi esibivo, così chi mi vedeva mi lasciava degli spiccioli oppure mi portava con sé nelle varie discoteche, che in realtà erano delle cantine dei palazzi con della musica. Mi ricordo una certa Elena, che aveva il culone ed era alta, e quando ballavamo insieme io le arrivavo proprio lì. Le mettevo le mani sulle chiappe e partiva Il ballo del mattone.
Invitavo a ballare anche le bambine del quartiere. Andavo forte col tip tap, rimorchiavo un sacco, poi rientravo a casa e mia madre mi menava, anche la domenica. In effetti la domenica era il giorno della festa e io, mentre uscivo di casa, le promettevo con la faccia seria: «Vado dal barbiere, torno fra pochi minuti». Mi ripresentavo tante ore dopo, spettinato più di prima e magari dopo essere passato da Caracalla per sbirciare l’Aida.
Il fatto è che alle due in punto – ogni 27 del mese quando in qualche modo papà tornava con una specie di stipendio – si faceva festa, erano pronte le fettuccine all’uovo, preparate in casa, e il pollo, e a turno noi figli dovevamo scendere alla pasticceria Cristiani, comprare le pastarelle e ritornare in tempo per mangiare le fettuccine. Oltre ad arrivare in ritardo, i soldi per le pastarelle li infilavo nel juke-box.
Altre volte mamma mi diceva di tornare alle sette, io mi presentavo alle sette e dieci e mi menava, allora la volta successiva rientravo alle undici, tanto per essere menato a prescindere almeno mi divertivo e mi prendevo il mio tempo. Nonostante tutto sorridevo. Sorridevo sempre. Mi muovevo dentro un piccolo mondo da scoprire.
Non ho mai cercato la vita, è stata sempre la vita a cercare me, mi sono sempre sentito un ragazzino molto fortunato, e la fortuna aiutava a essere audaci e tenaci, a raggiungere gli obiettivi. Inseguivo l’indipendenza, anche economica. Il tempo passava, a Cinecittà avevo rimediato delle piccole parti, però non volevo fare la comparsa all’infinito, non mi accontentavo, e dato che dovevo campare mi dovevo arrangiare. Aspettando un copione importante, che prima o poi sarebbe arrivato. Ogni tanto uscivo di casa, mi inventavo una storia, pur vivendo fra le nuvole ero cosciente di cosa stesse accadendo là fuori e di quali traguardi volessi raggiungere. Ero improbabile, nature, selvatico, selvaggio, ma sempre me stesso. E siccome di soldi non ce n’erano, tutti i giorni mi inventavo un lavoro e chiamavo gli amichetti miei del quartiere. Li assumevo! Come forma di pubblicità, nelle cassette delle lettere dei vari palazzi arrivavano i buoni sconto, compresi quelli dei detersivi: Ava come lava, Dixan, quella roba lì. Spedivo i bambini che avevo scelto a trattare con i portieri degli stabili, per convincerli a darli a noi invece di infilarli nelle buche della posta. Io poi andavo dai fornari e dai pizzicaroli – fornai e salumieri per chi non conosce il dialetto – a comprare i prodotti con quei buoni sconto e dopo li rivendevo non a prezzo pieno ma con uno sconto minore: per esempio il detersivo costava dieci, con lo sconto lo pagavo sei e lo rivendevo a otto, quindi ci guadagnavano tutti. Chi vendeva, cioè io, e chi comprava. Non volevo grandi margini, mi sono sempre accontentato. Ero un Robin Hood senza pretese, vendevo ai poveri per farli sentire meno poveri. Io, il più povero di tutti. Oppure noi bimbi senza arte né parte ma col pallino del commercio ci davamo appuntamento fuori dai negozi per raccattare il cartone degli imballaggi, lo piegavamo, lo caricavamo su carrettini con le rotelle e andavamo a rivenderlo. Ci davano cinque lire al chilo. Non tenevo quasi niente per me, davo la paghetta a tutti i miei dipendenti-bambini e cantavo: «Casca il gobbo, se rompe la schiena, ariecco Massimino più povero di prima».
Il resto dei guadagni andava infatti a mia madre, con cui avevo una bella complicità, e voglio dire a tutto il mondo: chi c’ha mamma non pianga, che di madre ce n’è una sola. Le portavo a casa i soldi e lei era molto felice. Mi stringeva la guancia e sorrideva: «Bello de mamma». Si infilava le scarpe e correva in ricevitoria. Mi voleva bene, non perché portassi a casa i soldi, ma in generale. Vedeva che mi davo da fare.
Vicino a casa c’erano i Mercati Generali, dove la sera arrivavano i vagoni dei treni pieni di arance e i proprietari dei banchi cercavano gente che le scaricasse. In quanto imprenditore, io prendevo l’appalto, controllavo senza faticare e mandavo i miei dipendenti-bambini a fare quel lavoro. Il padrone della baracca come pagamento ci lasciava qualche cassa di frutta, che noi andavamo a rivendere al Testaccio. E così, come diceva mio nonno: con qualche scudo in saccoccia l’omo campa.
Qualche moneta la tenevo per me e correvo all’Ente Comunale di Consumo, un grande negozio dove vendevano al cinquanta per cento le stoffe di gabardine certificate dal Comune: ne sceglievo un metro per farmi confezionare dei vestiti (pantaloni a campana e giacchetta verde, di solito). Uscivo per vedere il colore alla luce del sole e scappavo, perché ogni volta chiedevo alla commessa: «Posso pagare un po’ a settimana?» e lei rispondeva: «Basta con ’sta storia, se vòi ’a stoffa la devi da paga’ subito sinò te ne pòi pure anna’». Allora io dicevo: «Non te incazza’, scherzo, annamo fuori a vede’ se è il colore giusto». Andavamo fuori, lei ci cascava sempre. Poi me la squagliavo. Correvo via a tutta velocità. Non si facevano crediti, la volta dopo mi ripresentavo, pagavo la stoffa precedente e riscappavo con della nuova stoffa, e via così.
Ho sempre avuto una certa classe nel vestire e direi anche nel vivere. Nel frattempo mi sentivo un figo perché non andavo mai a scuola, secondo me la cultura e il sapere non si imparano sui banchi ma in mezzo alla strada, giorno per giorno. Siccome però era entrata in vigore una legge che rendeva la scuola obbligatoria fino ai quattordici anni, una sera hanno suonato il campanello di casa i carabinieri. Non c’ero, ha aperto mia mamma.
«Non si preoccupi signora, torniamo domani.»
Si preoccupava eccome. E quando si preoccupava, mi menava. Tornando al Testaccio, l’ho trovata ad aspettarmi col bastone: «Domani hanno detto che ti vengono ad acchiappa’, cos’hai combinato stavolta?».
«Mi devono portare a scuola. Mamma, non sei felice? In tutta Italia hanno scelto proprio me, per dare l’esempio. Mi vogliono accompagnare personalmente. E sai perché è capitato a me, a tuo figlio?»
«Eh…»
«Perché mi hanno visto al cinema. Sono un attore importante e attraverso me si vogliono fare pubblicità.»
«Ma che dici?»
«Sì, mi hanno pescato a campione per spiegare a tutta l’Italia l’importanza dello studio.»
«Massimi’, ma stai dando i numeri?»
«No ma’.»
«Peccato allora, perché li avrei giocati volentieri.»
Il giorno dopo i carabinieri si sono presentati davvero alla mia porta.
«Chi è Massimo Ferrero?»
«So’ io…»
Tutto lavato, vestito e infiocchettato, li ho seguiti e sono salito sulla loro auto, una Campagnola aperta di un colore orrendo, un verdone marcio che faceva schifo. Stavo in piedi sulla camionetta, mi sentivo il padrone del mondo. Salutavo le persone ai lati della strada, come fa il papa. Era divertente, come lo erano gli applausi con i quali mi hanno accolto i miei compagni all’arrivo.
Oggi farebbero gli scioperi di classe, per non rispettare quella legge. I ragazzi andrebbero tutti in piazza a manifestare, senza sapere neanche il motivo, soltanto per saltare la scuola, per fare sega, come si dice dalle mie parti. Noi invece, allora, facevamo sega solo per divertirci, ma alla fine in classe ci entravamo davvero. Mi sentivo un re quando Pippo Mazzone, Er Ciafretta, Er Tigre e poi Er Vichingo mi dicevano: «Ahò, ammazza che culo, pure il taxi gratis c’hai. Con gli autisti con il cappello». Gongolavo, m’atteggiavo, ero contento. Mi sentivo come Gigi Nazzica, un malandrino del quartiere, più grande di noi, che ripeteva sempre: «A raga’, sono Gigi Nazzica, so’ bullo e ve lo dico». Noi non sapevamo cosa intendesse, però gli facevamo i cori da stadio: «Scemo, scemo, scemooooo». Si incazzava ma stava al gioco. Era pieno di matti, me compreso, ma mai come il maestro della quarta elementare, completamente esaurito. Ci mandava sempre fuori dalla porta, era disperato, pigliava gli schiaffi sia dagli alunni che dal preside, l’abbiamo mandato fuori di capoccia.
Diceva: «Oggi è il 30 di settembre, questo giorno non verrà mai più». E noi in classe, in coro: «Ma vattene affanculo, chissenefrega». Lui: «Ferrero, ti caccio dall’aula». Uscivo e andavo a rompere li cojoni nelle altre classi, mica stavo in castigo. Poi, a turno, uscivano anche tutti i miei compagni, si autoespellevano dalla classe, e il povero pazzo (che prima di conoscerci era normale) rimaneva da solo, e quando lui veniva a cercarci, rientravamo tutti. Restava comunque solo.
Ogni tanto cambiavano il maestro. Quando uno diventava tutto scemo dava le dimissioni. Ne abbiamo fatti fuori tre o quattro, fino a quando è arrivata Rossana, una ciccionazza con gli occhiali. Stava seduta con le gambe accavallate sotto la cattedra, noi facevamo finta di cader...