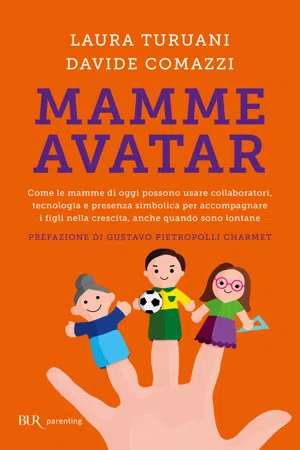![]()
SECONDA PARTE
–
PLAY
![]()
6
Il ritorno al lavoro
Idilliaci o faticosissimi (o più spesso entrambe le cose), i primi mesi dopo il parto sono stati caratterizzati da una relazione di stretta compenetrazione e interdipendenza tra la mamma e il suo cucciolo, guidata da automatismi affettivi e comportamentali che l’hanno resa tanto efficace quanto, se vista con gli occhi della mente consapevole, logorante e intrisa di ambivalenze. La madre ha fatto spazio a quella che si può descrivere come una vera e propria simbiosi, e per qualche mese ha messo fuori dalla porta tutto il resto. Il suo assetto interiore si è dunque fortemente sbilanciato, lasciando uno spazio egemone al Sé materno. Per la donna di oggi, abituata ad architetture complesse di conciliazione tra diversi compiti e diversi Sé, tutti ugualmente preziosi, si è trattato di una condizione inedita, che l’ha assorbita completamente, anche in modo inaspettato. Come ha potuto, proprio lei che riusciva a programmare tutto per non rinunciare a niente e che faceva ogni scelta mantenendo delicatissimi equilibri tra i propri desideri, trasformarsi in una madre tanto coinvolta, quasi sorda di fronte a tutto ciò che non riguarda il suo bambino? Come ha potuto consentire ai propri affetti un’organizzazione tanto asimmetrica e antidemocratica?
6.1
Il patto con se stesse e con il mondo
Probabilmente, la neomamma è riuscita a calarsi completamente in una versione tanto inedita di sé e dedicarsi con simile abnegazione al compito materno proprio perché sapeva che si sarebbe trattato di una condizione temporanea, e che tale periodo avrebbe avuto comunque una scadenza. Prima di mettere al mondo un figlio, infatti, la donna aveva sottoscritto un implicito patto con se stessa e con il mondo, che sanciva senza equivoci la durata limitata della fase in cui sarebbe stata solo madre. Quando ha avviato il progetto generativo era certa di volerlo perseguire, ma era altrettanto sicura che, pur ritenendolo il compito più importante, non avrebbe voluto affidare al ruolo materno il pieno governo e l’intero significato della propria vita.
Adesso che il figlio è nato e ha intrapreso l’avventura di crescere, nella mente della madre si riaffaccia il ricordo di quel patto e delle istanze che l’avevano ispirato.
A volte i termini del tacito accordo tra sé e il mondo coincidono con un pensiero e una volontà consapevoli della donna, che a un certo punto – pur apprezzando le gioie della maternità – comincia ad avvertire il desiderio di tornare a essere anche quella di prima, con la sua vita, i suoi impegni e le sue distrazioni.
Altre volte la mente presenta invece alla madre le sue richieste sotto forma di dati oggettivi, di bisogni concreti, spesso economici, che provengono dal mondo, e sono magari contrari ai propri desideri: «Si deve tornare al lavoro, che lo si voglia o no».
Io sarei stata a casa anche con la maternità facoltativa ma il clima al lavoro da quando ho detto che ero incinta è diventato molto faticoso e sapevo che se avessi prolungato me lo avrebbero fatto pesare tantissimo…
In realtà, anche quando queste esigenze vengono rappresentate come un’imposizione esterna, possono essere sostenute da un’intenzionalità profonda della donna e assumere una valenza psicologica forse inconsapevole ma radicale. Sin dai primi giorni dopo il parto, del resto, l’esistenza di quel patto implicito si è rivelata utile alla gestione dei complessi equilibri materni: in molti casi l’incontrovertibilità della «data di scadenza» del puerperio ha contribuito a stemperare certe ambivalenze, aiutando a tollerare le difficoltà di quella nuova e sconosciuta condizione.
Al terzo ingorgo al seno, mentre allattavo, mi ero messa a pensare al fatto che forse valeva la pena iniziare a svezzarlo, che tanto a breve sarei tornata al lavoro quindi era inutile soffrire per allattarlo una o due settimane in più…
Mi ricordo questi giorni di solitudine sempre uguali, d’inverno, in casa io e lui, in cui mi dicevo: Dài, è già il quinto mese, sei quasi fuori dal tunnel…
Ma con chi è stato stretto e quali sono i termini del patto?
Il primo aspetto in gioco è il lavoro e con esso la possibilità di esercitarsi in un ruolo sociale. Sia che venga visto come un antagonista rompiscatole, sia che corrisponda ai propri desideri, il vincolo con il lavoro non è mai stato in discussione. In alcuni casi si è avvalso della sospensione dovuta alla maternità da un punto di vista psicologico, oltre che pragmatico, ma è rimasto saldo e pronto al reingaggio.
Ero certa che la maternità sarebbe stata una parentesi, anzi, all’inizio la vedevo quasi come una vacanza dal lavoro, che mi ha sempre impegnata moltissimo…
Quando sono rimasta incinta sapevo che avrei voluto dedicarmi a mio figlio il più possibile, ma temevo anche gli effetti di un’assenza troppo prolungata dal lavoro. Avevo paura di perdere i contatti, e il ruolo che mi ero conquistata con fatica…
Si tratta insomma di un patto solidissimo, assolutamente da onorare: di fatto, sono oggi pochissime le donne che – in seguito alla maternità – lasciano il lavoro per scelta, per stare vicine ai figli, come invece pareva scontato fino a qualche decennio fa. Certo, c’è la realtà concreta: spesso lavorare è necessario, e non ci si può permettere il lusso di essere casalinghe e madri, soprattutto in tempi di crisi. Ma non si tratta solo di questo. La donna che, se è fortunata, ama il proprio mestiere, sa che lavorare, oltre che un piacere, è comunque un privilegio, per quanto faticoso. Lo sa perché sente che il lavoro, più ancora che una conquista sociale, è una conquista psicologica: vi sono state investite energie e riversate ambizioni, ed è tempo di raccoglierne i frutti.
Il raccolto ha a che fare con un grande guadagno semantico, ovvero con la possibilità di dare alla propria esistenza la maggiore ricchezza di significati possibile. Rivendicando il diritto di lavorare, la donna difende dunque il privilegio conquistato di esplorare la vita e farsi fecondare da tutte le possibilità di senso che essa contiene. Da questo punto di vista, prima di essere un ostacolo concreto, la maternità è un nemico psicologico dell’investimento lavorativo perché, armata com’è delle sue logiche naturali e del suo senso altissimo, si fa strada con facilità nella mente femminile, puntando ambiziosamente a pervadere e saturare ogni ambito dell’esperienza. Su questo punto, la natura e la cultura dei nostri tempi si scontrano. Come in altre circostanze nello sviluppo della specie, la cultura ha la possibilità di mitigare le rigidità della natura dando vita a convenzioni più democratiche, che possono anche rivelarsi più utili e funzionali per la natura stessa. Qualcosa di simile è accaduto con la nascita della figura paterna, che molti ritengono essere un prodotto della cultura,12 ma che ha chiaramente avuto enorme utilità per l’evoluzione della specie umana.
Nello scontro tra natura e cultura intorno all’esercizio del ruolo materno, si fronteggiano le richieste ineludibili dell’istinto di cura e le nuove interpretazioni di quel ruolo che le stratificazioni culturali hanno costruito nel corso dei secoli. Nel nostro caso, a correre in soccorso della donna alle prese con la pervasività del codice materno è la cultura narcisistica, che con il suo imperativo categorico della ricerca, spesso affannosa, di una «Grande Bellezza», ovvero di una bellezza assoluta, e dell’autorealizzazione a tutti i costi, chiede alte prestazioni in tutti i campi e pretende una piena democrazia tra le istanze interiori. La vera grande bellezza è dunque multiruolo: bisogna saper fare molte cose, e tutte assai bene. La logica dell’approfondimento di un’unica possibilità di significazione non convince né la donna che ha lottato per la conquista delle pari opportunità, né la cultura narcisistica, perché non è compatibile con la ricerca di una bellezza di livello superiore che è data dalla completezza dei Sé. Il sacrificio che il Sé materno chiede con toni di assolutezza trova quindi schierate imponenti forze di pace a contrastarlo.
È vero però che anche la spinta della cultura narcisistica può diventare una gabbia che impone troppe regole, che chiede un estremo perfezionismo e non consente alcuna forma di approssimazione. La ricerca spasmodica della realizzazione dei molteplici Sé aiuta a difendersi dalla pervasività del codice materno, ma per la donna rischia di diventare, anziché una forza di pace, un ingannevole e più subdolo «esportatore di democrazia», che in realtà mantiene alto o addirittura alimenta il livello del conflitto interiore.
Quando ho ricominciato a lavorare c’è stato un momento tremendo in cui non mi sentivo brava in niente, ma sempre in ansia o in colpa. Lasciavo mio figlio al nido prestissimo, al lavoro facevo di tutto per rendermi disponibile ma non mi consideravano per progetti complicati o a lunga scadenza perché mi dicevano che il bambino si sarebbe ammalato tantissimo e quindi non ero affidabile, non riuscivo più a vedere le mie amiche perché mi scapicollavo a casa il prima possibile e quando venivano a casa il bambino era l’unico protagonista, con mio marito non riuscivamo a fare un discorso di più di 30 secondi senza essere interrotti da pianti o suoi bisogni e in più non mi entrava ancora nessun vestito di prima della gravidanza…
Un’altra dimensione costitutiva del patto è quella che riguarda il Sé femminile e la coppia.
Il desiderio di tornare a sentirsi bella, a piacere e piacersi, è sempre stato presente nella mente della neomamma, anche quando lei era così presa dalla cura del cucciolo da non riuscire nemmeno a farsi una doccia. Il Sé femminile, per qualche tempo reso silente dalle necessità del figlio, torna pian piano a far sentire la propria voce nella frustrazione davanti all’ago della bilancia che non scende, nel desiderio di tornare in palestra e dal parrucchiere, o nella segreta gioia dell’epico momento in cui s’indossano di nuovo i propri jeans. I pensieri di questo tipo, che uno sguardo superficiale potrebbe liquidare come fissazioni estetiche, hanno invece un significato ben preciso: ricordano alla donna l’importanza e la sensatezza del proprio progetto femminile, la preziosità di ciò che ha coltivato con tanta dedizione prima di diventare madre, e che non deve andare perduto.
Le rivendicazioni del Sé femminile implicano anche una grande considerazione per la coppia: un altro oggetto che la donna ha devotamente costruito e molto curato nel corso del tempo e che cercherà di non sacrificare sull’altare della maternità. La bellezza dell’antico progetto amoroso è imponente, e il patto sottoscritto con il compagno chiede a gran voce il ritorno della donna e dell’amante. La «scontatezza» con cui si delinea l’opzione del rientro al lavoro, nel linguaggio segreto della coppia vuol dire molte altre cose:
Con mio marito prima non ne abbiamo mai parlato. Si dava assolutamente per scontato che sarei tornata al lavoro… e che pian piano avremmo anche un po’ ripreso le abitudini di prima.
Tra i due esisteva l’implicita comune convinzione che lo sbilanciamento e la riorganizzazione degli equilibri imposti dalla maternità avessero senso solo entro una dimensione temporale limitata. Il padre ha condiviso sin dall’inizio ogni dettaglio del progetto, mettendosi al suo servizio: ha collaborato con la madre alla cura del cucciolo, cercando in ogni modo di alleviarne la fatica, ma sempre attendendo il ritorno della sua partner, dell’amante che era stata e della sessualità di coppia. Non è impaziente, perché desidera anche essere papà, ma non può e non vuole mettere a tacere del tutto il maschio che è dentro di lui. Anche lui deve onorare, in un certo senso, un implicito patto di conciliazione, che nel suo caso è contrario e speculare a quello femminile: l’istinto lo chiamerebbe a essere solo maschio, mentre la cultura lo invita a essere anche un padre.
Comunque siano andati i primi mesi, la donna aveva dunque firmato un compromesso tra sé e il mondo, e ora si avvicina il momento del rogito. A un certo punto, infatti (a volte quando si concludono i nove mesi di esogestazione, a volte prima), nella mente della donna suona un campanello, come fosse arrivata la mezzanotte per la madre-cenerentola. Per com’è stato configurato il patto, quello che si avverte è un richiamo a più voci, che convergono in una sorta di canto interiore, potente e non rinviabile: il richiamo degli altri Sé (il Sé femminile, il Sé sociale, il Sé professionale) che chiedono alla donna di non lasciarsi catturare dal solo desiderio materno e di non esaurirsi in quel ruolo. L’alleanza culturale e psicologica che questi Sé stringono tra loro, ascoltando sia le richieste del mondo esterno sia le esigenze del mondo interno che abbiamo descritto, avvia un rituale di progressivo ritorno alle precedenti abitudini, che inizia ben prima della ripresa del lavoro e forse ne è una forma propedeutica. Le modalità e i tempi con cui esso si esprime sono ovviamente soggettivi, ma ciò che li accomuna sembra essere proprio la loro qualità di «prova», di primo tentativo organizzato per convincersi che qualche micro-separazione è possibile, forse persino piacevole, anche se non si riesce mai a godersela fino in fondo.
La prima volta che sono andata dal parrucchiere, per star via due ore mi ero tirata talmente tanto latte che sembrava partissi per due giorni…
Io e mio marito abbiamo festeggiato la prima cena fuori molto più del primo dentino… anche se poi l’abbiamo passata quasi interamente a parlare del bambino…
Si comincia insomma a sperimentare piccole distanze, per prepararsi alla grande separazione che avverrà di lì a poco.
Comunque venga vissuto questo cruciale passaggio, è inevitabile che la mente materna sia occupata da spinte conflittuali: quel che si prospetta è un riassetto degli equilibri di un governo interiore, ed è assai raro che avvenga senza attriti e oscillazioni.
La diversa intensità con cui la madre di oggi avverte ciascuna delle voci che la richiamano, o – in altri termini – la forza della propria identificazione con ciascuno dei Sé coinvolti, determina la qualità dei sentimenti prevalenti in questo periodo delicato. Se il regista principale della sua mente è ancora il Sé materno, il presagio della lontananza dal cucciolo diventa l’organizzatore di ogni pensiero e la getta in uno stato simile alla disperazione.
Non volevo rientrare, al solo pensiero vedevo il baratro. Soffrivo all’idea di dover dedicare tempo a una cosa che per me era diventata molto meno importante…
Se avessi potuto, non avrei lavorato più. Quando ci pensavo stavo male, il distacco mi sembr...