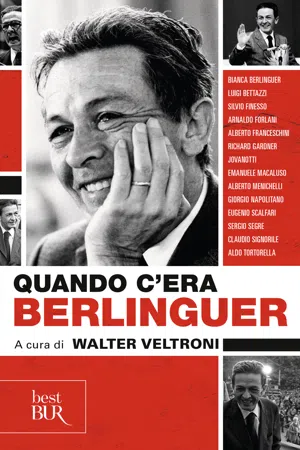![]()
1
Bianca Berlinguer
Mio padre
Papà ha sempre tenuto nettamente distinta la vita privata dalla vita pubblica. Anche se non ne abbiamo mai parlato esplicitamente, credo che questa sia stata una scelta giusta. Era un uomo sobrio e misurato, e aveva pudore dei propri sentimenti: sia nell’esprimere felicità che malinconia. Perciò ci ha sempre protetto dallo sguardo indiscreto degli altri.
La sua personalità fu segnata dalla morte prematura della madre, preceduta da lunghe assenze e vuoti, determinati da una malattia, encefalite letargica, che la fece scomparire via via dalla vita dei suoi figli ancora bambini. Quando è morta, papà aveva solo quattordici anni e io ho sempre sentito dire dalle zie, che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, che quel dolore profondissimo lo aveva condizionato in maniera indelebile.
Da quel momento, papà, zio Giovanni e nonno si erano legati moltissimo tra loro. Quando, nel 1969, mio nonno morì, fu la sola volta in cui vidi papà piangere. Da questo forse il suo carattere introverso. E tuttavia questi suoi tratti di riservatezza e di serietà non devono far pensare in alcun modo che fosse una persona triste.
Al contrario poteva essere estroso e molto allegro ma la sua allegria era sempre misurata, mai chiassosa e mai ostentata.
Ricordo tanti momenti di gioia della nostra infanzia. Il tempo a disposizione non era molto, è vero, però quando stavamo insieme, lui era tutto per noi: non c’erano distrazioni o impegni politici. Quando eravamo bambini, ogni volta che poteva, trascorrevamo la domenica insieme. Uscivamo la mattina per rincasare la sera, si organizzavano escursioni che duravano l’intera giornata. Sceglieva attività che ci piacevano, e che credo piacessero anche a lui. Per esempio andavamo a fare delle gite fuori Roma, sempre in luoghi un po’ impervi. Dovevamo camminare a lungo, portavamo i panini, facevamo i picnic. Tutte cose che i bambini adorano. Andavamo spesso al lunapark dell’Eur e per noi era una grande festa, visto che c’erano tutti i giochi possibili e immaginabili. Un altro appuntamento fisso, quando arrivava a Roma, era il circo di Liana Orfei, diventata poi un’amica di famiglia. L’ultima volta che ci siamo andati era il 1984, pochi mesi prima della sua morte. Alle gite domenicali si univa spesso zio Giovanni con i suoi tre figli che avevano la nostra stessa età.
Un’altra abitudine sempre rispettata, quando papà si trovava a Roma, era quella di pranzare tutti insieme molto tardi, tra le 14,30 e le 15,00, perché a quell’ora finiva la sua mattinata di lavoro. Quando lui se n’è andato, è stata dura abituarsi a non ricevere più la telefonata che annunciava il suo arrivo imminente: perché, intorno a quel tavolo da pranzo, per anni eravamo cresciuti, ci eravamo informati l’uno dell’altro, avevamo fatto domande e ricevuto risposte, litigato e urlato, eravamo stati una vera famiglia. Una famiglia numerosa, con i problemi di tutte le famiglie ma molto molto legata.
Siamo sempre andati in vacanza insieme. Anche quando eravamo grandi, almeno quindici giorni li abbiamo sempre passati con loro. D’estate andavamo in Sardegna, e da piccoli a volte capitava di partire scaglionati perché c’erano spesso crisi di governo tra luglio e agosto. Quando era tutto pronto per andare a Stintino, capitava che ci dicessero: «Non si parte più». Noi figli andavamo ospiti da famiglie amiche e papà e mamma ci raggiungevano appena possibile. Allora a Stintino c’era poca gente e pochissimi turisti: nessun albergo e rari negozi. Ci si conosceva tutti perché si andava lì da sempre. Era molto bello perché trascorrevamo intere giornate sulla barca a vela, quella di Paolo, il cugino di papà, che la lasciava a noi quando tornava al lavoro, a Sassari.
Sin da bambino, papà amava il silenzio del mare e il vento forte. A Stintino si usava veleggiare sulle imbarcazioni dei pescatori, gozzi di legno con la vela latina che, non avendo la deriva, venivano zavorrati con grandi pietre. Tutti fin da piccoli siamo stati abituati a manovrare quelle vele. Si stava in barca fino alle nove, nove e mezzo di sera e poi si tornava a casa. Per papà, il maestrale e il mare grosso erano una sfida. Quando il vento era particolarmente intenso, lui, Paolo e pochi altri si avventuravano e due, tre volte sono tornati con fatica e con le vele strappate. Mamma ci scherzava su: «Papà dice sempre che se potesse scegliere come morire vorrebbe che accadesse in mare e continua a provarci seriamente». Certo che amava davvero il mare e la barca e voleva stare sempre al timone, perché è lì che si decide la rotta: «Tira su il fiocco, arma la vela, metti i terzaroli».
Si andava soprattutto all’Asinara, dove si poteva sbarcare perché all’epoca i detenuti di quella colonia penale non erano considerati pericolosi. Altre volte scendevamo sull’isola Piana, uno scoglio in mezzo al mare lungo un chilometro e ottocento metri che mio padre aveva ereditato dalla madre che l’aveva acquisita dopo un’asta. Siccome era affittata a pascolo ed era piena di zecche, appena tornavamo in paese dovevamo fare subito il controllo della testa per evitare di averne presa qualcuna. Su quell’isoletta fu costruita una sgradevole speculazione che addolorò mio padre. Gli venne attribuito il possesso di un bene di chissà quale valore e con esso di innumerevoli proprietà terriere in Sardegna.
Partecipavamo ogni volta che si poteva anche alla sua vita pubblica. Fin da bambini, naturalmente quando non c’era scuola, lo seguivamo anche alle manifestazioni, ai congressi, ai comizi. Per evitare ingiustizie tra di noi, facevamo i turni, una volta partiva uno, una volta un altro e poi un altro ancora.
A casa nostra si è sempre parlato di politica. Le discussioni potevano farsi vivaci sia tra noi e papà sia tra papà e mamma, che teneva molto alla sua autonomia di giudizio.
Si discuteva, però papà non si opponeva mai alle nostre scelte, non ci ha mai imposto le sue aspirazioni, ci rispettava, insomma. Non credo che coltivasse un progetto preciso per noi. Quando è morto, io che ero la più grande avevo ventiquattro anni, e la più piccola, Laura, appena quattordici. Qualche anno prima avevo già deciso di fare la giornalista. Non so se fosse proprio quello che si augurava per me, ma io glielo avevo annunciato. E lui non aveva mostrato né grande entusiasmo né aperta disapprovazione. Mi aveva consigliato di studiare l’arabo e io per due anni ci ho anche provato ma, devo dire, senza alcun beneficio. Sia lui che mamma ci tenevano a che fossimo bravi a scuola, ma non sempre lo siamo stati e abbiamo avuto, come tutti i ragazzi, i nostri momenti di difficoltà.
Papà partecipava alla nostra vita scolastica come poteva. Ci aiutava in storia e filosofia, le due materie che amava. Per tutta la vita, ha sempre cercato il tempo per leggere e rileggere testi di filosofia e la grande letteratura classica. A volte tornava tardissimo la sera, all’una di notte, e per aiutarci si metteva sui libri anche a lungo.
Quando frequentavo l’università, appena finito un esame gli telefonavo e Anna, la sua segretaria, qualunque fosse la riunione in corso, mi rispondeva: «Te lo passo subito. Aspettava questa chiamata».
Gli capitava raramente di perdere la pazienza. Succedeva quando noi figli, ancora piccoli, litigavamo in continuazione. O quando, tornato a casa per dormire venti minuti, lo svegliavamo con le nostre urla.
Siamo andati spesso insieme all’estero. Nel 1979, in Unione Sovietica. Erano gli anni del terrorismo. Non potevamo recarci in Sardegna perché la casa che affittavamo non veniva considerata sicura. Avevamo passato due estati all’Elba, ma era stata una vacanza molto difficile perché eravamo costretti a vivere come blindati. Così decidemmo di andare in Unione Sovietica e papà subito prima di partire ci disse: «Ricordatevi che in questi Paesi ci sono microfoni dappertutto, dunque attenti a quello che dite». Nelle residenze ufficiali che ci venivano assegnate, per parlare liberamente andavamo in giardino oppure per strada, luoghi dove non era possibile collocare microfoni. Ricordo molto bene quel viaggio, che durò quindici giorni e toccò Jalta, Mosca e Leningrado, l’attuale San Pietroburgo. Avevo diciannove anni ed ebbi dall’inizio alla fine la sensazione inequivocabile di una grande freddezza dei sovietici nei confronti di papà e di papà nei loro confronti. Una percezione palpabile e un gelo anche umano oltre che politico. I dirigenti del Pcus che incontravamo non perdevano occasione di fare battute che sottolineavano la distanza tra loro e il Pci. Io avvertivo che il fossato era ormai incolmabile, anche perché non si trattava di una tensione recente. Già due anni prima in un intervento in occasione del sessantesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre a Mosca mio padre fece un discorso di radicale rottura dove affermò che il Partito comunista italiano voleva realizzare il socialismo, nel pieno rispetto di tutte le libertà democratiche individuali e collettive, compresa quella religiosa. E un decennio prima, nel 1969, durante la conferenza dei partiti comunisti aveva già espresso posizioni autonome.
Dunque, nel 1979 il distacco dall’Unione Sovietica era ormai definitivo e se tardò ancora a renderlo esplicito fu per una costante e direi drammatica consapevolezza della necessità di portare l’intero partito su tale posizione, senza correre il rischio di rivolte interne o di scissioni laceranti.
Nella villa dove ci avevano sistemato a Jalta, c’era un notevole apparato di sicurezza. Il controllo era soffocante: fino al punto di voler decidere dei nostri bagni, proibiti se il mare era un po’ mosso. In quel caso, se ci avvicinavamo all’acqua ci gridavano: «Berlinguer, no!!!» (ci chiamavano tutti Berlinguer). Noi, ancora adolescenti, ci lamentavamo: «Non ci fanno fare neanche il bagno». Allora papà si metteva a capo della nostra piccola rivolta, si immergeva lui per primo, seguito da tutti noi. E gli uomini della sicurezza a quel punto erano costretti a tuffarsi anche loro.
A Sofia invece era andato da solo, nell’ottobre 1973. A casa si parlò più volte di quell’incidente, avvenuto l’anno dopo la nomina a segretario e che per la sua dinamica gli apparve da subito molto sospetto. Nei Paesi comunisti, infatti, quando si muovevano i dirigenti tutte le strade venivano sgombrate e sorvegliate. Poi passava la polizia con la sirena. Quella volta, lui raccontò che immediatamente dopo il passaggio della macchina della sicurezza, da una strada laterale sbucò all’improvviso un camion militare che centrò in pieno, in quel lungo corteo di automobili, proprio quella dove sedeva papà. L’auto andò a sbattere contro un palo e si fermò sul bordo di un cavalcavia. L’autista fu ferito gravemente e l’interprete seduto vicino al lui morì. Papà ne uscì miracolosamente illeso, però aveva sbattuto violentemente la testa. I bulgari gli dissero che avrebbe dovuto restare ricoverato in osservazione per 48 ore. E lui, che già sospettava, rispose che avrebbe dovuto fare un comunicato pubblico per spiegare in Italia quanto era successo e giustificare il ritardo del suo ritorno. Appena accennato alla possibilità di rendere pubblico l’incidente, i dirigenti comunisti accettarono l’immediata partenza.
Già dalla Bulgaria per telefono manifestò a mamma i suoi sospetti e arrivato in Italia ne parlò apertamente con Emanuele Macaluso che aveva dimostrato di credere assai poco all’incidente, decidendo comunque – in assenza di ulteriori prove – di non rendere noto quanto sospettavano.
Con gli anni del terrorismo la vita di papà cambiò radicalmente. Non poteva uscire senza la macchina blindata e aveva una scorta molto consistente, soprattutto quella del partito, che provvedeva alla vigilanza del segretario sia sotto casa che durante i suoi spostamenti. Di conseguenza, anche la nostra vita dovette cambiare. Pure uscire una sera a mangiare una pizza, diventava complicato perché implicava che altri dovessero sacrificarsi per proteggerci. E così tutte le feste, i Natali, le Pasque, da allora le passammo sempre a casa nostra e non più come in passato dalla nonna. A quel punto, fu inevitabile che, con grande semplicità, gli uomini della vigilanza entrassero a far parte della nostra famiglia. E Alberto Menichelli e poi Dante Franceschini, Pietro Alessandrelli, Lauro Righi, Roberto Bertuzzi, Luca Neri, Alberto Marani e Otto Grassi oltre a tutelare la vita di papà, divennero amici, quasi parenti.
I miei genitori tuttavia furono bravi nel far pesare il meno possibile su noi la tensione di quanto stava succedendo. Cercarono, e ci riuscirono, di farci fare una vita molto simile a quella dei nostri coetanei. Anche nei momenti in cui arrivavano segnalazioni o minacce riguardanti non solo lui ma anche i familiari, non c’è mai stata drammatizzazione. La prima preoccupazione era sempre quella di tranquillizzarci e in ciò mia madre fu saggia almeno quanto mio padre.
L’unica volta in cui si parlò esplicitamente di un possibile attentato nei confronti di Berlinguer, fu durante il sequestro di Aldo Moro. Credo che quelli siano stati i giorni più drammatici della sua vita politica, anche sotto il profilo umano. Il rapimento del leader della Dc durò cinquantacinque giorni e furono durissimi per tutti. Mio padre non ha mai avuto esitazioni riguardo la linea della fermezza, perché riteneva che una trattativa con i terroristi avrebbe legittimato le Brigate rosse come soggetto politico e interlocutori dello Stato. Pensava che questo fosse un errore gravissimo e un oltraggio per tutte quelle famiglie colpite dal terrorismo. Quando giunsero le lettere di Moro, così umane e così giustificate in quelle condizioni, papà chiamò noi figli più grandi e disse: «Se dovesse succedere un giorno a me, sappiate che la mia decisione in piena autonomia è che non ci sia mai una trattativa con le Brigate rosse. E se anche io dovessi chiederla dalla prigione del popolo, voi dovete rispettare la mia volontà espressa da uomo libero in questo momento».
Le ultime ore che ho trascorso con papà me le ricordo benissimo. Lui stava per partire per quel viaggio da cui non sarebbe tornato. Lo chiamai perché dovevo andare in Sardegna e avevo capito che l’ora della partenza più o meno coincideva con la sua. Lo raggiunsi a Botteghe Oscure e andammo insieme a Fiumicino. Lui era diretto a Genova da dove poi si sarebbe spostato a Padova. Quella è stata l’ultima volta che l’ho visto vivo.
Di papà mi mancano tantissime cose, quelle che mancano a una figlia il cui padre se n’è andato troppo presto, quando tutti noi eravamo ancora molto giovani. Il rapporto quotidiano, che non abbia potuto conoscere la nostra vita da adulti e che non abbia saputo niente di quello che avremmo fatto. Mi sarebbe piaciuto chiedergli mille volte: «Cosa pensi di questo? Come valuti questa mia scelta? Come giudichi questa o quella situazione politica?». Il dispiacere più grande è che non abbia potuto conoscere i nostri figli: Letizia, Caterina, Giulia, Enrico e la figlia di Marco che sta per nascere.
Se poi mi chiedi che cosa sia mancato al Paese con la sua scomparsa, ti rispondo che forse è mancata la sua capacità di offrire una speranza a milioni di persone. Ce ne siamo accorti un minuto dopo la sua morte. Dall’ospedale di Padova, dovevamo andare a Mestre per accompagnare la salma che sarebbe partita con l’aereo del capo dello Stato, Sandro Pertini. Pioveva quel giorno, erano più o meno le quattro del pomeriggio, e ci mettemmo tantissimo per arrivare perché molte persone erano scese spontaneamente per strada, formando dei cordoni, per salutarlo un’ultima volta. Quando arrivammo all’aeroporto, io e mamma ci guardammo per un istante e da quello sguardo capii che anche lei era rimasta sorpresa da così tanta partecipazione. Sicuramente c’era anche prima quell’atteggiamento: capitava infatti per strada che in tanti lo volessero abbracciare, stringergli la mano, dirgli due parole. Però quella manifestazione così forte di affetto, che anche oggi, a distanza di trent’anni, sento proiettarsi su di me in quanto sua figlia, ecco, quello forse lo abbiamo capito davvero solo allora.
Il giorno dei suoi funerali è stato molto difficile. Vivere in pubblico un dolore privato così grande e così improvviso, è stata una fatica enorme. Impegnativo e allo stesso tempo bello – ricorro a un termine che mai avrei usato allora – perché l’emozione di tutta quella piazza ci ha toccato profondamente. Mentre guardavo quella folla che soffriva, non dico quanto noi perché il dolore di una figlia o di una moglie non è mai comparabile a quello di nessun altro, pensavo: «Quando tornerete a casa, troverete vostro padre. Stasera quando io tornerò a casa, mio padre non ci sarà». L’abbraccio di tutte quelle persone fu una straordinaria consolazione, ma non poteva colmare un’assenza incolmabile.
Credo che quel giorno rappresentò anche un po’ la fine del Partito comunista italiano, per come è stato in Italia con tutta la sua straordinaria originalità.
![]()
2
Alberto Menichelli
Il mio capo
Il mio rapporto con Berlinguer è iniziato purtroppo in concomitanza di un evento triste, la morte del padre Mario. Credo fosse il settembre 1969. Già c’era nell’aria qualche avvisaglia del golpe Borghese, la situazione non era tanto tranquilla e quindi la segreteria del partito ha voluto mettergli a fianco un compagno. Lui era contrarissimo ad avere un compagno come scorta, gli piaceva molto guidare la macchina, e invece gli hanno quasi imposto questa misura di sicurezza. All’inizio ha accettato, ma con riserva: «Che sia un provvedimento provvisorio». Difatti io, provvisoriamente, sono stato quindici anni con lui!
Il primo giorno è stato piuttosto difficile anche perché, a noi della vigilanza, Berlinguer incuteva una certa soggezione e comunque un grande senso di rispetto. Non era semplice stare con lui, infatti nei primi tempi ci si limitava a «Buongiorno» la mattina e «Ci vediamo domani» a fine giornata. Era abbastanza pesante, perché non riuscivi a capire se andava bene o se andava male. Sapevi di essere un intruso dentro quella macchina. Poi però, piano piano, l’atmosfera si è sciolta e si è instaurato un rapporto molto bello, molto stretto. Anzi, questa è una cosa che posso dire con orgoglio: io mi potevo permettere alcune licenze che ad altri non erano concesse, compreso Tatò. Per esempio lo prendevo in giro, per come si vestiva, per il Cagliari, la Lazio, la Roma… tutte cose belle.
Poi ci capitava di vederci anche fuori dall’orario di lavoro, dato che la segreteria mi aveva imposto addirittura di non lasciargli la macchina. Non dovevo lasciargliela assolutamente e allora succedeva che il sabato pomeriggio o la domenica mattina gli portavo i giornali, lui usciva con Lauretta, la figlia più piccola, e… devo dire che le prime volte che sono andato a San Pietro è stato con Berlinguer. Un giorno un gruppo di suore lo ha incontrato e riconosciuto, e lo ha salutato così: «Buongiorno eccellenza» e lui sottovoce ha detto: «Meno male che non mi hanno chiamato eminenza». Questo era Berlinguer.
Durante le festività di Natale o di Capodanno, anche se avrebbe voluto uscire, si tratteneva perché sapeva che avrebbe impegnato sette persone e allora rinunciava. A me questo dispiaceva tantissimo. Passare le feste di Natale in famiglia, come tutti, per lui non era possibile. Allora una volta l’ho portato con noi alla scuola di partito di Frattocchie, dove avevamo organizzato un bel cenone, con la tombola e grandi risate insieme a tutte le nostre famiglie. È stato veramente bello.
Non è vero che Berlinguer fosse un uomo triste, proprio no. Gli dava molto fastidio che si pensasse questo di lui, perché non lo era affatto, anzi lo definirei abbastanza spiritoso. Voglio raccontare un aneddoto: lui era complice negli scherzi che facevamo, intendo noi quattro della scorta, anche perché le giornate erano lunghissime, il clima un po’ pesante, persino pericoloso, e allora si cercava di scherzare. Mi ricordo che una volta eravamo alla festa dell’Unità di Tirrenia noi della vigilanza, tra cui Dante Franceschini, di recente scomparso all’età di 92 anni. Era lui il fulcro degli scherzi. Appena arrivati in albergo, ho chiamato subito il capocuoco, gli ho indicato Franceschini e ho detto: «Guardi, quel signore lì è di molto appetito, purtroppo però ha l’ulcera allo stomaco perforata. Mi raccomando, quando ci porta da mangiare gli dia porzioni ridotte». Questa storia è andata avanti per quattro giorni senza che Franceschini sospettasse nulla. Berlinguer tutti i giorni mi chiedeva: «Ma se n’è accorto?». «Ancora no.» «Ma è possibile?» «Eh no, ancora no.» Finalmente a Franceschini si accende la lampadina e dice: «Secondo me questo cameriere ce l’ha con me. Perché mi porta meno roba?». Questi erano gli scherzi che faceva Berlinguer. Addirittura se andavamo al bar a prendere il caffè, faceva finta che gli fosse caduto qualcosa e di cercare per terra. Allora soprattutto la scorta della polizia chiedeva: «Che è successo? Cosa cerca?». Ecco, questo era l’uomo triste.
Invece, timido lo era. Tant’è vero che prima dei comizi dovevo preparare un bicchiere d’acqua allungato con un po’ di whisky, su consiglio del professor Ciccio Ingrao, perché gli prendeva come un bl...