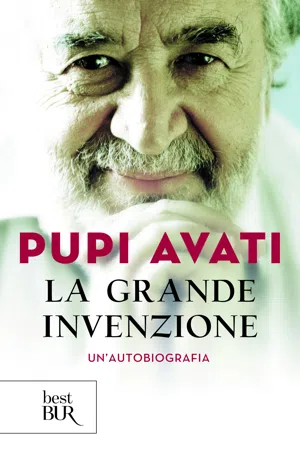![]()
Questa mattina nel dormiveglia ho sentito Lucio che mi diceva: «Ho fatto male a morire... mi sono pentito...». È a quell’ora, quando non è ancora giorno fatto, che si sentono le voci e non ci si meraviglia: «Ma non sei in Paradiso?» gli ho chiesto immaginando: figurati se Dio si lascia scappare uno come Lucio Dalla.
«Non lo so...» mi ha detto lui.
«Come non lo sai?... ma almeno mia madre l’hai vista?» gli ho chiesto.
«Non c’è» mi fa.
«Come non c’è, guarda che se non c’è mia madre vuol dire che non sei in Paradiso... magari sei nel Limbo...» poi hanno suonato quelli della raccolta differenziata che con una pulsantiera di una dozzina di nomi scelgono sempre il mio per farsi aprire il portone.
Così mi sono svegliato e ho chiuso la conversazione con Lucio.
dp n="8" folio="8" ?
dp n="9" folio="9" ?
1
Troppo bugiardo
Quello che mia madre ha sempre detto di me, cogliendo a pieno un aspetto della mia essenza, è che sono «molto buono ma troppo bugiardo».
Lo diceva alludendo alla mia peculiare predisposizione a raccontare, una caratteristica che ho ereditato proprio da lei. Solo che a volte nel raccontare, pur partendo sempre da un fondo di verità, finivo per mescolare il vero con l’invenzione, cosa che lei mi rimproverava soprattutto quando si trattava della sua epica familiare. Anche la storia di questo mio insolito soprannome, di come sia venuto in mente a due genitori nel 1938 di chiamare il loro primogenito Pupi, me la sono dovuta inventare raccontando che mia madre da ragazzina si era invaghita di un violinista austriaco che tutti a Salisburgo chiamavano Pupi. Una spiegazione che a livello aneddotico «funziona» ma che ha sempre fatto imbestialire mia madre che la sapeva totalmente frutto della mia immaginazione.
Per me la bugia non era altro che una diversa modalità dell’immaginazione, un modo per dilatare il reale. E questo, in definitiva, è ciò che mi ha spinto a fare il cinema.
Raccontare mi è sempre sistematicamente servito per rivivere le cose in una chiave diversa e, soprattutto per intervenire sui finali che sono il punto essenziale di tutte le vicende: per farmi fidanzare con la ragazza che mi aveva sempre detto di no, per farmi vincere anche quando avevo
perso, in ogni caso per mirare a quell’happy end che ci garantivano tutti i film americani con i quali siamo cresciuti. Ho sempre avuto la tendenza a mescolare il reale con la fantasia, e oscillo continuamente tra il pensabile e l’impensabile, tra ciò che accade e ciò che mi piacerebbe accadesse. È più forte di me e anche nella mia quotidianità finisco ormai sempre più spesso per confondere la realtà con la finzione cinematografica. Il cinema si è andato a collocare in modo così misterioso, inestricabile nella mia vita da far sì che i contorni di un set includano ormai la mia vicenda umana, nei miei rapporti più ordinari. Qualche mese fa, per esempio, dovevamo decidere come risolvere un problema della caldaia nella nostra casa di campagna e ne stavo discutendo con mia moglie:
«La cambiamo o la facciamo ancora aggiustare?» le ho chiesto e, mentre aspettavo la sua risposta, la guardavo chiedendomi se sarebbe stato meglio inquadrarla da destra o da sinistra, senza trovare né una soluzione alla riparazione della caldaia né alla posizione della macchina da presa.
Ho atteso da sempre l’attenuarsi di quell’eccesso di realtà con cui si confronta il nostro vivere scavando tutt’intorno a me vie di fuga, cunicoli, pertugi che nel momento di massima esposizione alle responsabilità sapessero condurmi in quell’altrove in cui fin da bambino ho sempre cercato riparo.
Se negli anni della maturità poteva apparire indecoroso ricorrervi non significa che non ne provassi nel mio intimo una fortissima nostalgia, senza immaginare che sarebbe stato sufficiente invecchiare, anche solo un poco, per avervi nuovamente accesso. Si trattava solo di pazientare, poi quella stagione meravigliosa, in cui bambino avvertivi lo straordinario potere che ti dà lo strapensare, si sarebbe riproposta nella sua abbagliante onnipotenza.
Trattandosi dei primi espliciti sintomi di demenza senile, non avrei dovuto gioirne come invece mi è accaduto, addirittura ostentandoli. Ma forse tutto il mio intero percorso
umano non è improntato ad altro che al candidare come valore il limite, la carenza, l’inadeguatezza, la vulnerabilità, sintomi di una qualche mia grave patologia sulla quale ho preferito non indagare.
Certo, è anche un modo per sfuggire alla realtà e ai confini angusti della responsabilità, una specie di indisponibilità a crescere che ravviso in me anche nei momenti più dolorosi della mia esistenza. Di recente, quando mi sono ritrovato a condividere coi miei familiari un problema grave di salute che riguardava una persona a me molto cara, mi sono accorto che, nonostante fossi il più anziano, ero quello meno attrezzato per poterlo fare. Era come se non riuscissi a prendere in mano la situazione, come se non accettassi quel doloroso eccesso di realtà, che non potevo in alcun modo manipolare. C’era un altro che non ero io a distribuire le battute a preordinare gli eventi. Avrei voluto scappare, darmi malato, come facevo da bambino.
Non l’ho fatto, ma tutta la mia vita in fondo è stata in qualche modo una fuga consapevole. Ho sempre scelto delle soluzioni che mi mantenessero in un’età mentale in cui l’impegno vero, autentico, quello del mondo adulto, fosse continuamente prorogato.
Da ragazzo se ho scelto il jazz l’ho fatto perché mi permetteva di evadere dalle regole costrittive della musica classica, era un puro seguire l’istinto. Quando mi è andata male, sono fuggito travestendomi da venditore di alimenti surgelati. A quel punto ho giocato a fare l’adulto responsabile, adottando abbigliamento e lessico appropriati. Mi sentivo straordinariamente in parte nello scendere, con una ventiquattrore di vilpelle in completo Facis e occhiali polarizzati, da una Alfa Romeo Giulia con un bagagliaio frigorifero zeppo di bastoncini di pesce e spinaci tritati. Per un po’ c’era da andarne fiero, e infatti per un po’ la cosa ha funzionato, almeno fino a quando c’era da evangelizzare con il nuovo verbo il mondo diffidente degli alimentaristi. Ma in una vita intera, che la si calcoli sulla media di un’ottantina
di anni, darne più di quattro ai surgelati mi apparve fin troppo generoso e così, sedotto da un sogno diverso, sono scappato a Roma, dove ho continuato a fuggire da un film all’altro, di anno in anno. E fino a quando me lo permetteranno, continuerò a farlo.
![]()
Questa mattina non era ancora l’alba e non era ancora venuto nessuno dall’Altro mondo a dirmi qualcosa di sé, ma quello ha suonato lo stesso rompendo l’incanto dell’attesa.
«È ancora buio!» gli ho strillato al citofono, ma lui ha urlato più forte di me che doveva lasciare i sacchetti per i rifiuti umidi. Sono tornato a letto ma ho avvertito un bisbiglio provenire da sotto le coperte. Sulle prime mi sono spaventato, ma poi ho scoperto che non avevo spento l’iPod e la voce di Jelly Roll, accompagnata dal suo pianoforte, aveva continuato a raccontare per tutta la notte la nascita del jazz nella New Orleans dei primi del Novecento.
Se avessi chiesto a mio padre chi era Jelly Roll Morton, per quale allusione sessuale si chiamasse così e perché si fosse fatto incastonare un diamante in un incisivo, non avrebbe saputo rispondere. Di sicuro non sapeva neppure che Jelly Roll querelava tutti perché si considerava l’inventore del jazz. Querelò persino il povero William Christopher Handy, l’autore di St. Louis Blues, un brano che vorrei rammentarvi come fa ma è difficile fischiarlo in un libro. Amo il jazz in modo disperato, di un amore che il jazz non merita non avendomi mai riamato, avendo fatto di tutto per farmi desistere dal suonarlo. E riuscendoci. Quindi dovendo scegliere a chi dare la precedenza nel racconto fra il jazz e mio padre preferisco decisamente quest’ultimo.
dp n="14" folio="14" ? dp n="15" folio="15" ? 2
Ines e Angelo
Mio padre è morto in un incidente stradale il dieci agosto del 1950, scegliendo per morire un posto, un’ora e un giorno che poi dirò, perché fossero speciali. Insomma, ci teneva a fare una morte non qualunque. Lui non sapeva niente di jazz ma era un grande appassionato del Quartetto Cetra, di Natalino Otto e di Bing Crosby. Aveva cinque dischi settantotto giri che ascoltava tutte le sere, delle volte facendo ballare mia sorella di nove anni o Elsa, la nostra domestica, che si vergognava a ballare davanti alla mamma che rideva e le si bruciava il ragù.
Mio padre era l’uomo più diverso da me che si possa immaginare. Se avessero messo tutti gli uomini di Bologna in fila, come facevano a Scotland Yard prima che si vendessero il palazzo, e avessero chiesto a chiunque chi fosse mio padre, nessuno lo avrebbe indovinato. Era biondo di capelli e di baffi, gli occhi azzurri, magnifico sorriso. Curatissimo nel vestire in un’Italia in cui gli uomini tenevano la stessa camicia e la stessa biancheria per una settimana. Si chiamava Angelo, ma tutti lo chiamavano Lino, e gli ho sempre invidiato il fatto che fosse simpatico, nel modo di esserlo che fa ridere le donne. Producendo nel loro sguardo quella liquida lucentezza che tradisce sempre un tumulto dell’animo. Al mattino la nostra Elsa gli porgeva con sacralità la camicia fresca di bucato appena stirata con il colletto non troppo inamidato, mentre mia madre gli infilava nel taschino della giacca un candido fazzoletto di lino, lasciandolo intuire più che vedere: una coreografia che tutte le donne di casa da anni replicavano per lui, dal caffè alla prima sigaretta, dalla lucidatura delle scarpe allo sgombero precipitoso del bagno da parte di chiunque lo occupasse.
«Si è alzato papà!» urlava la mamma ed era un allarme sufficiente a farci dileguare. Solo a mia sorella, senza alcun dubbio la sua prediletta, era concessa quella strafottenza nei suoi riguardi che lui, per ragioni del tutto inesplicabili, non solo sapeva perdonarle, ma dimostrava di apprezzare.
Un giorno, entrando nella stanza da letto dei miei genitori, vidi il pene del babbo. Era il primo pene di un uomo adulto che vedevo. Era scuro, lungo e pencolava in bella mostra in mezzo alle sue gambe bianche mentre la mamma strillava a papà di coprirsi che c’era l’Elsa che gli aveva portato la camicia stirata. Ma lui non si coprì, ne sono certo, mostrando questo coso che mi apparve così disarmonico, così in più rispetto alla gradevolezza del suo corpo, così posticcio. Eppure papà, così efebico, era anche quel coso lì capace di far scappare via l’Elsa scandalizzata, capace quindi solo al suo appalesarsi di mettere in fuga tutte le donne del creato. I poteri misteriosi, addirittura soprannaturali, di quel coso che andavano oltre la diuresi, li avrei appresi più in là negli anni, nell’estate di San Lazzaro quando venni iniziato.
Angelo Avati, mio padre, era un uomo soprattutto dotato della grande capacità di riconoscere il bello, capacità che gli derivava probabilmente dall’aver trascorso gli anni della sua formazione in quel grande negozio di antichità di suo padre che al calar della sera diventava ritrovo di tutti coloro si occupassero d’arte, per mestiere o per diletto, nella remota Bologna di quegli anni.
Fu proprio nel negozio di suo padre Giuseppe, detto Pippo, che incontrò nostra madre Agnese Vigetti, figlia di Carlo e Osti Francesca. Probabilmente quando la vide per la prima volta battere a macchina notò più il suo non facile rapporto con la tastiera che la sua avvenenza. Di certo non immaginava che di lì a poco una tragedia familiare avrebbe favorito la loro unione.
La mamma era di origini modeste. La sua famiglia veniva da Sasso Marconi, ma lei era nata nel 1914 a Bologna, dove suo padre Carlino lavorava come operaio all’Arsenale. Carlino, nato nel 1889 fino a cinque anni aveva vissuto a Monte San Pietro. Morto però suo padre nel 1894, sua madre Olimpia, asolaia e con tre figli piccoli da crescere, aveva deciso di dare ascolto a quelli che andavano in giro per i paesi a «vendere l’America». Erano degli ometti che venivano l’estate per mostrare nelle scuole o nelle sagrestie, appendendolo a una parete, il manifesto di quelle grandi navi a vapore capaci in venticinque giorni di navigazione di portarti in Brasile. E i nomi di quei piroscafi erano Alsace o Aquitaine, Sempione o Italia, Assiduità o America.
Già molti, soprattutto dal Veneto, erano partiti e questi ometti facevano leggere, a chi sapeva leggere, le loro lettere piene di riconoscenza e di felicità per essere emigrati. Fu così che Olimpia cominciò a sognare, fra un’asola e un’altra, l’America. Sognarla soprattutto per i suoi tre bambini destinati altrimenti a crescere negli stenti. Così in qualche modo, credo vendendo una vigna e con una colletta di tutta la parrocchia, il viaggio venne organizzato e qualche tempo dopo, tre bambini assonnati e una vedova trepidante raggiunsero il porto di Genova.
Conoscevano il mare? L’avevano già visto? Non lo so. Facile pensare che almeno i bambini lo vedessero per la prima volta, ma la meraviglia dei piccoli, finì per orientarsi su altro. Mentre aspettavano che si facesse sera per imbarcarsi, passarono davanti a una pasticceria, rimanendo esterrefatti da una grande torta a forma di nave che occupava l’intera vetrina: pochi istanti dopo, partirono i pianti.
«Dai, mamma, ti prego, ce la compri?»
«Mamma, pensa com’è buona...»
Olimpia, fuori di sé dall’eccitazione del viaggio, considerandosi ormai «americana», quindi al riparo da ogni angustia economica, decise di compiere quel gesto che l’avrebbe resa memorabile nell’aneddotica familiare: spese le uniche due lire che aveva per accontentare il loro capriccio per far sì che i suoi tre bambini, nel bailamme del carico e dello scarico di una banchina del porto di Genova, al riparo di una fiancata del grande piroscafo a vapore che li avrebbe portati in America, si potessero divorare un’intera nave di pandispagna, marzapane e canditi.
Si imbarcano con la sensazione che la grande festa fosse iniziata per mai più finire. Quel poco di oro che possedevano, per precauzione, Olimpia lo aveva cucito nelle lenzuola. Quando però sbarcarono a San Paolo del Brasile, non trovò più nulla: era infatti abitudine della ciurma frugare nei fagotti dei passeggeri di terza classe e servirsi. Sul molo di San Paolo Olimpia si ritrovò dunque completamente squattrinata e senza sapere quale avvenire offrire ai suoi tre bambini.
Che cosa avrà provato una donna che aveva avuto la forza e il coraggio di imbarcarsi con i suoi piccoli, di fronte a una catastrofe imminente? Immagino sarà rimasta interdetta lì sul molo a cercare di capire come uscirne, in un trambusto di gente che scaricava, caricava, spingeva, barcollava con i bagagli sulla schiena. Fu a questo punto che le si avvicinò una coppia di italiani, senza alcun dubbio facoltosi. Aveva notato che stazionavano sull’imbarcadero osservando con curiosità lo sbarco degli immigrati e quando si presentarono dissero di essere rimasti colpiti da Carlino, che oltre a essere il più piccolo, era anche il più grazioso dei suoi tre figli. Si presentarono come coltivatori di origine italiana e le proposero di prenderlo in adozione: per le persone abbienti della città che non potevano avere figli si trattava di una pratica consolidata, che oltretutto in un colpo solo poteva fare contento sia chi non aveva mezzi per mantenere la prole, che chi ne desiderasse una. Olimpia forse ci stette a pensare un po’, passando dal rifiuto istintivo alla razionale accettazione, convinta se non altro del fatto che consegnando il figlio a questi signori avrebbe garantito a Carlino la fortuna di crescere in mezzo agli agi. Nel frattempo si sarebbe guardata attorno e avrebbe provveduto a sistemarsi. Questo si sarà detta.
In effetti, qualche anno dopo, lavorando alacremente, riuscì a diventare proprietaria di una sua piantagione e così si rifece viva per reclamare il figlio.
«Vado a prendere vostro fratello» disse agli altri due che forse si erano scordati di Carlino.
«Dovete ridarmi il mio ragazzo» spiegò con determinazione a coloro che lo avevano accudito e che, compresa la situazione, acconsentirono, seppur a malincuore, alla sua richiesta.
Dopo diciassette anni dal loro arrivo in Brasile, Olimpia e i suoi tre figli erano ricchi: arrivarono a possedere una loro fiorente fazenda di caffè, di cui per altro mio nonno mantenne fino all’ultimo un ricordo molto vivido.
Nel 1913, tuttavia, quando Olimpia era già morta, l’avventura sudamericana di questo ramo materno della mia famiglia si concluse: i tre fratelli, ormai tutti in età di leva, ricevettero la cartolina di precetto dall’Italia e, pur di difendere la patria, vendettero la fazenda e tornarono a Sasso Marconi. Cosa sapevano dell’Italia e cosa li legava a questo Paese? Poco o niente. Ma fu proprio a Sasso Marconi che Carlino, soprannominato da tutti l’Americanino, conobbe mia nonna Francesca.
Negli anni Venti un uomo solo dell’età di mio nonno non aveva in mente che un obiettivo: prender moglie, e così anche lui decise che doveva sposarsi. Aveva notato una famiglia, gli Osti di San Leo, con una disponibilità di quattro figlie femmine almeno all’apparenza tutte ancora nubili. Si andava dalla vivacissima Aldina (detta Dina), alla riflessiva Maria, dalla languida Francesca alla bellissima Amabile. Alle quattro sorelle Osti dovremmo aggiungere anche i loro quattro fratelli, ma l’urgenza di anticipare la vicenda affettiva di Carlino mi costringe a lasciarli momentaneamente sul fondo. Un solo dettaglio sarà sufficiente per far comprendere a quale genere di famiglia il nostro Americanino si stesse interessando. Il padre delle sorelle Osti si chiamava Sisto e amava così tanto il vino e temeva così poco la morte da aver sistemato sotto il letto la sua bara, tenendola sempre piena di bottiglie di Albana.
Fu con il preciso intento di suscitare l’attenzione delle figlie di quest’uomo eccentrico che una domenica, dopo la messa, Carlino andò a sedersi a un tavolino del bar della piazza. Chi può fare un’americanata se non l’Americanino? Carlin...