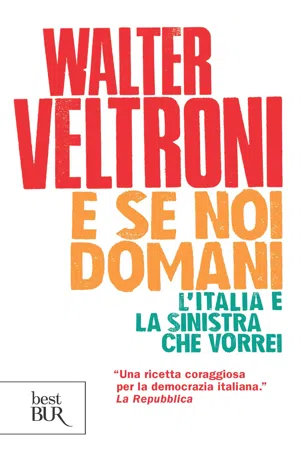![]()
Una società nuova (senza slogan troppo facili)
Questo non è un programma, non spetta a me farlo. È l’esemplificazione di una nuova società possibile, edificata attorno a una visione ispirata da quelle tre parole: responsabilità, comunità, opportunità. Una società che passi, culturalmente e civilmente, dall’egoismo particolarista alla responsabilità sociale.
E con uno Stato nuovo, fondato sull’idea che democrazia e potere debbano ritrovarsi e che l’assemblearismo consociativo e il populismo assemblearista e autoritario siano due facce della stessa medaglia.
Ho parlato di una nuova società. Questa espressione non mi spaventa. Non penso a un’altra società, ma a una società nuova. Nuova per riforme e valori.
Mai, neanche nel tempo del terrorismo, ho avvertito tanta paura diffusa. Tutto sembra sbriciolarsi e non emergono idee grandi, tanto suggestive da accendere un ragionevole sogno e, con esso, la speranza di uscire da questo tunnel. Siamo talmente immersi in questa realtà che facciamo fatica a ricordarci come si viveva prima. Quello che succede con le guerre.
E come durante le guerre emergono gli istinti primordiali. Si rifiuta il presente o ci si fa guidare passivamente da esso. Si cercano in vecchi armadi le medicine con le quali farsi passare l’ansia. E le si trova scadute, spesso dopo averle orgogliosamente trangugiate. È quello che è successo, in questi anni, alla sinistra italiana.
Ci sono frasi, diventate rassicurante idioma, che mi spaventano. Le cito perché le considero la summa del pensiero negativo della sinistra, quello che la tranquillizza sul momento ma certamente la rende minoritaria e la fa andare a sbattere contro un muro.
«Senza se e senza ma.» Fu usata contro la guerra in Iraq, la prima volta, e poi è diventata velenoso luogo comune dei discorsi politici di una sinistra stanca e passatista. Per me «senza se e senza ma» c’è una cosa sola: la legalità.
Il resto è, per una persona di sinistra, proprio «se e ma», è il dubbio, la ricerca, la scoperta, la revisione critica di se stessi. E quasi sempre – per questo la risposta giusta è «ma anche» – perché la complessità del reale difficilmente è riducibile a uno slogan. Quanti «ma anche» ha pronunciato Obama in questi anni? Apriamo agli israeliani e al loro diritto alla sicurezza ma anche invitiamo i loro ragazzi a guardare la realtà con gli occhi dei palestinesi. Combattiamo Bin Laden e il fondamentalismo religioso islamico ma anche andiamo al Cairo a dire che «l’Islam è parte integrante dell’America».
E proprio scorrendo il bellissimo e coraggioso testo di quel discorso tenuto nel 2009 all’università della capitale egiziana si trovano queste frasi: «Il rapporto tra Islam e Occidente ha alle spalle secoli di coesistenza e cooperazione, ma anche di conflitto e di guerre di religione», oppure: «So che agli occhi di molti il volto della globalizzazione è contraddittorio. Internet e la televisione possono portare conoscenza e informazione, ma anche forme offensive di sessualità e di violenza fine a se stessa. I commerci possono portare ricchezza e opportunità, ma anche grossi problemi e cambiamenti per le comunità locali».
La realtà è proprio «ma anche», e tutti devono diffidare degli spacciatori di certezze tanto inossidabili quanto rapide a dissolversi per essere sostituite, spesso, da materiale ancora più vecchio. E anche chi fa satira può far male a ciò che si propone di aiutare, se lo invita, facendolo egli stesso, a rifugiarsi in presunte certezze del passato invece che cercare nuove sfide.
La guerra, anche la guerra, nel suo universale orrore, non si può purtroppo rifiutare senza se e senza ma. Lo sanno gli italiani che abbracciarono dei ragazzi di colore venuti da lontano a salvarci dai nostri errori, lo sanno i kosovari che non hanno più paura di finire in fosse comuni, lo sanno i cittadini di Sarajevo che possono ora andare al mercato senza rischiare di essere dilaniati da una bomba.
Dunque persino la guerra, il peggiore dei mali collettivi, non è senza se e senza ma, come ci hanno insegnato Vittorio Foa e Alexander Langer.
Ancora: pensiamo al caso dell’Ilva. Chi deve ascoltare una vera sinistra? I cittadini che chiedono la chiusura di una fabbrica inquinante o i lavoratori che difendono la loro occupazione? E se in un quartiere di una città si insedia un campo di nomadi che considera suo diritto vivere senza fissa dimora, che attenzione dare alle proteste delle famiglie? La politica è decisione, che nasce però dall’attenzione ai diritti delle persone, quando sono legittimi e possono però essere tra loro conflittuali.
Tutto, nella radicale e frenetica trasformazione di questo mondo, propone alle culture politiche il dovere di porsi domande nuove e non di dare risposte usate e logore. È semmai vero che una società non più eurocentrica e non più divisa nei blocchi sociali tradizionali richiede una sofisticata capacità di lettura e di progressivo e coraggioso adattamento del sistema di valori della sinistra alle nuove condizioni. Altrimenti non si è più sinistra.
Per me la parola «sinistra» non è un’icona alla quale portare fiori né un luogo romantico o un negozio di antiquariato. Per me è incarnare oggi, qui, con lo sguardo rivolto al futuro valori di giustizia sociale e diritti fondamentali.
E la sinistra è condivisione della sofferenza degli altri, quelli che hanno di meno e quelli che potrebbero dare di più di sé. La sinistra, per me, è il contrario dell’egoismo. O, almeno, dovrebbe esserlo.
Per questo considero veleno slogan come Not in my back yard, non nel mio giardino. Perché, magari con la copertura di una robusta ragione ideologica, afferma il principio che esiste «il mio giardino» e che quello dell’altro «non è mio, non mi riguarda». In base a questo principio quei ragazzi americani o inglesi non sarebbero dovuti venire a morire qui nel ’44-45, in fondo non era «il loro giardino», i missionari che alleviano le pene dei più derelitti potrebbero starsene a casa e gli operai di una fabbrica avrebbero il diritto di disinteressarsi del destino di quella a fianco. È uno dei lasciti velenosi di culture individualiste che hanno incontrato, come spesso è successo nella storia, le vecchie ideologie della sinistra.
Sono forme moderne di corporativismo, di particolarismo che nulla hanno a che vedere con la legittima difesa dei propri diritti individuali che possono essere davvero tutelati solo in un contesto di relazione, di rete, di attenzione verso l’altro. Altrimenti l’esito sono le guerre tra poveri o tra vicini, perché se ciascuno dice «non nel mio giardino», i beni comuni rischiano di essere inutilizzabili.
Nessuno può più, in questo tempo inedito e complicato, farsi isola, chiamarsi fuori, pensare solo a se stesso. Non può farlo l’impresa che è chiamata a esercitare una attenta responsabilità sociale. Non può farlo il singolo cittadino che è chiamato a mettersi in rete, a organizzarsi, a farsi carico. Non può farlo la politica perché gli interessi di parte appaiono insopportabili quando la barca è investita da onde che non consentono neanche di respirare. Siamo un arcipelago, dobbiamo abituarci a vivere questa nuova stagione.
Se c’è una crisi in Giappone le nostre Borse, e i nostri risparmi, vanno giù. Se in Cina le imprese producono senza standard ambientali le conseguenze sull’aria che respiriamo, sul livello dei nostri mari sono inarrestabili. Se a Cupertino inventano una tecnologia nuova il nostro modo di vivere e comunicare cambia per sempre. E in questo mondo qualcuno pensa davvero che si possa resistere con la difesa del proprio spazio individuale, della propria posizione, talvolta del proprio privilegio?
Siamo nella rete. E la rete può proteggere dalle cadute ma può anche farsi ragnatela e imbrigliare e uccidere. Ne usciremo solo insieme. Altro che «non nel mio giardino». Il nostro giardino moderno è il mondo. E l’io e il noi devono riconciliarsi, se non vogliono separarsi definitivamente.
L’altra frase che ha caratterizzato questo tempo è Not in my name. È stata usata, sempre all’epoca della guerra in Iraq, per dire che Bush non poteva dichiarare il conflitto parlando a nome dei cittadini che lo avversavano. E non aveva torto, chi lo scriveva sui cartelli. Quella guerra veniva dichiarata in beffa alle norme internazionali, ingannate dal raggiro dei falsi dossier sulle armi di distruzione di massa, una delle più grandi manipolazioni dell’opinione pubblica che si siano conosciute.
Ma Not in my name è diventata una filosofia, nelle mani di sapienti druidi. È diventata l’idea che la democrazia diretta sia la soluzione dei nostri problemi e che dunque nessuno rappresenta nessuno, «uno vale uno» e in fondo che bisogno c’è di un governo se il Parlamento può legiferare senza di esso. Lo stesso Parlamento del quale si invocava la chiusura fino a che non sono stati eletti i rappresentanti, tali sono, del Movimento Cinque Stelle. Quel movimento ha una idea intermittente della trasparenza: pretende, assurdità inaccettabile, che venga trasmessa in streaming una consultazione formale per la formazione del governo ma sbarra tutte le porte quando i suoi eletti discutono tra loro, magari con opinioni diverse, e insulta dei giornalisti precari se fanno lo streaming dei loro dibattiti.
La democrazia diretta finisce sempre con l’essere ostaggio di un capo. E brave persone a Roma sono costantemente in attesa che il loro leader carismatico gli dica quello che devono fare, se possono aprire o no una riunione, se hanno detto una cosa giusta o sbagliata. Io credo che l’idea della «streaminghizzazione» della vita pubblica sia una idea autoritaria. La democrazia è fatta anche di riservatezza, di parole che ci si scambia senza che abbiano immediatamente una valenza pubblica. La democrazia è, da sempre, fatta anche di questo e la ideologizzazione della pubblicità di tutto non può conoscere confini né arbìtri. Non ci può essere chi, come il casellante di Non ci resta che piangere, decide se e quando alzare la sbarra, magari su richiesta di «un fiorino».
È come se Blair avesse reso note le laboriose procedure che lo hanno portato a trovare una soluzione alla guerra in Irlanda o se Rabin e Arafat avessero reso noti i contenuti delle loro faticose mediazioni prima degli accordi del ’92. Chi stabilisce cosa è pubblico e cosa no? Finirebbe, questa ideologia, nella furbissima soluzione italiota di Cinque Stelle: le nostre riunioni sono riservate, anzi blindate. Le vostre, tutte, devono essere pubbliche. Troppo comodo.
La democrazia diretta è una risorsa importante per ridare ossigeno alla asmatica democrazia rappresentativa. Ma non può sostituirla. Ha scritto il massimo studioso della rete in Italia, Stefano Rodotà: «Il fatto che Grillo dica che sarà cancellata la democrazia rappresentativa perché si farà tutto in rete rischia di dare ragione a coloro che dicono che la democrazia elettronica è la forma di populismo del terzo millennio… Poi si scopre che Grillo al Nord dice “non diamo la cittadinanza agli immigrati” e al Sud che la mafia è meglio del ceto politico, allora vediamo che il tessuto di questi movimenti è estremamente pericoloso».
La politica non può rinunciare al dovere di dire la sua e di prendersi la responsabilità di scelte complesse che non sempre possono essere ridotte a un sì o a un no. Il fallimento a Taranto del referendum popolare sull’Ilva dimostra proprio questo. Va di moda sottoporre a referendum o a consultazione in rete qualsiasi cosa, ma questa è solo la finale deresponsabilizzazione della politica, come le «parlamentarie» nella forma fin qui conosciuta. «Parlamentarie» che, nel caso del Movimento Cinque Stelle, hanno consentito a un senatore – che lo ha dichiarato in tv – di essere eletto avendo ottenuto 48 voti nelle consultazioni in rete: una famiglia numerosa. O le «quirinarie», in cui, dei 48.000 aventi diritto su un elettorato di 8 milioni, si è astenuto il 48 per cento. L’abuso non codificato di queste forme di democrazia diretta rischia paradossalmente di sancire l’inutilità di forme importanti di partecipazione dal basso. Le forme di consultazione democratica – ne ho indicata una sull’assetto istituzionale del Paese –, l’attivazione di meccanismi di protagonismo responsabile e persino di gestione di beni e servizi comuni sono una risorsa per strappare alla bulimia satrapica di certa politica, specie locale, la gestione integrale della cosa pubblica.
Anche la rete è una immensa risorsa in questo senso. Ma, innanzitutto, a una condizione, sempre la stessa da sempre. Che anche qui cessi la discriminazione sociale che condanna una buona parte del Paese a essere emarginata. Sud e Nord devono poter accedere alle informazioni allo stesso modo, non a velocità diversa, non con zone nelle quali è impossibile collegarsi. Banda larga, diffusione del wi-fi gratuito sono ormai frontiere della competitività, come lo fu la costruzione dell’Autostrada del Sole. Scelta alla quale, lo dico incidentalmente, la sinistra fu contraria, come d’altra parte alla tv a colori.
Cominciai a usare la rete quando ancora non c’era il www e ci si connetteva attraverso provider come MC-link. E, da allora, sono convinto che la rete sia una meraviglia di opportunità, la faccia più bella della globalizzazione: la possibilità di azzerare le distanze comunicative e di socializzare milioni di informazioni. La rete costituisce ambiti di ricerca, di confronto, di promozione umana. La rete è fattore di sviluppo economico e di miglioramento, grazie ai servizi on line, della possibilità di limitare spostamenti inutili e di riconquistare il bene primario del tempo.
Il tempo è stato infatti oggetto della grande rivoluzione indotta dalle tecnologie. Facciamo tutto più in fretta di prima ma ogni attesa ci sembra intollerabile. Viviamo in una costante ubiquità, che alimenta in noi una sensazione di onnipotenza, la percezione di essere «dentro le cose» che conosciamo e commentiamo in diretta, siamo a contatto permanente con una quantità immensa di desideri: desideri di cose, luoghi, persone che però non possiamo tutti soddisfare. Marco Niada, nel suo interessante Il tempo breve, scrive che questo decennio «ha premiato la velocità di esecuzione rispetto al ragionamento, l’impulso rispetto alla riflessione, il brevissimo termine rispetto al medio e lungo termine. Questa accelerazione ci ha reso tutti più irresponsabili. Dai politici ai cittadini comuni, nella ricerca del tutto e subito».
Possiamo molto di più, sappiamo molto di più, ma vogliamo tutto e subito, nella società veloce.
Ma come tutte le meraviglie la rete ha un’altra faccia, quella contraddittoria. È difficile parlarne, per le stesse ragioni che sto per descrivere. I social network sono una parte della meraviglia: opinioni che circolano a migliaia, un tripudio della democrazia. Rapporti affettivi, familiari, di amicizia o di amore che si intrecciano per questa via. Un mondo piccolo, raggiungibile, umano. Ma i social hanno portato con sé anche dei mutamenti del «discorso pubblico».
Spesso sono luoghi di cattiveria cinica e disumana. Mi hanno colpito certe reazioni alla morte di Antonio Manganelli, veleni di sconcertante soddisfazione nutriti da accuse inventate – «Se lo merita per quello che ha fatto alla Diaz» – o ciò che qualcuno scrisse in calce alla notizia dell’ictus che aveva colpito Lamberto Sposini – «Se lo merita così la smette di fare la tv marmellata» oppure «Non dimentico che aveva lavorato con Berlusconi». O ancora i commenti comparsi sul sito del giornale fondato da Antonio Gramsci a proposito della morte di Margaret Thatcher: «Era ora!!!», «Le colpe non si estinguono con la morte. Era un’infame e nessuno la rimpiangerà!!!», «Giustizia è fatta!! È finalmente morta, purtroppo nel suo letto anziché giustiziata come avrebbe meritato, una delle peggiori nemiche dell’umanità del XX secolo. Morta con trentacinque anni di ritardo», «Bottegaia assassina», «Berlusconi corri, c’è posto anche per te».
Singoli, certo. Ma la circolazione sulla rete fornisce a quelle disumane assurdità una sorta di legittimazione. Diventano cose che si possono dire. E invece non si possono dire. Nessuno può negare nessun diritto di espressione. Ma certe cose non si possono umanamente, eticamente, moralmente dire.
In rete tutto è rapido e corto. Con due conseguenze: la semplificazione e la radicalizzazione delle posizioni. Il linguaggio della politica nel tempo di Berlusconi è perfettamente entrato negli stereotipi comunicativi dei social. Spesso prevale l’insulto personale, la apodittica affermazione di certezze fondate su balle spaziali che la rete inghiotte senza batter ciglio. Forse è l’inizio, forse si prenderanno le misure. I social, per loro natura, dovrebbero essere luoghi aperti in cui la cosa più bella sono le idee e i pensieri dell’altro. Luoghi non afflitti dallo spirito di conservazione, dall’idolatria del no che anima il Paese, ma laboratori di una società aperta e dialogante, con la testa nel futuro.
C’è poi un problema che riguarda la politica e il suo rapporto con la rete. Accadde la stessa cosa con la definitiva affermazione della televisione quando qualcuno spiegò ai politici che «bisogna guardare in macchina» e, ancora oggi, si vedono attempati senatori che ignorano scortesemente l’intervistatrice e fissano rapiti l’obiettivo della telecamera pensando che questo darà più incisività alle loro parole, spesso vuote. Così tutti si sono precipitati su Twitter e Facebook e ora vivono in una condizione di dipendenza totale. Rilanciano, narcisi, i messaggi che parlano bene di loro e sono ossessionati da quello che la rete dice. Così tendono ad assecondarla, perdendo dosi massicce di autonomia culturale e politica. «Lo ha detto la rete» per molti è il nuovo «lo ha detto il comitato centrale», ed essendo la rete, per sua stessa natura, veloce e semplificata, allora la politica si è fatta rapida e banale. Si è aggiunto un tassello alla sua crisi di fondo: la perdita di respiro, ambizione, visione.
Certe volte penso a cosa sarebbe accaduto se i social network fossero esistiti al tempo in cui Togliatti decise l’amnistia per i fascisti o quando Berlinguer ebbe il coraggio di sostenere che si stava meglio sotto l’ombrello della Nato che sotto quello del patto di Varsavia.
La rete è un luogo moderno dell’incontro e del dialogo sul quale nessun bavaglio può essere messo. Semmai anche lì è giusto favorire il gusto delle opinioni dell’altro e la curiosità del nuovo. Ma questo è puramente un fatto culturale. La politica non si rifugi dietro l’alibi del «l’ha detto la rete» per sfuggire al tema del suo coraggio e della sua sovranità. È come per i sondaggi. I politici dei quali bisogna più diffidare sono quelli che decidono per la loro comunità seguendo ciò che dicono le rilevazioni di opinione. Un vero dirigente politico segue la sua coscienza e l’interesse generale. E bisogna stare attenti perché il pericolo è che nel momento più complesso della storia si facciano avanti risposte semplificate. E, in generale, che predomini una cultura che prescinde dal vecchio saggio ammonimento di Marco Aurelio: «Guarda sempre all’insieme».
La società del frammento, d...