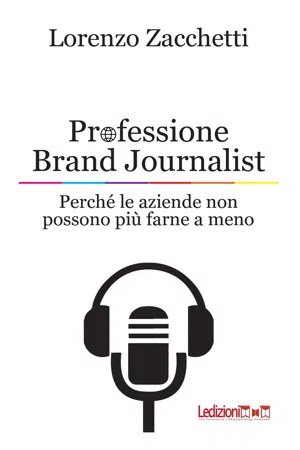
eBook - ePub
Professione Brand Journalist
Perché le aziende non possono più farne a meno
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Autore e conduttore di "Brand Journalism", la trasmissione radiotelevisiva diventata una vera e propria "masterclass" con tutti i professionisti e le case-history più interessanti del settore, Lorenzo Zacchetti prosegue con questo libro nell'opera di definizione di una
nuova professionalità dei giornalisti. Dopo anni di relazioni quantomeno difficili con gli interessi economici – talvolta nemici da combattere e in altri casi ispiratori occulti delle famose "marchette" – l'evoluzione del mercato ha reso necessario un cambiamento fondamentale: gli strumenti professionali dei giornalisti sono diventati indispensabili per le aziende, la cui comunicazione va profondamente ripensata alla luce della nuova realtà disegnata dalla disintermediazione. Imprese e prodotti vanno comunicati su un piano diverso, che coinvolga il target dal punto di vista emozionale, valoriale e anche etico, nell'ottica di quella "politicizzazione del marketing" che rappresenta un punto focale per l'autore, che conosce la professione del Brand Journalist per esperienza diretta. E di successo. Come tutti gli altri mestieri, non è per tutti: servono competenze che vengono precisamente descritte nel libro, a partire dal rigore nella ricerca della verità che rappresenta il primo dovere di ogni giornalista e che anche un Brand Journalist deve saper mettere in campo, pur lavorando per un'azienda e non per un editore tradizionale.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Professione Brand Journalist di Lorenzo Zacchetti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Languages & Linguistics e Journalism. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Capitolo 1
Il mestiere del giornalista, le imprese editoriali e il rapporto con la pubblicità
C’è da avere più paura di tre giornali ostili
che di mille baionette.
(Napoleone Bonaparte)
che di mille baionette.
(Napoleone Bonaparte)
1.1 Il cane da guardia del potere
“Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations”, ovvero: “Il giornalismo consiste nello stampare ciò che qualcun altro non vuole che si stampi; tutto il resto sono pubbliche relazioni”. Tale definizione viene generalmente attribuita al noto scrittore e giornalista britannico George Orwell, nonostante qualche legittimo dubbio nell’individuarne precisamente la paternità. In assenza di prove inoppugnabili, va rilevato come esistano altre definizioni della professione giornalistica, sia precedenti che antecedenti, che ne sembrano una sorta di parafrasi. Tra queste è praticamente sovrapponibile quella attribuita (stavolta senza incertezze) a un altro britannico: Lord Alfred Harmsworth, che fu giornalista ed editore a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Il cofondatore di due testate ancora oggi in auge come il “Daily Mail” e il “Daily Mirror” evidenziò infatti: “News is what people want to keep hidden and everything else is publicity”, cioè: “Le notizie sono ciò che la gente vuole tenere nascosto e tutto il resto è pubblicità”. Più volte citata in vari contesti, questa definizione è stata ripresa anche dal giornalista politico statunitense Bill Moyers, nel corso dell’edizione 2005 della National Conference for Media Reform. Per il solo fatto di essere stata ribadita nel contesto della più importante sede di dibattito sul rapporto tra i media e la democrazia americana, la definizione viene talvolta attribuita allo stesso Moyers, ma stavolta con una superficialità decisamente grossolana che legittima qualche dubbio sull’affidabilità delle fonti online. Avremo modo di tornare sul punto.
Al netto delle pur opportune precisazioni storiche, ciò che conta veramente è il concetto di fondo: la funzione fondamentale del giornalismo consiste proprio nel rivelare quelle verità che altrimenti rimarrebbero nascoste. Verità, ovviamente, di interesse pubblico, che esso consista nel venire a conoscenza degli scheletri nell’armadio di un politico che si presenta alle elezioni o degli scenari macroeconomici che potrebbero portare, ad esempio, a un inasprimento della pressione fiscale o al fallimento di investimenti solitamente considerati allettanti. Fornire ai cittadini le informazioni necessarie per formarsi una propria idea in modo autonomo sulla società nella quale vivono è ciò che rende il giornalismo un cardine delle democrazie compiute, ponendo nel contempo il settore dell’editoria in una sorta di paradosso che è tipico del capitalismo: da un lato svolge una funzione che è indiscutibilmente di interesse pubblico, ma dall’altro è esercitata da imprenditori privati e quindi è regolata dalle spietate leggi del mercato. In questa ambivalenza si inserisce anche il dibattito sull’opportunità di sovvenzionare l’editoria con contributi pubblici, una pratica che spesso viene associata dall’opinione pubblica ad abusi e privilegi (purtroppo con qualche ragione), ma che a livello internazionale viaggia invece di pari passo con l’effettiva libertà di stampa. A dimostrarlo sono i dati del World Press Information Index, secondo i quali i Paesi che possono vantare l’informazione più libera sono quelli scandinavi, ovvero gli stessi che primeggiano nella graduatoria dei sostegni statali. Avremo modo di tornare a parlare anche di queste nazioni e dei rispettivi mercati editoriali, nei quali tra l’altro è nato un fenomeno significativo quale quello della free-press (vedi par. 1.5).
1.2 L’informazione intrappolata nella Rete
Rispetto al rapporto tra informazione e democrazia, le considerazioni sin qui esposte hanno spinto a coniare la definizione di “watchdog journalism”, che tuttavia è una evidente tautologia: il giornalismo ha già nel suo DNA il ruolo di “cane da guardia” del potere, pertanto l’aggiunta del termine “watchdog” è ridondante. Se si vuole ulteriormente stressare il concetto è decisamente molto meglio assumersi questo impegnativo compito nella quotidianità professionale, svolgendolo con la schiena dritta e nonostante le pressioni di vario genere che potrebbero indurre il giornalista ad essere meno rigoroso. Chi si è avvicinato a questa professione in epoca recente non faticherà a comprendere in che cosa tali pressioni possano consistere. Se fino agli anni Novanta il ruolo del giornalista era accompagnato da un’aura di fascino romanzesco ed associata a un ruolo sociale molto influente – quello di intellettuale vero e proprio – oggi è spesso condizionato dalle insidie del precariato, e, ancora prima che dai risvolti economici, dalle radicali modifiche al modo di lavorare che hanno fatto seguito alla “età dell’oro” del mestiere. Modifiche che, nel contempo, hanno reso molto più semplici alcune procedure operative, ma dall’altro hanno enormemente complicato il raggiungimento degli scopi finali. Una sorta di paradosso che possiamo provare a spiegare con un tipico esempio di questa rivoluzione: la preponderanza assunta dalle agenzie di stampa, una risorsa in sé molto preziosa e che fornisce un flusso di notizie ai media con i quali hanno accordi di collaborazione. La loro tradizione è molto antica, risalendo addirittura all’Ottocento, ma nell’era digitale il loro peso specifico è cresciuto enormemente. Da un lato ciò ha portato evidenti miglioramenti, come ad esempio nel caso di avvenimenti che si verificano dove la testata in questione non ha sedi o corrispondenti locali: se in precedenza era compito dell’inviato speciale recarsi sul posto e raccogliere in fretta e furia le informazioni del caso, la presenza in loco di giornalisti dell’agenzia che già conoscono l’ambiente ha certamente velocizzato la cosiddetta “copertura” della notizia. L’altra faccia della medaglia è data dall’omologazione dell’informazione, in quanto tutti i media accreditati presso l’agenzia in questione sono in possesso di identiche informazioni, comprese fotografie e video, sul fatto di specie. Ovviamente la singola testata può personalizzare il contenuto giornalistico con un proprio commento, titolando l’articolo in maniera creativa e non meramente didascalica, dando alla notizia una particolare gerarchia in pagina e anche correlandola sul piano logico ad altre notizie in qualche modo connesse, ma la “materia prima” è la stessa per tutti e questo ci sposta notevolmente dalla centralità della valorizzazione della capacità giornalistica che consiste nello scovare le verità nascoste. Persino la verifica stessa della notizia viene spesso bypassata, riponendo fiducia totale nelle agenzie benché la responsabilità giuridica resti in campo alla testata che la pubblica.
Il passaggio al digitale, che in Italia ha preso slancio all’inizio del corrente millennio, ha ulteriormente esasperato questo cambiamento, anche perché la progressiva riduzione della forza-lavoro impiegata nelle redazioni ha reso sempre più frequente il malvezzo del “copia e incolla” dei lanci di agenzia, rendendo i singoli prodotti editoriali ancora più simili l’uno all’altro. Ancora peggio è quando tale abitudine si estende ai comunicati stampa che, a differenza delle notizie di agenzia, non rappresentano un punto di vista obiettivo, ma quello di un’azienda o di un singolo che ha un legittimo interesse su materie che pure talvolta hanno un effettivo interesse giornalistico. Anzi, gli uffici stampa più abili sono ormai specializzati nel produrre comunicati nei quali i rispettivi assistiti prendono spunto da fatti di cronaca molto notiziabili per fornire indicazioni e pareri in merito, configurandosi così come riconosciuti esperti della materia, in cambio delle informazioni oggettivamente preziose che forniscono ai media. Questi sono solo alcuni dei numerosi aspetti che, con la diffusione di Internet, hanno ribaltato i paradigmi della professione giornalistica, facendone saltare in primo luogo i modelli di business più consolidati. La Rete ha fornito a tutti la possibilità di accedere gratuitamente a qualunque contenuto, a tutto danno delle professioni che si basano sul diritto d’autore. Certamente esiste un problema enorme e tuttora irrisolto sull’affidabilità della marea di informazioni dalle quali siamo quotidianamente investiti sul Web e quindi il finale di questa storia è ancora lontano dall’essere scritto. Fenomeni come il dilagare delle fake-news rendono cruciale una regolamentazione che eviti queste distorsioni e che premi il giornalismo esercitato con competenza e deontologia. In taluni casi tale disinformazione si spiega con il dimostrato scopo di influire sull’esito della contesa politica, ma ai fini del nostro discorso è certamente più rilevante la motivazione commerciale di queste menzogne: diffondere informazioni truffaldine al fine di garantire un vantaggio a un’azienda o a uno specifico prodotto. Nonostante questi evidenti problemi di credibilità delle fonti, il modello del “pago per essere informato” è stato messo in una drammatica crisi, sia nel rapporto tra il Web e la carta (dove quest’ultima arriva sulle notizie con un ritardo temporale che spesso le rende obsolete), che nei tentativi di valorizzare il più dinamico giornalismo online, come dimostrano i risultati molto interlocutori di paywall, libere sottoscrizioni e altre forme di sostegno da parte dei lettori che i giornali stanno cercando di introdurre per mettere in ordine i rispettivi conti economici. Per rendere l’idea di quanto sia stato disruptive questo cambiamento, l’analisi va storicizzata ripercorrendo la nascita e i successivi sviluppi dei precedenti modelli di business.
1.3 Origine ed evoluzione del “Quarto Potere”
Nati in seguito all’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg (1455), nel secolo successivo i giornali diventano un fenomeno di massa dal riconosciuto valore commerciale, al punto che persino le loro testate vengono coniate con riferimenti espliciti a questo aspetto. Il termine “Gazzetta”, associato a varie testate che ancora oggi vanno per la maggiore, nasce a Venezia nel 1536, dal nome della moneta (“gaxeta”) con la quale si possono acquistare i fogli contenenti notizie sulla crisi in corso tra la Serenissima e la Turchia. Un caso analogo è quello de “Il resto del Carlino”, nato nel 1885, la cui denominazione si rifà al precedente “Il resto del sigaro”, giornale in vendita nella Firenze dell’Ottocento. Il particolare nome di quest’ultimo derivava dal fatto che i sigari allora costavano 8 centesimi e che i tabaccai lo proponevano in vendita abbinata, al posto dei due centesimi di resto. Insomma: allora era il giornale ad essere “l’allegato” di un altro prodotto, anche se sul finire del secolo successivo abbiamo visto il fiorire di un mercato esattamente contrario (quello dei “collaterali”). Tornando al 1885, quando a Bologna viene fondato un nuovo quotidiano, la sua testata si ispira proprio all’esperienza fiorentina, mescolata ad altri retaggi storici. Il “carlino” era infatti una moneta in uso nello Stato Pontificio e non più in circolazione dopo l’Unità d’Italia e l’introduzione della lira (1861). Tuttavia, per abitudine, la moneta da 10 centesimi continua ad essere chiamata “carlino” e l’espressione “dare il resto del carlino” viene gergalmente utilizzata per intendere “regolare i conti”. Con l’obiettivo di estenderne il significato all’intenzione di “pungolare i potenti e fustigare i prepotenti”, il nuovo giornale viene quindi chiamato “Il Resto… del Carlino” (i puntini di sospensione vengono cancellati solamente in seguito). Mezzo secolo prima, dall’altra parte dell’Oceano, viene invece coniata la definizione di “penny press” per indicare non una singola testata, ma tutti quei giornali che gli strilloni vendono nelle strade americane al prezzo di un solo penny. Il newyorchese “Sun” è il primo a scegliere la soluzione di questo significativo cut price, rispetto allo standard precedente della vendita a sei penny. Tale scelta commerciale ha forti riflessi anche sul contenuto del prodotto: non rivolgendosi più a un solo pubblico di elite, ma anche e soprattutto ai ceti popolari, la stampa americana accentua il suo ruolo di “watchdog” del potere e di fustigatrice del malvezzo, un compito del quale il termine “penny press” diventa ben presto un sinonimo.
La diffusione della stampa quotidiana inizialmente mette in crisi quella periodica, che nel Settecento si riposiziona su contenuti di carattere prevalentemente culturale e scientifico, quindi meno legati alla stringente attualità. La crescente popolarità dei giornali comporta un forte sviluppo di un altro modello di business: la pubblicità. La prima réclame della storia viene fatta risalire al 1630, grazie all’intuizione di Théophraste Renaudot, che l’anno seguente avrebbe fondato “La Gazette de France” con lo scopo di informare i sudditi sugli avvenimenti di corte. Grazie al suo ruolo di medico della corona francese, in seguito ottiene l’esclusiva della stampa dei fogli periodici nazionali, un privilegio che (dopo la morte del suo protettore Armand-Jean Richelieu nel 1642), gli viene fatto pagare con il divieto di esercitare la professione sanitaria. Renaudot comunque continua a lavorare nell’editoria e nel 1925 viene istituito un importante premio letterario – tuttora esistente – che porta il suo nome. La sua influenza sul settore è comunque ancora più visibile nell’importanza che la pubblicità inizia ad assumere a partire dalla rivoluzione industriale del 1760 e che ancora oggi contraddistingue il mercato dei media. La crescente offerta di prodotti di vario genere che caratterizza questa fase storica richiede la stimolazione di una domanda che solamente i giornali, forti del loro ruolo leader nel settore dell’informazione, possono garantire. Da qui parte l’impulso che scatena un’onda destinata a influenzare l’informazione e la comunicazione pubblica per diversi secoli, fino ai giorni nostri.
1.4 La pubblicità diventa il centro del modello del business (e influisce sui contenuti)
Mentre la stampa percorre la propria strada, la nascita di altri media molto potenti come il cinema (1895), la radio (1897) e la televisione (1900) porta al quasi immediato lancio della pubblicità anche in formato audio e video, nonché alla pratica del product placement, che analizzeremo a parte (vedi cap. 2). Ciò nonostante, le réclame continuano a imperversare anche sui giornali, i cui editori gradualmente spostano il focus dei propri ricavi dalla vendita delle copie alla vendita delle pagine pubblicitarie: una lunga storia, il cui apice si registra negli anni Ottanta del Novecento.
A fare da spartiacque, per quanto riguarda il mercato italiano, è la “discesa in campo” (quello editoriale) di Silvio Berlusconi. Nel 1978 nasce Fininvest, la holding che, nel settore dei media, acquista Telemilano dal fondatore Giacomo Properzj e dà vita al primo network televisivo privato italiano, basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale che solo due anni prima aveva messo fine al concetto di monopolio statale nelle telecomunicazioni. Tuttavia resta in vigore il divieto di trasmettere in diretta sull’intero territorio nazionale, un limite che la neonata Canale 5 aggira con uno stratagemma: attraverso un network di televisioni locali, trasmette in contemporanea un palinsesto registrato il giorno precedente. La furbesca soluzione non piace per nulla ai pretori di Roma, Torino e Pescara, che nel 1984 oscurano le reti Fininvest (nel frattempo allargatesi con l’acquisto di Italia 1 e Rete 4 dai rispettivi fondatori). La situazione viene sanata dal governo Craxi I, che con tre decreti legge emanati tra il 1984 e il 1985 regolamenta la materia a carattere transitorio, fino a quando la legge Mammì (1990) non conferisce piena agibilità all’impresa mediatica di Fininvest su scala nazionale. Un’impresa che ha il suo punto di forza proprio nella pubblicità, visto che nell’inedita competizione con la televisione pubblica i canali di Berlusconi non possono contare sul sostegno del canone e quindi devono inventare qualcosa di nuovo per colmare il gap. L’ingresso di un nuovo player così agguerrito ha un effetto dirompente sul mercato pubblicitario, offrendo una preziosa visibilità anche ad aziende che non possono permettersi budget esorbitanti. Entrano infatti in gioco soluzioni innovative come i “barter”, ovvero il pagamento degli spot in cambio merce. In questa fase di grande innovazione e fermento del mercato dell’editoria (nella quale tra l’altro inizia ad affermarsi l’astro di Urbano Cairo, che dopo i successi come a.d. di Mondadori Pubblicità si metterà in proprio), si incrinano le certezze della raccolta pubblicitaria sulla carta stampata, che per reazione accentua il suo carattere popolare, con l’obiettivo di aumentare la diffusione. Benché il genere della cronaca rosa sia l’espressione di una cultura che affonda le radici nel feuilleton, il romanzo d’appendice diffuso fin dai primi decenni dell’Ottocento, è proprio in questa fase storica che proliferano i settimanali femminili, ma anche quelli di gossip e/o dedicati alle star della televisione, nonché periodici specializzati in diversi argomenti, dallo sport al turismo.
Analogamente a quanto accaduto nei secoli precedenti, il modello di business, le policy di prezzo e i contenuti editoriali si intrecciano in una strategia integrata, confermando quello che il filosofo e sociologo canadese Marshall McLuhan aveva già esplicitato con il suo libro del 1967, dall’eloquente titolo “Il medium è il messaggio”. Massimizzare il numero dei lettori diventa un must non solamente per il beneficio diretto in termini di incassi da edicola, ma anche per quello indiretto derivante dalla maggior appetibilità sul mercato pubblicitario, che in molti casi diventa la prima fonte di ricavi. Questa strategia espone i giornali al rischio di ricatti da parte degli investitori, che in caso di articoli sgraditi possono ritirare la pubblicità e quindi stroncare l’impresa editoriale, ma evidenti ripercussioni si registrano anche nella quotidianità redazionale. La linea editoriale di prodotti così concepiti non può che mirare a una forma di informazione che è comunque pienamente degna di rispetto, ma che riorienta l’asse dal ruolo di “cane da guardia” a quello di cantore delle celebrità. In questo cambiamento, sovente si realizza una sorta di contiguità con i personaggi dei quali si occupa. Per non compromettere i rapporti con i volti che attirano l’interesse del pubblico, siano essi sportivi o divi dello spettacolo, si affina un’arte del compromesso che sposta il profilo del giornalista da quello dello sgradito indagatore a quello dell’amico dei VIP, che nei casi-limite diventa una specie di “embedded” in tempo di pace. Certamente non mancano esempi virtuosi di giornalismo estremamente rigoroso e serio anche in questi ambiti professionali, che peraltro anche chi scrive ha frequentato, ma il concetto di “interesse pubblico” si allarga notevolmente e lo specifico giornalistico non è più solo legato alla ricerca di ciò che il personaggio pubblico nasconde, ma anche di quello che invece ama esibire, sia esso un successo professionale, un luogo di villeggiatura o una liaison che susciti curiosità. Se invece pensiamo a uno scoop vero e proprio realizzato contro la volontà dell’interessato, come ad esempio nel caso della scoperta di aspetti della vita privata di un attore famoso, è indubbio che si tratti di buon giornalismo che risponde a un interesse pubblico, ma certamente ci si discosta parecchio dalla fondamentale funzione democratica di fornire gli elementi necessari per esercitare i propri diritti. Nel caso di specie, semmai si forniscono elementi utili a modificare o confermare l’opinione che il pubblico nutre nei confronti dell’attore in questione. Anch’egli, in quanto divo, esercita una forma di potere e quindi questo tipo di giornalismo svolge il suo ruolo di “cane da guardia”, ma il contesto cambia radicalmente. Nella scelta dei contenuti, il faro rimane ovviamente ciò che i lettori desiderano leggere, ma i pesi riservati ai singoli ambiti, anche in termini di fogliazione, sono molto spesso più legati alle esigenze pubblicitarie che a scelte puramente editoriali. Un efficace esempio di questo approccio si riscontra nei giornali femminili, le cui lettrici certamente nutrono interesse per la moda, ma nei quali il numero di pagine destinato allo specifico argomento è più spesso determinato in relazione ...
Indice dei contenuti
- Professione Brand Journalist
- Colophon
- Indice
- Prefazione
- Introduzione
- 1. Il mestiere del giornalista, le imprese editoriali e il rapporto con la pubblicità
- 2. Il brand: dalla pubblicità tradizionale alla narrazione
- 3. Il brand journalist nell'ecosistema della comunicazione
- 4. Come lavora un brand journalist
- 5. La narrazione aziendale
- Postfazione
- Bibliografia