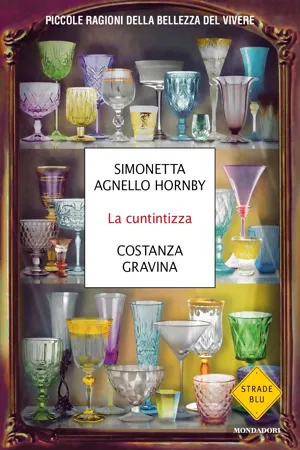![]()
![]()
Negli ultimi quarant’anni la civiltà della Rete ha rivoluzionato il lavoro, i rapporti umani e ha indubbiamente portato benessere. Uno dei più evidenti effetti negativi, al contrario, è stato quello di agire sul fronte relazionale: indiscutibilmente, le persone hanno meno rapporti diretti tra di loro. Viviamo in un mondo che cambia di continuo, e fino a lì tutto bene. Non abbiamo certo paura delle trasformazioni: cambia la moda, cambia il cibo, cambiano i gusti, cambia la famiglia, cambia la morale e cambia il modo di vivere degli esseri umani. Eppure. Eppure qualcosa è successo, la percezione che abbiamo di noi stessi e di noi stessi nel mondo, nonché di questo incessante processo di cambiamento, ha subito una scossa.
È ironico che nonostante si comunichi con inimmaginabile facilità con tanti “amici”, in realtà siamo sempre più solitari e ci impoveriamo emotivamente. Ci troviamo di fronte a una crescita esponenziale del malessere psichico, della povertà, delle tentazioni sovraniste: in una parola, dobbiamo fare i conti senza volerlo veramente con la graduale morte della democrazia. Più vediamo sullo schermo le sofferenze umane, meno facciamo per migliorare il mondo e la vita dei suoi abitanti. Ci sono ricchi che rigettano la miseria altrui o addirittura la disconoscono, si chiudono nelle fortezze del lusso, e sono pochi i miliardari che hanno come modello Bill Gates e Warren Buffett, benefattori dell’umanità.
Noi cittadini europei ci consideriamo civili e indipendenti. Non ci rendiamo conto di essere invece sorvegliati e controllati dai veri padroni del mondo: le grandi società multinazionali dell’Occidente – a cominciare da quelle che creano e controllano la tecnologia del cellulare che teniamo in tasca – e certe nazioni come la Russia e la Cina, determinate a penetrare nel mondo occidentale senza tanti scrupoli.
In Europa, nell’isolamento dovuto al Covid-19, coloro che hanno una connessione internet e disponibilità economiche possono procurarsi tutto ciò che serve e di più, comprando online dal cibo agli elettrodomestici, all’abbigliamento, dalle lezioni private alle diagnosi mediche, fino al piacere sessuale, con la conseguente impennata della pornografia (non soltanto quella online), sempre di più virata sulla violenza e sugli stupri.
Gli omicidi tra giovanissimi – di branco e quelli one-to-one all’interno della famiglia – in questi anni di pandemia sono aumentati a una velocità sconcertante, a partire dalla nostra Europa, e così anche la violenza sugli anziani. Tutto ciò va a discapito dei tradizionali rapporti tra esseri umani, della fisionomia protettiva del nucleo famigliare.
Devo ammetterlo: la materia di cui è fatta la cuntintizza è tornata prepotentemente a imporsi dentro di me nel tempo monco del Coronavirus, è diventata il mio il filo di speranza e di conforto. Mi ci sono aggrappata agli inizi del lockdown; non c’è creatura al mondo che non voglia raggiungerla istintivamente, quasi senza rendersene conto. In fondo, riconoscersi “affetti” da cuntintizza fa parte del nostro istinto di sopravvivenza.
Ma cos’è la cuntintizza? In che consiste? La cuntintizza è uno stato d’animo, una condizione di appagamento e soddisfazione, un sentimento d’amore verso il prossimo o verso un ideale, e un’aspirazione di tutti gli esseri umani nonché degli animali.
Non ho ricordi della mia infanzia privi di cuntintizza. La riconoscevo: si presentava attraverso l’affetto dei miei genitori, il piacere della compagnia dei cugini per parte di madre, ma anche la mia curiosità verso il mondo. Era intima, privata e la condividevo con chi mi stava vicino. Spianava la strada che porta alla speranza e al benessere interiore, e sembrava duratura.
La cuntintizza nasce e si manifesta in ogni singolo individuo senza rivelare da dove ha origine e perché esiste. Si può raggiungere in svariati modi; io la cerco attraverso l’osservazione e la curiosità.
Ognuno di noi ha la sua cuntintizza, poi sta a lui decidere se condividerla.
La cuntintizza necessita di essere nutrita, curata e protetta, altrimenti si atrofizza fino a scomparire. Talvolta, maltrattata, si trasforma nell’opposto, vale a dire in malevolenza.
![]()
Adoro mondare la verdura fresca appena raccolta nell’orto, sbucciare patate e cipolle, lavare e tagliare menta e basilico. Mentre risciacquo e tolgo gli insetti rimasti, tra le mie mani, i miei occhi e le foglie ancora piene di linfa si crea un rapporto, come se ambedue, io e la verdura, fossimo consce di far parte del ciclo della sopravvivenza: noi esseri umani e la pianta da cui spunteranno altre foglie.
Non mi vergogno a dire che ho l’occhio al risparmio. Al supermercato cerco i prodotti dal prezzo ribassato perché in scadenza: latte, formaggi, bevande, frutta, verdura, carne, pesce fresco, prosciutto e salame, pane, dolci e biscotti. È un modo per contribuire alla lotta allo spreco, e in più comprarli mi rende felice, mi dà persino un senso di avventura, dal momento che spesso acquisto cibi e bevande che non conoscevo. Arrivata a casa, metto subito in frigo e nel freezer il cibo da conservare. Poi mi dedico al mio pranzo, cominciando dalle verdure in offerta: stanche, sbattute e in fin di vita, salvate dagli scaffali del supermercato, le metto subito in acqua per ravvivarle e dare loro una meritatamente dignitosa morte in padella. L’odore untuoso del soffritto di olio d’oliva e trito di cipolla è denso di cuntintizza; aggiungo subito una spruzzata di aceto e poi in una cascata trasferisco le verdure tagliuzzate nella padella, in un tripudio di colori, sapori e profumi che appaga i sensi.
Mentre il soffritto cuoce, mangio la polpa delle arance e metto a seccare nel riposto di casa le bucce tagliate in un’unica spirale: appese ai fili di metallo tirati tra gli scaffali, sprigionano un leggero profumo. Dalla buccia secca immersa nell’acqua bollente per la tisana, sbummica un aroma garbato e forte al tempo stesso che si mescola al profumo della stufa alimentata dai rami secchi degli ulivi potati. È lì che mi sorprende quel delicato senso di pienezza che addomestica l’anima.
![]()
Mamma raccontava che quando avevo tre anni e mia sorella Chiara, di pochi mesi, era al centro dell’attenzione sua e della bambinaia, sgusciavo dalle nostre stanze e mi rifugiavo in cucina; lì mi sedevo su un poggiapiedi e osservavo beata la cuoca e le domestiche che preparavano il pranzo.
Ricordo che seguivo il loro chiacchierio e con l’acquolina in bocca cercavo di indovinare dai profumi il cibo che avrei mangiato a tavola; c’era sempre qualcuna che si impietosiva e mi offriva un boccone di quanto cucinato.
Da lì passavo nell’anticucina, il regno di Paolo, l’autista palermitano che lavorava a casa Agnello da quando papà mio aveva quattro anni. Ormai anziano, Paolo guidava raramente, ma papà, che amava stare al volante, se lo portava seduto accanto a sé, per compagnia. Si volevano bene assai.
In inverno, Paolo stava accucciato accanto alla caldaia a carbone che dava acqua ai bagni e riscaldava i termosifoni, accudendola puntigliosamente. Era goloso, e io condividevo con lui le caramelle che tenevo nella tasca del mio grembiulino; le succhiavamo insieme, lentamente, per farle durare più a lungo, come due complici, e nel frattempo lui mi raccontava storie della Grande Guerra, quando era andato a finire a Costantinopoli, dove si mangiavano i dolci più buoni del mondo e vivevano donne dagli occhi bellissimi e il volto velato. Quando la caramella s’era dissolta completamente, lasciavo Paolo e tornavo in cucina. Mi sedevo sulla scaletta usata per raggiungere i ripiani alti degli scaffali del riposto e sentivo gli odori della cucina. Ricordo in particolare quello delle patate bollite, pelate e schiacciate per farne il purè, da cui esalava il profumo dell’amido che mi invigoriva. La ragazza che grattugiava il parmigiano per riempire la formaggera della tavola dei “grandi” mi offriva immancabilmente una scaglia di parmigiano da succhiare che mi portava in paradiso. Io intanto odoravo i profumi delle erbe per cucinare che crescevano nelle graste (basilico, prezzemolo, rosmarino), della lavanda, che non si mangiava ma si diceva che allontanasse le mosche, quelli delle “polverine” per i dolci (cannella, chiodi di garofano, noce moscata) e quelli delicati e inebrianti delle foglie di alloro e dei baccelli di vaniglia.
Attraverso l’olfatto e il gusto sono arrivati i primi assaggi di cuntintizza, e, dopo settant’anni, continuo a sentirne l’eco.
![]()
La cucina è il mio ambiente preferito sin da piccola, la stanza che guardavo con più attenzione quando entravo in una casa. E non mi riferisco alle mura che la delimitano, quanto piuttosto all’aria che vi si respira standoci dentro, alla sensazione che trasmette ogni “attrezzo di scena”: il tavolo, il frigorifero, i fuochi, la bilancia, la dispensa, tutti gli utensili.
Ogni cucina ha un suo carattere e comunica qualcosa a cui non si può restare indifferenti. Entrarvi è sempre un’avventura, un po’ come esplorare una parte di mondo ancora sconosciuta.
La cucina è il posto in cui tutti i sensi trovano appagamento. Tocchiamo gli ingredienti valutandone la consistenza, ascoltiamo il rumore gentile del soffritto che sfrigola, osserviamo come le materie prime vengono lavorate, tagliate, impastate, messe a bollire, a friggere o a stufare. Misuriamo come sentinelle l’odore che esce dal forno, monitoriamo la cottura sui fornelli. Da adulta ho imparato a contare sul mio olfatto più che sulle lancette dell’orologio che troneggia in tutte le cucine.
Da bambina mi piaceva osservare tutto quello che succedeva lì dentro. Mi sedevo su una sedia appoggiata al muro – non al tavolo di lavoro – nella speranza di poter offrire nel mio piccolo un aiuto quando mi era consentito, quando c’erano degli incarichi adatti, altrimenti mi bastava restare lì anche solo a guardare, aspettando paziente. Attendevo che Giacomina, la persona di servizio che lavorava in casa nostra fin da prima che io nascessi, si degnasse di darmi qualche compito. Era lei la sovrana della cucina. Di tanto in tanto io le domandavo, insistente: «Ti posso aiutare?», ma la sua risposta era invariabilmente: «Costà, vattinni a giocare, cà io haiu cosi ri fari». Altre volte, nelle ore morte del pomeriggio, Giacomina mi lasciava invadere il suo regno (suo solo quando mia nonna era impegnata a fare altro). Sembrava dura, ma in fondo non lo era, e alla fine cedeva: prendeva da un cassettino il mio grembiule da cucina impermeabile, regalo londinese di nonna Teresa, mi aiutava a indossarlo facendo un bel fiocco dietro e finalmente io potevo mettermi all’opera.
Giacomina cucinava il pranzo e la cena, mentre preparare i dolci era una prerogativa dei membri della famiglia. Lei era molto golosa e li mangiava con voracità, ma non ha mai chiesto una ricetta. Quando si dedicava alle minestre io ero addetta a spezzare gli spaghetti: li metteva interi in una mappina a quadri e con le sue mani grosse e forzute li rompeva, mostrandomi come fare, e io la copiavo. Il rumore dello spaghetto rotto con le mani fino a ridursi in minuscoli pezzetti mi faceva sentire utile e parte di una squadra; ogni tanto aprivamo il panno per vedere se i pezzi di pasta erano della grandezza giusta, quella adatta al brodo.
![]()
Da bambina, nella campagna di Mosè, la tenuta di mamma, andavo in cucina di pomeriggio, guardavo tutto il bendidio appena raccolto e portato dai contadini nelle ceste e immaginavo le pietanze che sarebbero state preparate e cucinate.
Cucinare significa toccare la materia prima, lavarla, pulirla, tagliarla, impastarla e infine creare le ricette. È un lavoro di immaginazione e trasformazione. Odio la dipendenza dai macchinari che oggi affollano gli scaffali. Odio l’apparato di utensili nei cassetti delle cucine moderne, dal coltello elettrico al mixer, al frullatore, all’impastatrice. Non c’è più bisogno di assaggiare l’impasto per abbinare gli ingredienti, e tutti quegli accessori hanno impoverito la manualità – tritare la cipolla, l’aglio e il prezzemolo, ridurre in polvere le stecche di cannella, lavorare l’impasto e infine lavare a mano piatti e pentole: ormai, tutto è inghiottito dalla lavapiatti.
Le cameriere, dopo il riposo pomeridiano, mondavano le verdure in cucina, sedute in cerchio attorno al sacco. Io imparavo da loro: sceglievano le parti più tenere e in condizioni migliori per essere servite bollite e poi condite con olio e limone. Quelle rimaste venivano sminuzzate e cotte con cipolla e patate per la minestra, o si tenevano nel frigorifero come “battuto” da aggiungere nei giorni seguenti a piatti di carne e minestre. Mi affascinava questo maneggiare, scegliere, per poi seguire la tradizione e le ricette antiche, ed ero felice di farlo con loro. Le cameriere mi proteggevano e dunque mi assegnavano compiti facili, con una di loro che mi dirigeva e sorvegliava. Ne ero grata: mi sentivo “grande” e privilegiata a lavorare con loro e ascoltare il loro ciarmulio.
Di pomeriggio, in campagna, una volta rigovernato dopo il pranzo, le donne di servizio andavano nelle loro stanze a riposare, lasciando la cucina pulita – l’odore della liscivia con cui era stato lavato il pavimento era forte e gradevole. A quel punto era il turno di mamma e zia Teresa, che vi andavano, sole sole, a “fare i dolci”. Io sentivo il loro ticchettio di tacchi e le raggiungevo. Spesso facevano la pasta reale (mandorle tritate e zucchero a cileppo, lavorati a mano fin quando il composto, rassodato ma ancora malleabile, è pronto per l’ultimo passaggio: essere colorato di verde), come chiamiamo noi il marzapane, e ne mettevano da parte un terzo per modellarne palline da offrire agli ospiti assieme al caffè. Io avevo il compito di fare palline piccole piccole, tutte uguali, che poi passavo nello zucchero cristallizzato, e ne ricevevo due o tre da mangiare subito. Le altre si conservavano in una scatola di metallo per quando ci fossero stati ospiti. Ricordo la gioia di assaporare la pallina fatta da me, lo stridere dello zucchero tra i denti e il denso profumo della pasta reale.
Prima di congedarmi, a lavoro finito, mamma non mancava mai di regalarmi un ultimo pezzettino avanzato di pasta reale che aveva tenuto nascosto.
Al contrario di me, mia sorella Chiara e Gabriella, la figlia di zio Giovanni che era sua coetanea e con cui passavamo tutte le estati in campagna, non amavano andare in cucina. Loro due erano canterine e si divertivano a cantare a squarciagola all’aria aperta sui balconi, o mentre passeggiavano nei campi e nei cortili della fattoria – una cuntintizza a me negata dai miei genitori e dai cugini più vecchi, perché ero stonata.
![]()
Quando si dice “campagna”, soprattutto se preceduto da aggettivo possessivo, si intende una proprietà che per lo più comprende residenza padronale, giardini e terra coltivata. Andare in campagna, andare “nella nostra campagna” sono locuzioni che possono suonare con sfumature diverse. Per me è più che un semplice spazio all’aperto lontano dalla città. È una condizione, è libertà. Quando sono in campagna sento che la natura mi offre tanto e ha un potere rigenerante molto forte.
La campagna ci insegna a gioire di cose semplici, con poco.
La nostra campagna, San Basilio, si trova a pochi chilometri da Caltagirone, nella parte sudorientale della Sicilia. La cittadina barocca è conosciuta per la famosa scalinata composta da centoquarantadue gradini decorati con maioliche di ceramica che collega la parte più recente in basso a quella più antica in alto.
La casa in cui oggi abitiamo è un ex monastero che appartiene alla nostra famiglia dal 1704, un tempo occupato da monaci basiliani. La sua posizione strategica, su una collina, permette di controllare la strada che dalla costa meridionale risale verso l’interno. Dentro le mura che delimitano il cortile, c’è un baglio in pietra viva con una fontana che ancora oggi butta acqua. E nello stesso spazio si trova una chiesetta ormai sconsacrata. Si accede al cortile attraverso un grande cancello in ferro battuto che la sera viene chiuso.
In cima a quella collina, San Basilio sembra un luogo sospeso nel vuoto, soprattutto perché vi si arriva dal basso, per poi imboccare una stradina sterrata nascosta da una vegetazione folta che si rinnova di stagione in stagione e che conduce a destinazione. Tutto intorno, solo distese di terra coltivata e di alberi a perdita d’occhio, una sequenza di poderi e di attività agricole. Quando eravamo piccoli, io e mio fratello Giuseppe vi trascorrevamo parecchio tempo, a volte da soli, altre volte in compagnia di altri bambini, figli di amici dei nostri genitori. In realtà a noi piaceva stare lì a qualsiasi condizione ed eravamo felici comunque.
Il viaggio da Palermo era lungo, e ogni chilometro sembrava raddoppiare nella nostra immaginazione, tanto era il desiderio di arrivare e ritrovare le meraviglie che sapevamo là ad aspettarci. L’ultimo tratto percorso in auto scopriva progressivamente la nostra meta: il folto dei cespugli, i filari di alberi di agrumi, poi un angolo della casa e soprattutto il tetto, di colore rosso mattone, che spiccava là in alto come promessa mantenuta intatta nella memoria. Che gioia! Tutto era lì un’altra volta, tangibile, reale, dolce e profumato.
In campagna si giocava tanto, e spesso i giochi erano quelli che in città non erano consentiti. E oltre al puro diletto, ci aspettavano esperienze allettanti che talora suonavano quasi trasgressive. Ad esempio la libertà di non farsi il bagno ogni giorno, a patto però di lavarsi i denti e la faccia (almeno quello). Era il...