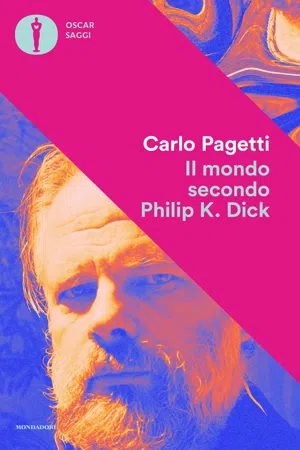We Can Build You si inserisce in quella produzione narrativa di Philip K. Dick in cui i paradigmi e i simboli più efficaci della fantascienza si confrontano con una vena realistica dalle evidenti motivazioni autobiografiche e con l’ambizione dello scrittore di «raccontare» l’America del tempo presente. Proprio la sua ambiguità «generica», che è stata considerata a lungo un elemento di debolezza del romanzo, tanto da suscitare le riserve di alcuni dei maggiori studiosi dickiani (Darko Suvin, Kim Stanley Robinson, Patricia S. Warrick), consente oggi una rilettura assai più approfondita e problematica di questo «ibrido» letterario. Decisivo, in questo senso, è lo spazio critico riservato a We Can Build You (ben tre contributi, su cui occorrerà ritornare) nella raccolta di saggi Philip K. Dick. Contemporary Critical Interpretations, curata da Samuel J. Umland (1995).
Dal punto di vista fantascientifico, del resto, We Can Build You è una miniera di spunti che verranno sviluppati estesamente in molte opere degli anni Sessanta del Novecento: Martian Time-Slip, The Simulacra, Do Androids Dream of Electric Sheep? Uso il tempo futuro perché la prima stesura di We Can Build You si conclude nel 1962, anche se il romanzo viene pubblicato solo dieci anni dopo nella sua versione definitiva. Secondo Gregg Rickman, Do Androids e We Can Build You «possono essere considerati quasi come gemelli». Il romanzo conserva inoltre più di un’eco di The Man in the High Castle, tanto è vero che, sia pure in modo obliquo, esso affronta ancora il problema dell’assoluta relatività e della manipolabilità degli eventi storici. Così il cinico speculatore edilizio Sam K. Barrows potrà suggerire di far combattere nuovamente la Guerra civile americana da due eserciti di androidi, in modo da rimetterne in discussione l’esito. La caduta dei valori etici, fortemente sentita da Dick, si traduce nell’immaginario fantascientifico di una società in cui un cittadino su quattro è considerato uno squilibrato e lo stato gestisce una catena di case di cura simili a penitenziari. L’interesse per la condizione del malato di mente si manifesta con grande evidenza nel corso di We Can Build You e rinvia ad altre opere dickiane, come Martian Time-Slip e Clans of the Alphane Moon. Nel già citato volume di Umland, Anthony Wolk ricostruisce, a questo proposito, l’interesse che Dick aveva sviluppato per le opere di un gruppo di psichiatri e psicologi, che contestavano l’impostazione tradizionale delle loro discipline, cercando un approccio più esistenziale e «filosofico» allo studio della schizofrenia: Ludwig Binswanger, John D. Benjamin, Jacob S. Kasanin.
Certamente We Can Build You appartiene anche a un momento creativo, situato tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, in cui Dick sente forte l’impulso di affermarsi come scrittore «serio», non condizionato dai vincoli del mercato SF. Egli compie perciò un suo viaggio personale, in cui i «ferri del mestiere» dell’autore di fantascienza, pur senza essere dimenticati, vengono diluiti e immersi in un paesaggio largamente contemporaneo, connotato dai tic e dalle ossessioni della provincia americana, consumata dalla paranoia e dalla solitudine esistenziale, composta da famiglie dysfunctional, attraversata dalle angosce del fallimento personale e dell’inadeguatezza psicologica.
Nello stesso tempo, We Can Build You si proietta in modo sorprendente verso la narrativa dickiana del decennio successivo, animata da una carica visionaria e da una tensione autobiografica ancora più forti, influenzata dalle manifestazioni sovrannaturali a cui l’autore affermava di aver assistito nel febbraio e nel marzo 1974. A Scanner Darkly sarebbe stata la prova dell’angoscia esistenziale dello scrittore, ma anche della sua volontà di disciplinare le tumultuose esigenze interiori in un racconto lucido e disperato. Nella massa degli appunti successivi alla rivelazione mistica che compongono l’Exegesis, riorganizzati e selezionati da Lawrence Sutin, Dick scrive a proposito dei suoi romanzi: «I lettori dicono che dipingo sempre lo stesso mondo, un mondo riconoscibile. Dov’è questo mondo? Nella mia testa? È quello che vedo nella mia vita e che inconsapevolmente trasferisco nei miei romanzi e nei lettori? Almeno sono coerente, dal momento che è tutto un solo romanzo. Ho il mio mondo speciale». Lo scrittore non è più in grado di distinguere tra la sua esperienza soggettiva e il mondo fittizio dei suoi romanzi. In seguito, cercando di dare una suddivisione tematica ai suoi romanzi, classifica succintamente come una riflessione sulla «nostra condizione [di esseri umani]» il trittico di «SCANNER [A Scanner Darkly] SHEEP [Do Androids Dream of Electric Sheep?] WE CAN BUILD YOU».
Le date, quelle reali e quelle fittizie, sono, come al solito, importanti. La prima stesura di We Can Build You, come ho già accennato, si situa tra il 1961 e il 1962, quando regge ancora il matrimonio tra Phil e Anne Williams, la vedova del poeta Rubenstein, la terza moglie di Dick, la più colta ed esigente, che aveva stimolato le ambizioni dello scrittore. Assieme ad Anne, Dick visita Disneyland e viene colpito dal rilievo dato alle commemorazioni della Guerra civile (1861-1865), in occasione del primo centenario del conflitto che aveva diviso il Nord e il Sud degli Stati Uniti. We Can Build You è anche una obliqua rivisitazione del mito eroico della guerra tra nordisti e sudisti e, insieme, una riflessione sulle nevrosi e sulle angosce sessuali che stavano minando le basi del matrimonio di Phil e Anne. Seguendo il destino di altri romanzi «realistici» di Dick, We Can Build You non trovò un editore almeno fino al novembre 1969, quando una sua versione apparve su «Amazing», appunto con il titolo A. Lincoln, Simulacrum, mentre solo nel 1972 esso uscì, ulteriormente ritoccato, in volume.
Il romanzo è ambientato nel «futuro» del 1982, ma le tracce della sua proiezione avveniristica, seppure importanti, sono volutamente circoscritte e tendono a ricollegarsi esplicitamente ai miti americani degli inizi degli anni Sessanta: il sistema solare comincia a essere colonizzato, e dunque, malgrado l’automobile rimanga un essenziale strumento di locomozione, i mezzi di trasporto si sono andati perfezionando. All’avanguardia sono anche gli strumenti musicali costruiti dalla ditta di Louis Rosen, il protagonista che ha sangue tedesco nelle vene (come talvolta faceva credere di sé lo stesso Dick), e del socio e amico Maury Rock, il cui autentico cognome fa Frauenzimmer.
La popolazione americana appare aggredita dalle malattie mentali, come succede in Martian Time-Slip, e da quelle di origine genetica, come indica il volto clownesco di Chester, il fratello mostruoso di Louis. In tutto il romanzo, il confine tra razionalità e follia è altrettanto precario di quello che divide narrativa mainstream e fantascienza, e della linea di demarcazione che dovrebbe separare gli esseri umani e i due androidi costruiti da Maury, con l’aiuto della figlia Pris, per sconfiggere la concorrenza dei grandi monopoli industriali.
Gli androidi impersonificano Edwin M. Stanton, il ministro della Difesa del presidente Lincoln, e Lincoln stesso. Repliche consapevoli di appartenere a un’altra epoca, essi tentano di adattarsi al nuovo imprevedibile universo con sobrietà e forza d’animo. A differenza degli androidi di Do Androids Dream of Electric Sheep?, che, nell’interpretazione di Dick, sono crudeli e implacabili, Stanton e soprattutto Lincoln appaiono come prototipi di un’umanità di cui si è perduto lo stampo, strutture prodigiose non tanto per il trionfo tecnologico di cui sono il frutto, ma per le doti di comprensione che sembrano emanare. Certo, la loro entrata in scena contiene più di un elemento farsesco, come se Dick volesse rimarcare il suo distacco dall’impostazione «scientifica» di Asimov, rifacendosi parodicamente piuttosto alle leggende del Golem.
Così, l’automa di Stanton emerge davanti agli occhi scettici e sconcertati di Louis da uno strato di giornali in cui era stato avvolto, e viene subito dopo «parcheggiato» a casa dello stesso Louis, essendo affidato alle cure di un altro vecchio, Jerome, il burbero padre di Louis. D’altra parte, Lawrence Sutin osserva, in Divine invasioni. La vita di Philip K. Dick, come, durante una discussione con Barrows, sia proprio Lincoln a rivendicare per l’umanità il possesso esclusivo di un’anima, in contraddittorio con il materialismo del suo disumano oppositore, il quale ha fatto costruire una ridicola caricatura dell’attore John Wilkes Booth, l’assassino del Lincoln ottocentesco, per tacitare il saggio androide.
Legando strettamente momenti di riflessione intellettuale e di azione comica, con una libertà che appartiene ai grandi scrittori, Dick procede – nella stessa scena – a liquidare il grottesco automa assassino, facendolo colpire sulla testa dal tacco a spillo di Pris Frauenzimmer, la fanciulla che crea e distrugge, la datrice di vita che non esita a por fine a un esperimento, una vera e propria Frankenstein in gonnella, di fronte a cui tutti si rivelano poveri mostri innamorati e impotenti: il padre Maury, Louis Rosen, prigioniero di un rapporto di odio-amore che ne rivela tutta la debolezza e l’insicurezza virile, e perfino il tycoon Barrows, che si approfitta di lei, ma viene smascherato pubblicamente dalla ragazza diciottenne, la quale usa un linguaggio spregiudicato nei confronti dei vari maschi a lei interessati, che è degno di una eroina femminista.
Sutin ci ricorda che, mentre il marito era impegnato nella stesura di We Can Build You, Anne, già madre di tre bambine avute dal precedente matrimonio e di Laura Archer, nata nel 1960, aveva deciso di interrompere una nuova gravidanza, nonostante l’opposizione di Philip. Il senso di una perdita irrevocabile circola tra le pagine del romanzo e si coagula attorno alla figura della donna fatale: Pris Frauenzimmer, figlia e madre insieme, diabolica seduttrice (il padre traduce il suo cognome tedesco in Streetwalker, passeggiatrice) e forse anche incarnazione della sorella gemella di Dick, morta tre settimane dopo la nascita, e di tutte le donne che continuavano ad agitare la fantasia dello scrittore, riconoscibili nell’archetipo della dark-haired girl, la fanciulla dai capelli neri, tanto più desiderabile quanto si rivela irraggiungibile, e capace di infliggere ferite umilianti al suo spasimante, sottoposto, nel primo incontro in automobile, a uno spietato interrogatorio (perché non si è sposato? È omosessuale? O è così brutto da scoraggiare ogni possibile fidanzata?). Pris è abbreviativo di Pristine, la creatura intangibile, primigenia, una belle dame sans merci che non ha più niente di romantico, pur essendo capace di ammaliare e sedurre.
Anche le figure maschili, però, giocano un ruolo non secondario in questo racconto di sconfitte e di fallimenti personali. Nella sua interpretazione di We Can Build You, Rickman ha voluto richiamare la figura del nonno materno di Philip K. Dick, che avrebbe sottoposto il futuro scrittore e forse anche la madre di lui a una serie di abusi sessuali. Ciò che è certo è che il motivo dell’incesto (in fin dei conti, Maury, il padre di Pris, e Louis si comportano come due fratelli, e Pris potrebbe essere benissimo la figlia di Louis) circola in questa opera, come in altre dello scrittore californiano.
L’autobiografismo di Dick è però complicato e arricchito dal gioco dei riferimenti letterari, non solo al Frankenstein della giovane Mary Shelley (di cui Pris è una sorta di reincarnazione crudele) o ai testi canonici dell’infanzia – Peter Pan e Winnie the Pooh – il cui mondo innocente affascina il simulacro di Lincoln. Altre indicazioni più sottili percorrono il testo dickiano: il racconto di Louis Rosen, della sua lotta disperata per ottenere Pris, degli ambigui rapporti che entrambi intrattengono con il potente Barrows rinviano parodicamente al Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, e a una nuova versione della fine del Sogno Americano. Pris richiama anche la Lolita di Nabokov, che aveva pubblicato il suo romanzo più famoso nel 1955. L’impotenza di Louis di fronte a Pris ricorda quella del protagonista de Il sole sorge ancora di Hemingway, come rileva Rebecca Umland, la quale giunge a dimostrare in modo efficace la presenza nel romanzo dickiano del modello cavalleresco dell’amore cortese, quello delle storie di Lancillotto e Ginevra, e di Tristano e Isotta, in cui il cavaliere innamorato compie azioni impulsive ed esagerate, sottoponendosi ai rimproveri della donna agognata. D’altra parte, le allusioni alla Guerra civile americana stabiliscono una relazione con la narrativa gotica di Ambrose Bierce, lo scrittore californiano della fine dell’Ottocento, che aveva rappresentato la lotta tra il Nord e il Sud in termini macabri e antieroici. Da Bierce, oltre che dal Frankenstein, può derivare il motivo del simulacro, che è già sviluppato nel racconto Il padrone di Moxon, la storia dell’automa scacchista che uccide il suo padrone. In un certo senso il richiamo a Bierce serve al lettore per non cadere in una visione troppo idealizzata di Lincoln e dei suoi tempi. Infatti, anche se l’androide Lincoln esibisce qualità umane superiori a quelle dei suoi interlocutori, egli porta con sé molti pregiudizi ottocenteschi, a cominciare dall’appoggio paternalistico concesso ai neri, da lui considerati comunque una razza inferiore. Del resto, il nuovo Lincoln è sì innocente delle brutture del mondo – non beve, non va a donne, non si fa corrompere –, ma proprio la sua purezza è il segno di un carattere artificiale, di un ineluttabile infantilismo, dell’impossibilità a cogliere le contraddizioni del mondo moderno. Lincoln è il fantoccio di un passato fossilizzato e irrecuperabile.
Anche la progressiva identificazione di Louis Rosen con Lincoln, alla luce dello stato malinconico e del temperamento lugubre che li accomuna, contiene un forte elemento parodico, se si considera la vocazione alla mediocrità e al fallimento del protagonista, l’ultimo di una catena discendente di eroi letterari che vanno da Amleto, il protettore di tutti gli ipocondriaci, ad Abraham Lincoln, il grande presidente degli Stati Uniti, soggetto a momenti di depressione, giù fino al suo simulacro, ridotto a fare il consulente legale per una piccola ditta, e a quell’ombra di uomo che, a poco a poco, diventa Louis Rosen, roso dai suoi dubbi, dalle manie di persecuzione, dal suo amore esaltato e improvviso per una ragazza diciottenne schizofrenica che lo disprezza e si serve di lui, e che può essere posseduta solo in una fantasia psicotica, dove ogni desiderio si realizza nel più totale distacco dalla realtà.
Così il romanzo di fantascienza, per sua natura gravido di eventi apocalittici, di situazioni clamorose, di mirabolanti invenzioni, si trasforma nella vicenda strettamente privata di un io scisso e lacerato, nel racconto di un viaggio non nel glorioso futuro, ma nel «regno delle ombre». Infatti Louis si inoltra nelle tenebre della follia accompagnato da due androidi psicopompi, e regredisce fino alla terrificante scena primeva laddove, nel letto in cui fantastica di congiungersi alla ragazza amata, egli si imbatte nella figura del padre, e intorno a lui, come attorno ad altri personaggi dickiani, si chiude il cerchio implacabile della famiglia d’origine: il padre-Dio, che parla un po’ in tedesco, un po’ in yiddish, e la madre-amante, assieme al figlio-mostro, intenti ad assistere al disfacimento di Louis Rosen, «il povero nulla» perduto nell’universo dei propri sogni inconfessabili, il frutto di un concepimento insensato e deforme, l’autore di opere deformi, lo scrittore di fantascienza.
Ciò che dà intensità al racconto di questo progressivo sfilacciarsi della trama dell’esistenza è l’uso – innovativo in Dick, non a caso sperimentato in precedenza solo in Confessions of a Crap Artist, e recuperato pienamente in seguito in The Transmigration of Timothy Archer – della tecnica dell’io narrante. In questo modo, la manifestazione della soggettività si fa più esasperata e totale, e ancora più improponibile appare la scoperta di un altro, di un principio di alterità, con cui l’io di Louis Rosen possa misurarsi, per ricostituirsi in quanto identità autonoma, capace di reagire al caos che lo sta inghiottendo.
Il dolore lancinante prodotto dall’incontro con l’altro è uno dei motivi conduttori di We Can Build You: l’incommensurabilità delle distanze – sia che si tratti del benigno androide Lincoln, sia che si tratti di Pris – rende più angoscioso il linguaggio. E se la figura paterna viene parzialmente esorcizzata attraverso la replica caritatevole e desessuata dell’antico «padre della patria» Lincoln, nulla si può fare con/contro l’implacabile presenza/assenza femminile di quel simulacro d’amore che è Pris Frauenzimmer. Mentre il legame con Anne si avviava a concludersi, We Can Build You mette in scena l’impossibilità di una conciliazione con il mondo delle donne e con i loro poteri creativi (a chi, se non alle donne, è dato affermare «noi possiamo costruirvi?»), inventando – nel corpo di un romanzo di fantascienza – la storia di un’ossessione amorosa folle e sconclusionata, tra un inventore/artista fallito e Priscilla Frauenzimmer, «una cosaoggetto [thingthing] crudele, fredda e sterile», ma anche «la vita stessa» (She’s life itself), ovvero il suo alter ego Pristine Womankind, ovvero la misteriosa Silvia Devorac, la nemica di Barrows, che Louis non riuscirà mai a incontrare; ovvero, ancora, Ann Rutledge, la fanciulla amata dal giovane Lincoln, o Anne Williams Rubenstein, la terza moglie, o quante altre immagini femminili popolavano ossessivamente la mente di PKD. Alla fine, ridotto all’osso, We Can Build You è una straziante storia d’amore – ciò che la fantascienza non ha mai voluto o saputo raccontare apertamente –, ma è anche una paradossale dichiarazione di fiducia nei confronti di una forma narrativa (post)moderna, a cui anche la fantascienza partecipa con piena dignità letteraria. Calatosi dentro il «mondo» sotterraneo e infernale della sua opera (e della sua mente), come avrebbe scritto nell’Exegesis, lo scrittore americano dà voce ai suoi personaggi, riconoscendo loro il potere supremo di ri-costruirlo, e mettendo in scena brandelli della sua precaria esistenza. Perciò, non I can build you (io autore posso costruir voi personaggi), ma, appunto, we (noi p...