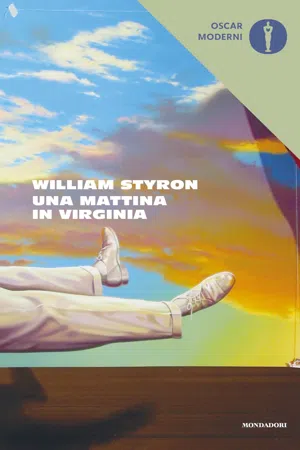A Parigi, nel 1985, in una gelida serata di fine ottobre, per la prima volta mi resi conto che la battaglia contro la malattia della mia mente, una battaglia che mi teneva impegnato da molti mesi, avrebbe potuto avere un esito fatale. Questa rivelazione mi colpì mentre l’automobile sulla quale viaggiavo percorreva una strada resa sdrucciolevole dalla pioggia, non lontano dagli Champs-Élysées, e passava vicino alla luce smorta di un’insegna al neon che recava la scritta «Hôtel Washington». Non vedevo quell’albergo dalla primavera del 1952, più di trent’anni prima, quando per parecchie notti era stato il mio iniziale e provvisorio alloggio parigino. Nei primi mesi del mio Wanderjahr ero arrivato a Parigi in treno da Copenhagen, ed ero approdato all’hotel Washington guidato dall’imprevedibile determinazione di un agente di viaggio newyorkese. All’epoca l’albergo non era che una delle numerose, umide e scialbe locande destinate a turisti squattrinati (soprattutto americani) che, se come me facevano per la prima volta la conoscenza dei francesi e delle loro amene eccentricità, avrebbero poi ricordato per tutta la vita quanto l’esotico bidet che troneggiava nella squallida camera da letto e la toilette confinata laggiù in fondo al corridoio male illuminato bastavano a definire l’abisso fra la cultura gallica e quella anglosassone. Io però ero rimasto all’hotel Washington solo per poco tempo. In capo a qualche giorno ero stato premurosamente sottratto a quella dimora da alcuni giovani amici americani di recente conoscenza, che mi avevano sistemato in un albergo a Montparnasse, ancora più fatiscente ma senz’altro più pittoresco, vicinissimo a Le Dôme e ad altri ritrovi letterari di chiara fama. Avevo solo venticinque anni, e la celebrità che mi aveva procurato il mio primo romanzo era decisamente limitata, visto che pochi americani residenti a Parigi avevano sentito parlare del mio libro, e meno ancora l’avevano letto. Così, con il trascorrere degli anni, l’hotel Washington era gradualmente scomparso dalla mia coscienza.
Ed eccolo riapparire, quella sera d’ottobre, mentre oltrepassavo la facciata di pietra grigia sotto una tenue pioggerella, e il ricordo di quel mio arrivo di tanti anni prima cominciò a pervadermi ed ebbi la sensazione di essere tornato, fatalmente, al punto di partenza. Rammento ora di aver pensato che quando sarei partito da Parigi alla volta di New York, il giorno dopo, sarebbe stato per sempre. Ero sconvolto dall’ineluttabilità con cui accettavo l’idea che mai più avrei rivisto la Francia né avrei ritrovato la lucidità che mi stava abbandonando con una velocità terribile.
Solo pochi giorni prima, avevo dovuto ammettere che soffrivo di una seria malattia di natura depressiva, e che mi stavo dibattendo impotente nei miei tentativi di tenerla a freno. Neppure la festosa occasione che mi aveva condotto in Francia riusciva a rallegrarmi. Fra le molteplici e temibili manifestazioni della malattia, sia fisiche sia psicologiche, uno dei sintomi più universalmente noti è l’insorgere di un senso di avversione per se stessi, una caduta dell’autostima, e io, a mano a mano che il malessere progrediva, ero stato colto da una sensazione crescente d’inutilità. Eppure, questa mia opaca malinconia era tanto più paradossale in quanto avevo intrapreso questo precipitoso viaggio di quattro giorni a Parigi per ricevere un premio che avrebbe dovuto ristabilire brillantemente il mio ego. Pochi mesi prima, infatti, avevo saputo di essere stato scelto per ricevere il Prix Mondial Cino del Duca, un riconoscimento assegnato annualmente a un artista o scienziato la cui opera riflette tematiche o principi di carattere «umanitario». Il premio era stato istituito in memoria di Cino del Duca, un immigrato italiano che aveva accumulato una fortuna negli anni intorno alla Seconda guerra mondiale prima curando la stampa e la distribuzione di riviste piuttosto dozzinali (soprattutto fumetti), poi estendendo i propri interessi a pubblicazioni di qualità e acquistando il quotidiano «Paris Jour». Aveva anche prodotto film ed era stato un importante proprietario di cavalli da corsa, attività quest’ultima a cui doveva la gioia di numerose vittorie sia in Francia sia all’estero. L’aspirazione a più elevate gratificazioni culturali aveva fatto di lui un rinomato filantropo, inducendolo fra l’altro a fondare una casa editrice che cominciò a pubblicare opere di un certo valore letterario (curiosamente, una delle proposte editoriali di Del Duca fu proprio Un letto di tenebre, il mio primo romanzo). Quando morì, nel 1967, la sua casa editrice Éditions Mondiales era diventata una componente rispettabile di un impero multiforme, ricco e prestigioso al punto di aver quasi completamente cancellato il ricordo delle sue origini «fumettesche»; fu allora che la vedova di Del Duca, Simone, decise di dar vita a una fondazione la cui principale funzione doveva essere l’assegnazione annuale del premio omonimo.
Il Prix Mondial Cino del Duca è riuscito ad acquisire grande credito in Francia (una nazione che nutre una simpatica infatuazione per premi e riconoscimenti) non solo per l’eclettismo e l’originalità dimostrati nella scelta degli assegnatari ma anche per la generosità del premio, che quell’anno ammontava a circa venticinquemila dollari. Fra i precedenti vincitori c’erano stati Konrad Lorenz, Alejo Carpentier, Jean Anouilh, Ignazio Silone, Andrej Sacharov, Jorge Luis Borges e un solo americano, Lewis Mumford. (Le femministe prendano nota: nessuna donna, finora.) Soprattutto in quanto americano, mi era difficile non sentirmi onorato dall’essere incluso in una lista del genere. Mentre il dare e il ricevere premi generalmente inducono in tutte le parti in causa morbosi accessi di falsa modestia, maldicenza, invidia e tormento, la mia opinione personale è che ricevere certi premi, sebbene non essenziale, può essere molto piacevole. E, per l’appunto, il Prix Cino del Duca costituiva per me un riconoscimento così francamente piacevole da far apparire fuori luogo qualsiasi complessa autoanalisi al riguardo, dunque accettai con gratitudine e scrissi in risposta che avrei soddisfatto senza difficoltà la ragionevole richiesta di presenziare alla cerimonia. In quel momento mi si profilava dinanzi un sereno viaggio di piacere, non un’andata e ritorno in fretta e furia. Se fossi stato in grado di prevedere l’andamento delle mie condizioni mentali mentre la data della cerimonia si avvicinava, non avrei neppure accettato il premio.
La depressione è una disfunzione emotiva così misteriosamente dolorosa ed elusiva nel suo modo di farsi conoscere all’Io, o perlomeno all’intelletto raziocinante, da rasentare la totale indescrivibilità. Per questo risulta quasi incomprensibile a chi non l’ha sperimentata nella sua forma estrema, anche se il cattivo umore, le «lune» che occasionalmente affliggono le persone e che tendono a venire associate alle generali difficoltà dell’esistenza di tutti i giorni sono così comuni da dare a molti individui almeno una vaga idea di cosa possa essere la malattia nella sua forma catastrofica. Io però, al tempo di cui scrivo, ero giunto ben al di là di tali familiari, tollerabili paturnie. A Parigi, ora lo so bene, mi ero trovato a uno stadio critico del decorso della malattia, minacciosamente a metà strada fra i vaghi turbamenti che l’avevano annunciata all’inizio dell’estate e l’epilogo quasi violento di dicembre, che avrebbe avuto come esito un ricovero in clinica. Più avanti cercherò di descrivere l’evoluzione di questo malessere dalle sue più remote origini fino al mio soggiorno in clinica e alla convalescenza, ma il viaggio a Parigi rimane per me particolarmente significativo.
Il giorno fissato per la cerimonia della premiazione, che avrebbe dovuto aver luogo a mezzodì ed essere seguita da un pranzo formale, mi svegliai a metà mattina nella mia stanza all’hotel Pont Royal notando fra me e me che mi sentivo abbastanza in forma, e comunicai la buona notizia a mia moglie Rose. Con l’aiuto di un blando tranquillante, l’Halcion, ero riuscito a sconfiggere l’insonnia e a prendermi qualche ora di riposo, perciò il morale era discreto. Sapevo però che questa pallida allegria era la solita effimera schiarita, poiché ero certo che entro il calar della sera sarei stato da cani. Ero arrivato al punto di poter controllare al dettaglio ogni singola fase delle mie condizioni nel loro deteriorarsi. Avevo accettato la malattia dopo molti mesi di rifiuto durante i quali, da principio, avevo attribuito il malessere, l’inquietudine e gli improvvisi attacchi d’ansia all’astinenza dall’alcol: a giugno di colpo avevo smesso di bere whiskey. Via via che il mio stato emotivo peggiorava, mi ero messo a leggere parecchio materiale sul tema della depressione, sia libri destinati a profani sia ben più ponderosi testi professionali, fra cui la bibbia della psichiatria, il DSM (Diagnostic and Statistical Manual della American Psychiatric Association). Per buona parte della mia vita mi sono sentito spinto, forse con poca saggezza, a diventare un autodidatta in medicina, e su vari argomenti di interesse medico ho accumulato una competenza magari da dilettante, ma senz’altro superiore alla media (e alla quale molti miei amici, certo non saggiamente, si sono spesso affidati), sicché fu motivo di grandissima sorpresa per me scoprire di essere di un’ignoranza pressoché totale riguardo alla depressione, che può considerarsi un problema di carattere medico serio quanto il diabete o il cancro. È molto probabile che, in qualità di soggetto depressivo latente, avessi sempre inconsciamente respinto o eluso una conoscenza approfondita in questo campo; sarebbe arrivata troppo vicino al nucleo della mia essenza psichica, perciò avevo accantonato l’argomento come un’aggiunta poco gradita al mio magazzino di informazioni.
In ogni caso, di recente avevo colmato questo vuoto grazie a vaste letture, condotte durante le poche ore in cui lo stato depressivo allentava la sua morsa quanto bastava per permettermi il lusso di concentrarmi, e così avevo appreso una serie di fatti al tempo stesso affascinanti e perturbanti, che tuttavia non potevano essermi di alcuna utilità pratica. La posizione più onesta assunta dalle autorità in materia si riassume nell’ammissione che certo un trattamento terapeutico della depressione non è cosa agevole. A differenza del diabete, poniamo, per il quale un intervento tempestivo sull’adattamento dell’organismo al glucosio può invertire in modo radicale un pericoloso processo in atto e ridurlo sotto controllo, la depressione nelle sue forme più avanzate non dispone di un rimedio così efficace: proprio la mancanza di mezzi adeguati ad alleviare la sofferenza è fra i problemi connessi alla malattia quello che mette a più dura prova chi ne è colpito ed è l’elemento discriminante che permette di classificarla a pieno titolo nella categoria delle patologie più gravi. Tranne in quelle forme di malattia che vengono dichiarate maligne o degenerative, ci si aspetta sempre che esista almeno una forma di trattamento e un successivo miglioramento, per mezzo di pillole, di una terapia fisica o tramite una dieta o ancora attraverso la chirurgia, con una prevedibile progressione che da un primo alleggerimento dei sintomi porti alla guarigione finale. Cosa spaventosa a dirsi, il profano che si trovi colpito da una grave forma di depressione, nel momento in cui si azzarda a dare un’occhiata a uno dei molti libri attualmente disponibili sul mercato, trova pagine e pagine di teorie e sintomatologie ma ben poco che si riferisca alla concreta possibilità di un recupero. C’è sì qualcuno che proclama di avere rimedi sicuri, ma si tratta di personaggi un po’ troppo disinvolti se non in malafede. Tutto questo approda a una verità tanto essenziale quanto difficile da digerire, una verità che ritengo di dover comunicare proprio all’inizio della mia cronaca: la depressione rimane un grande mistero. Nel rivelare i suoi segreti alla scienza, è stata molto più avara di molti altri famosi mali che ci affliggono. Come mi disse un giorno uno psichiatra, con una certa schiettezza e una notevole capacità di analogia: «Se paragoniamo lo stato delle nostre conoscenze con la scoperta dell’America di Colombo, l’America ci è ancora ignota e noi siamo laggiù su quella piccola isola delle Bahamas».
Dalle mie letture avevo appreso, per esempio, che il mio caso aveva almeno un motivo d’interesse. La maggior parte delle persone che soffrono di questa malattia, infatti, i primi tempi si sentono particolarmente a terra al mattino, con il pernicioso risultato che non riescono neppure ad alzarsi dal letto; solo con il trascorrere della giornata cominciano a stare meglio. La mia situazione, invece, era l’esatto opposto. Mentre ero in grado di alzarmi e di vivere in modo quasi normale la prima parte della giornata, cominciavo ad avvertire il destarsi dei sintomi a metà del pomeriggio o appena più tardi: una tetraggine che si addensava dentro, un senso di paura e di alienazione e, soprattutto, un’angoscia soffocante. Ho l’impressione che sia del tutto indifferente che l’acme della sofferenza individuale sia collocata al mattino o alla sera: se questi stati di tormentosa semiparalisi sono simili fra loro, e probabilmente lo sono, la loro distribuzione all’interno della giornata diventa una questione piuttosto accademica. Sta di fatto che quella mattina, a Parigi, la mia personale inversione del classico ritmo quotidiano di comparsa dei sintomi mi consentì di procedere senza problemi, sentendomi più o meno padrone di me, alla volta del palazzo riccamente decorato, sulla rive droite, sede della Fondazione Cino del Duca. Qui, in un salone rococò, il premio mi venne consegnato al cospetto di una piccola folla di esponenti della cultura francese, e io potei pronunciare il mio discorso di accettazione con quello che mi parve un discreto aplomb, dichiarando che, se era mia intenzione donare gran parte della somma di denaro a vari istituti per la promozione della cooperazione franco-americana a fini sociali e umanitari, fra cui l’American Hospital di Neuilly, d’altra parte c’era pure un limite all’altruismo (scherzai), così mi auguravo di ottenere indulgenza se trattenevo per me una piccola porzione del totale.
Quello che non dissi, e che non era uno scherzo, era che la somma trattenuta sarebbe servita a pagare due biglietti sul Concorde per l’indomani stesso, in modo da tornare in tutta fretta con Rose negli Stati Uniti, dove alcuni giorni prima avevo preso appuntamento per una visita psichiatrica. Per una forma di riluttanza ad accettare il dato di fatto che la mia mente si stava dissolvendo, nelle settimane precedenti, nonostante lo stato di malessere fosse andato intensificandosi, avevo evitato di ricorrere all’aiuto di uno psichiatra. Ma sapevo che non avrei potuto continuare all’infinito a rimandare la cosa, e quando avevo finalmente preso contatto per telefono con un terapista di eccellenti referenze questi mi aveva incoraggiato a fare il mio viaggio a Parigi, dicendomi che mi avrebbe visitato appena fossi tornato. Così ora desideravo solo tornare, e presto. Benché fosse evidente che la mia situazione era più che seria, volevo mantenere un atteggiamento speranzoso: molta letteratura sul tema della depressione ostenta un disinvolto ottimismo e sparge a piene mani rassicurazioni sul fatto che quasi tutti gli stati depressivi possono arrestarsi o regredire purché si riesca a individuare l’antidepressivo appropriato; inutile dire che il lettore è facile preda di queste promesse di rapido rimedio. Quel giorno, a Parigi, perfino nel momento stesso in cui ero impegnato a parlare in pubblico, desideravo soltanto che la giornata passasse in fretta, e non vedevo l’ora di volare in America e precipitarmi nello studio di quel dottore che con le sue medicine miracolose avrebbe fatto piazza pulita di tutte le mie sofferenze. Ora ricordo con chiarezza quei momenti, e mi riesce quasi impossibile credere di aver nutrito una speranza così ingenua, o di aver potuto essere a tal punto inconsapevole del travaglio e del pericolo che mi aspettavano.
Simone del Duca, bruna, imponente, dal portamento regale, si mostrò prima comprensibilmente incredula e poi adirata quando, dopo la cerimonia di premiazione, le dissi che non potevo unirmi a lei per pranzare al piano superiore del grande palazzo, insieme con una dozzina circa di membri dell’Académie Française che avevano fatto parte della giuria. Il mio rifiuto fu deciso e accompagnato da una giustificazione quantomai assurda: le dissi che mi ero messo d’accordo per andare in un ristorante con la mia editrice francese Françoise Gallimard. Naturalmente, una decisione del genere da parte mia era offensiva; con mesi e mesi di anticipo ero stato informato con tutti gli altri interessati che tra i festeggiamenti del giorno era previsto un pranzo, e per di più in mio onore. In realtà il mio comportamento era il risultato della malattia, che ormai era progredita abbastanza da produrre alcuni dei suoi più famosi e sinistri contrassegni: confusione, difficoltà di concentrazione e perdita di memoria. In uno stadio successivo la mia mente sarebbe stata interamente in preda alle più anarchiche sconnessioni; ora, come ho già detto, prevaleva una sorta di biforcazione caratteriale: una certa lucidità nelle prime ore della giornata, tenebre crescenti di pomeriggio e di sera. Doveva essere stato mentre ero vittima di quella cieca confusione, la sera prima, che avevo preso appuntamento per pranzare con Françoise Gallimard scordandomi completamente i miei obblighi nei confronti della signora Del Duca. Quella decisione continuava ora a dominare in lungo e in largo i miei pensieri e creò in me una determinazione talmente ostinata da rendermi capace di insultare, sia pure in modo sfumato, la degnissima Simone del Duca. «Alors!» esclamò la signora, e il suo viso avvampò di rabbia mentre girava su se stessa in un solenne dietro front, «Au... re-voir!» Mi ritrovai di colpo a bocca aperta, pietrificato dall’orrore per quello che avevo fatto. Mi balenò dinanzi la visione di un tavolo al quale era andata a sedersi la padrona di casa, e insieme con lei i membri dell’Académie Française, ospiti d’onore a La Coupole. Implorai l’assistente di madame, una donna occhialuta con un bloc-notes e un’espressione terrea e mortificata, che mi aiutasse ad accomodare le cose: era tutto un terribile errore, un qui pro quo, un malentendu. E alla fine mi sfuggirono alcune parole, quelle che tutta una vita di equilibrio e una compiaciuta fiducia nell’inattaccabilità della mia salute psichica mi avevano sempre fatto credere impronunciabili; sentii me stesso dire a questa perfetta estranea: «Sono malato. Un problème psychiatrique». E rabbrividii.
Madame Del Duca accettò magnanima le mie scuse e il pranzo ebbe luogo senza ulteriori complicazioni, anche se io, mentre chiacchieravamo piuttosto impacciati, non riuscivo a liberarmi completamente dal sospetto che la mia benefattrice fosse tuttora infastidita dalla mia condotta e mi giudicasse un tipo bislacco. Il pranzo durò a lungo, e quando finì mi sentivo già sul limitare delle tenebre pomeridiane, con il loro dilagare di angoscia e terrore. Una troupe televisiva di un canale nazionale mi attendeva (mi ero dimenticato anche di loro), pronta a portarmi al Museo Picasso recentemente inaugurato, dove era previsto che io venissi ripreso mentre osservavo le opere esposte e scambiavo commenti con Rose. Come temevo, lungi dall’assomigliare a una simpatica passeggiata, tutto questo si rivelò un’ardua battaglia, una durissima prova. Quando arrivammo al museo, dopo aver affrontato un traffico terribile, erano le quattro passate e già cominciavo a percepire i sintomi ormai familiari del calvario a venire: panico, smarrimento e la sensazione che i miei pensieri fossero inghiottiti da una marea tossica e indefinibile che inibiva qualunque reazione di godimento agli stimoli del mondo vivente. In poche parole, invece del piacere (quantomeno del piacere che avrei dovuto provare di fronte alla vetrina sontuosa di questo genio abbacinante) avvertivo una sensazione simile al vero e proprio dolore, e tuttavia diversa in modo indescrivibile. A questo punto vorrei tornare di nuovo sulla natura elusiva di una malattia del genere. Non è un caso che abbia fatto qui capolino l’aggettivo «indescrivibile», poiché occorre dire che, se tale malessere si potesse descrivere, tanti fra gli sventurati colpiti da questo antico tormento sarebbero in grado di esprimere almeno in parte ai loro amici e ai loro cari (e anche ai loro medici) le proprie sofferenze, e forse riuscirebbero a suscitare quella comprensione che il più delle volte non trovano; non tanto perché vi sia scarsa solidarietà, quanto per l’incapacità di fondo, da parte delle persone sane, di rappresentarsi una forma di malessere così estranea all’esperienza quotidiana. Per quanto mi riguarda, la sofferenza che mi prende è una morsa simile all’annegamento o al soffocamento, ma anche queste immagini sono tutto sommato inadeguate. William James, che lottò contro la depressi...