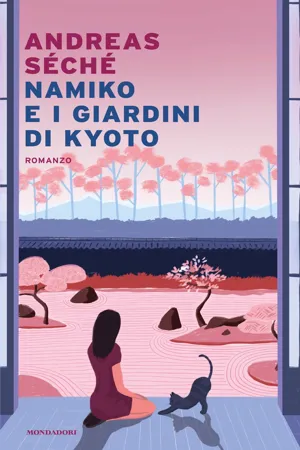Ogni volta che sento un flauto, mi torna in mente Namiko.
Namiko amava il flauto e i suoni che produceva: la rapivano trasportandole l’anima in mondi a cui non mi era dato di accedere. Quando sentiva un flauto, Namiko sembrava stregata. Di solito erano le note lente e gravi dello shakuhachi giapponese ad ammaliarla con il loro potere suggestivo, nemmeno io riuscivo a restare indifferente. Ma la musica penetrava nel suo intimo molto più in profondità che nel mio.
In generale, Namiko amava i suoni delicati. Il respiro leggero del primo vento d’ottobre, il mormorio ovattato dei ruscelli di Kyoto, lo scricchiolio della neve sul muschio, il rintocco lontano delle campane dei templi buddisti e, naturalmente, i sussurri.
A volte bastava che fosse sdraiata accanto a me nell’erba perché sentissi che si sarebbe rimessa a sussurrare. Sussurrare, diceva sempre Namiko, è come sottolineare, ma senza, appunto, sottolineare. Nel ritirare la voce, secondo lei, il peso si spostava dalla forma al contenuto, attribuendo a ciò che si voleva dire il tocco discreto delle cose significative.
«Sussurrare» mi sussurrò una volta all’orecchio «è intimità con la voce.»
Solo Namiko poteva dire cose del genere.
Quando, dopo tutti questi anni, mi guardo indietro, mi coglie quella sensazione strana che riunisce in sé felicità e malinconia. Il giorno in cui le nostre strade s’incrociarono per la prima volta, non avevo idea di quanto fosse potente il destino che si accingeva a plasmare il mio futuro. Fu a Kyoto. Namiko entrò nella mia vita con la provocazione muta di un enigma che chiedeva infine di essere risolto. Se allora non ci fossimo incontrati, molte cose sarebbero andate diversamente. Molte me le sarei perse, filtrate dalla mia percezione come acqua attraverso un setaccio. Grazie a Namiko so che, per me, il regalo più importante dell’amore sta nella vicinanza, e non negli spazi. Se non ci fosse stata Namiko, forse non avrei mai sentito bisbigliare i suoni soffusi della vita. Lungo il mio percorso, di colpo ero rimasto immobile, avevo trattenuto il fiato, sorpreso, e allora era arrivato, il respiro di un’intera città, la sua architettura, i suoi giardini sussurranti, i suoi enigmi e caratteri. E anche in mezzo alla natura ero stato d’un tratto pervaso da un piacevole mormorio, poiché il sussurro del mondo è onnipresente.
All’epoca avevo ventinove anni, lavoravo come redattore per una rivista tedesca ed ero arrivato a Kyoto per scrivere un articolo sui giardini giapponesi. Avevo in programma di visitare alcuni giardini, farmi un’idea del vecchio quartiere di geishe di Gion e, dopo una settimana, riprendere l’aereo per tornare a casa. Ma cosa sono mai i programmi? Solo chi è privo di fantasia ne fa e li rispetta. In realtà, i programmi hanno del grottesco: chi li concepisce sembra ingegnoso, quando in realtà la vera inventiva consiste nel non rispettarli. Perché danno un’illusione di sicurezza, ma diventano una scusa per non reagire alla spontaneità del momento.
Da una mezz’ora me ne andavo a zonzo per il giardino del Padiglione d’argento tentando di individuare quanto avevo letto nei libri sull’arte dei giardini in Giappone. Fu allora che, con lo sguardo perso, posai gli occhi su una donna.
Era appoggiata a un ciliegio con la camicia da uomo bianca raccolta davanti e le mani infilate nelle tasche dei pantaloni. I capelli lisci e neri erano legati in una coda di cavallo, rosicchiava la stanghetta degli occhiali da sole con gli occhi sprizzanti curiosità. Doveva avermi avvistato per prima. Quando mi accorsi di lei, il suo sguardo era già posato su di me.
La mia prima sensazione fu di sconcerto. Sembrava quasi che ci fossimo dati appuntamento lì e fossimo entrambi sollevati di vederci, finalmente. Nei suoi occhi c’era un desiderio un po’ sfrontato di scoprirmi, esaminava senza ritegno il mio aspetto esteriore e minacciava di spiare anche il mio mondo interiore. Le mie percezioni parvero confondersi. Distolsi lo sguardo e cercai di occupare i pensieri con un paio di cespugli ben potati e curati. Ma nel profondo di me, in quel breve istante era sbocciato qualcosa che sembrava provare ben poco interesse per le piante, così resistetti ancora brevemente alla tentazione prima di girarmi di nuovo verso il ciliegio.
La donna non c’era più, la vidi dirigersi verso un vicino boschetto di bambù senza voltarsi.
Poi sparì.
Quattro giorni dopo, il nostro incontro continuava a fremermi dentro dolcemente. Mi ero riproposto di staccarmi dai trattati teorici sui giardini giapponesi per immergermi in un’esperienza personale. Me ne stavo quindi seduto in un giardino zen avvolto nel silenzio. Il paesaggio si ergeva muto attorno a me, attendeva solo di essere apprezzato e, se non è chieder troppo a un europeo, compreso. I giardini zen di Kyoto, vecchia città imperiale nonché ex capitale del Giappone, non sono opere dispotiche: la ghiaia è stata rastrellata con sensibilità dai monaci, che l’hanno disposta ordinatamente, ma nessuno prescrive all’osservatore ammirato che lettura darne. Può ricordargli un campo di riso, o un deserto, oppure può percepirlo come un invito a perdersi in audaci metafore mentre una lucertola passa scivolando sulle sue sensazioni. Per quanto riguarda l’architettura del giardino, invece, qui nulla è lasciato al caso. Ogni albero, ogni cespuglio e ogni pietra sono pensati, posati e curati dalla mano umana. Eppure non ricordano in nessun modo la precisione minuziosa con cui sono organizzati, ad esempio, i giardini alla francese, dove si teme quasi di inciampare nei forellini lasciati sulla carta millimetrata dal compasso con cui i progettisti tracciarono un tempo i contorni.
I giardini giapponesi sono più vicini al cuore pulsante della natura. Con il loro senso per la filigrana e le sfumature, i giapponesi, così ho letto da qualche parte, hanno inventato innumerevoli parole per la pioggia e per i rumori che produce su superfici diverse; allo stesso modo, i loro giardini sembrano nascere dalla terra stessa.
Nel giardino zen, l’armonia mi avvolgeva. Cercai di afferrarla, andando un po’ in giro e attraversando un piccolo ponte arcuato di legno che resisteva pazientemente sopra un ruscello. Carpe decorative animavano il vicino laghetto, si lasciavano accarezzare, alcune erano care quanto un’automobile.
I quattro elementi del giardino zen sono la pietra, l’acqua, l’albero e il muschio, il mare verde della terraferma che si riversa sulle pietre e si arrampica sulle cortecce degli alberi. Mi sforzavo di non calpestare il muschio, poiché alla sua vista, in Giappone, non si arriccia il naso liquidandolo come erbaccia. Non solo il muschio trattiene l’umidità, ma rappresenta anche il tempo, e nei confronti del tempo e del passato molti giapponesi nutrono un sentimento davvero insolito: la venerazione. Anch’io avrei ben presto imparato ad apprezzare appieno il valore di ciò che è stato, ma in quel momento non lo potevo ancora sapere. E non solo nei confronti del muschio, ma anche della natura in generale molti giapponesi provano un profondo rispetto, il che non stupisce, considerati tutti i terremoti e i tifoni che devastano regolarmente il paese. Lo shintoismo, diffuso in Giappone, il kami no michi, la “via degli dèi”, offre una scelta sfarzosa di divinità naturali e spiriti, i kami. A volte il Giappone viene definito il “paese degli otto milioni di kami” proprio perché si trovano ovunque, in ogni pietra, albero, fiume, in tutte le cose, appunto.
È questo l’idillio che hanno in mente i giapponesi quando definiscono Kyoto nihon no furusato, la culla del Giappone, per così dire.
Il mio girovagare soprappensiero terminò davanti a un pino potato con cura. Sfogliai la mia guida e, in un capitolo dedicato all’arte dei giardini, scoprii che i pini simboleggiano la longevità.
All’improvviso sentii una voce alle mie spalle.
«Konnichiwa.»
Alzai sorpreso gli occhi dal libro e mi voltai. Davanti a me c’era la donna con la camicia da uomo. Questa volta ne indossava una a quadri rossi e bianchi. La teneva morbida sopra i jeans bianchi, i capelli sempre raccolti in una coda di cavallo legata con un semplice nastro bianco. Fortunatamente, in quei pochi giorni di permanenza avevo imparato che konnichiwa significava buongiorno.
«Konnichiwa» balbettai quindi a mia volta, accorgendomi di essere arrossito. E poi? Altro in giapponese non sapevo dire, stavo giusto cercando di riesumare il mio inglese scolastico dal profondo della mia memoria quando la donna mi venne in soccorso con un sorriso dolce. «Se non sa il giapponese, possiamo parlare nella sua lingua» mi propose.
«Parla tedesco!» esclamai, prendendomi mentalmente a schiaffi per quella constatazione banale.
«È il minimo che ci si possa aspettare da una studentessa di germanistica» rise di rimando. «Cosa dice il suo libro sull’amante in attesa?»
«Hmm?» chiesi, guardando sbigottito la mia guida di viaggio.
«L’amante in attesa. Il pino!»
Indicò l’albero davanti a noi e mi sorrise indulgente. «La parola giapponese per “pino” ha lo stesso suono di “attendere”. E se l’albero fosse una donna che si strugge nell’attesa del suo amato?»
«E se io fossi un uomo che si strugge nell’attesa del suo nome?» chiesi. A quanto pare mi ero ripreso almeno un po’.
«Namiko» rispose ridendo mentre mi tendeva la mano, disattendendo del tutto le usanze giapponesi. Le dissi a mia volta il mio nome.
«Sono stupita. È già la seconda volta che la incontro in un giardino e non ne comprende ancora la lingua?»
«Ecco...»
«Questo giardino le racconta delle storie. Quasi come se si trovasse in una fiaba tramutatasi in pianta. La parola per “pino” è matsu, e matsu significa anche “attendere”.»
«Purtroppo non parlo giapponese, so solo dire konnichiwa» mi giustificai sorridendo.
«Allora non resta che...»
«Chiedere a qualcuno come lei» proposi.
«Imparare il giapponese» ribatté divertita.
«Nel frattempo, perché non mi traduce lei cosa dice un giardino come questo?»
Non lo chiedevo per interesse professionale. In quel momento non ricordavo nemmeno di avere mai esercitato una professione. Vedevo solo Namiko, e con domande come quella cercavo di impedire che se ne andasse.
Ma c’era dell’altro. La sensazione che quella storia dell’amante in attesa e delle altre figure camuffate da piante tutt’attorno a me potesse rivelarsi in qualche modo importante.
Continuammo a bighellonare insieme e lasciammo il piccolo giardino alla ricerca di un caffè.
«Come faceva a sapere che sono tedesco?» le chiesi strada facendo.
«Ci eravamo già incontrati nel giardino del Padiglione d’argento, così oggi l’ho osservata meglio, e ho scoperto questa» disse indicando sorridente la guida tedesca che tenevo in mano. «Non potevo non rivolgerle la parola, incontrarsi due volte in un giardino non è così comune. Sebbene io vi trascorra parecchio tempo.»
«Come mai?»
«Per leggere.»
«Senza libro?» domandai abbassando lo sguardo per controllare.
«Non mi serve un libro per leggere» rispose.
Rimanemmo in silenzio per un po’.
Entrammo infine in un caffè. Namiko ordinò un cappuccino in cui versò cinque cucchiaini di zucchero. Io chiesi un caffè e lo bevvi nero, benché solitamente ci aggiunga del latte. In qualche modo, sembrava volessi dare a Namiko l’impressione di essere un duro. Gli uomini a volte sono così.
«Mi sembra bello che sotto la corteccia di un pino, oltre al legno, ci sia dell’altro» dissi mentre bevevo il caffè arrotolando la lingua per risparmiare alle papille gustative il peggio.
«A volte porto in giro i turisti europei e cerco di tradurre la lingua dei giardini.»
«Smascherando per esempio l’amante in attesa?»
«Non è un’immagine fortissima? Un pino se ne sta lì, anno dopo anno, imperturbabile. Mi pare sia un segno di grande fiducia nei confronti della persona che attende. Rimane. Getta radici. Aspe...