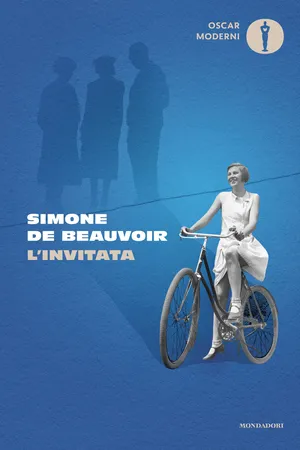Françoise alzò gli occhi. Le dita di Gerbert saltellavano sulla tastiera, mentre egli fissava il manoscritto con aria torva. Sembrava stanco e anche Françoise era assonnata, ma la stanchezza in lei aveva un che d’intimo e di avvolgente. Non le piacevano quelle occhiaie nere che sottolineavano gli occhi di Gerbert; aveva il volto sciupato, più duro, i suoi vent’anni si vedevano appena.
«Non vuoi che smettiamo?» chiese.
«No, andiamo avanti» rispose Gerbert.
«Del resto, mi rimane soltanto una scena da sistemare» disse Françoise voltando una pagina.
Le due erano già trascorse da un po’. Di solito a quell’ora non c’era più anima viva in teatro, ma quella notte esso viveva: la macchina da scrivere ticchettava, la lampada diffondeva sulle carte una luce rosata. Io sono qua, il mio cuore pulsa. Questa notte il teatro ha un cuore che pulsa.
«Mi piace lavorare di notte» disse Françoise.
«Già,» rispose Gerbert «c’è più pace.»
Sbadigliò. Il posacenere era zeppo di mozziconi di sigarette bionde e sul tavolino c’erano due bicchieri e una bottiglia vuota. Françoise guardò le pareti del suo studiolo: l’aria rosata era carica di calore e di luce umana. Fuori c’era il teatro inumano e nero, con i suoi corridoi deserti, attorno a un grande guscio vuoto. Françoise posò la penna.
«Ne vuoi ancora un goccio?» chiese.
«Perché no?» rispose Gerbert.
«Vado a prendere un’altra bottiglia nel camerino di Pierre.»
Uscì dallo studio. Non aveva molta voglia di whisky: erano più che altro quei corridoi neri che l’attiravano. Quando lei non c’era, quell’odore di polvere, quella penombra, quella solitudine desolata non esistevano per nessuno, non esistevano affatto. Adesso era lì, e il rosso del tappeto s’insinuava attraverso l’oscurità come la luce d’una timida fiammella. Aveva questo potere: la sua presenza strappava le cose dalla loro incoscienza, restituendole al loro colore, al loro odore. Scese al piano di sotto e spinse la porta della sala: era come se le fosse stata affidata una missione, bisognava che quella sala deserta, invasa dalla notte, esistesse. Avevano calato il sipario di ferro, le pareti odoravano d’intonaco fresco; le poltrone di velluto rosso erano allineate, inerti, nell’attesa. Un istante prima non aspettavano nulla. Ora era presente lei, e quelle tendevano le braccia. Guardavano il palcoscenico nascosto dal sipario abbassato, chiamavano Pierre, e le luci della ribalta e una folla raccolta. A perpetuare quella solitudine e quell’attesa avrebbe dovuto rimanere lì per sempre; ma avrebbe dovuto essere anche altrove, nel magazzino dell’attrezzeria, nei palchetti, nel ridotto: avrebbe dovuto essere dappertutto, contemporaneamente. Attraversò il proscenio e salì sul palcoscenico; aprì la porta del ridotto, scese nel cortile dove marcivano i vecchi scenari. Era la sola che sapesse far emergere il senso di quei luoghi abbandonati, di quegli oggetti immersi nel sonno; era presente e quelli le appartenevano. Il mondo le apparteneva.
Oltrepassò la porticina di ferro che chiudeva l’ingresso riservato agli artisti e si spinse fino al terrapieno. Tutto intorno alla piazza le case dormivano, il teatro dormiva: una sola finestra luceva di rosa. Sedette su una panchina, il cielo nero brillava al di sopra degli ippocastani. Si poteva credere d’essere in una tranquilla città di provincia. In quel momento non rimpiangeva di non avere accanto a sé Pierre; vi erano gioie che, lui presente, non poteva gustare: tutte le gioie della solitudine. Da otto anni ormai le aveva perdute e, a volte, ne provava come un rimorso. Si abbandonò sulla dura panchina di legno; un passo rapido risuonava sull’asfalto del marciapiede, sul viale passò un autocarro. C’era quel rumore di cose mosse, il cielo, le esitanti fronde degli alberi, un’unica finestra rosa nella facciata nera; non c’era più Françoise; non esisteva più nessuno, in nessun luogo.
Françoise balzò in piedi: era strano tornare a essere una persona, appena una donna, una donna che ha fretta perché c’è un lavoro urgente ad attenderla, e quell’attimo non era che un attimo come gli altri della sua vita. Appoggiò la mano sulla maniglia della porta, e si volse con una stretta al cuore. Era un abbandono, un tradimento. La notte stava per inghiottire di nuovo la piazzetta di provincia; il vetro rosa avrebbe riflesso la sua luce inutilmente, non l’avrebbe riflessa più, per nessuno. La dolcezza di quell’ora sarebbe andata perduta per sempre. Tanta dolcezza persa sull’intera faccia della terra. Attraversò la corte e salì per la scala di legno verde. Era una forma di rimpianto alla quale aveva rinunciato da un pezzo. Solo una cosa era reale: la propria vita. Entrò nel camerino di Pierre e prese una bottiglia di whisky dal vecchio armadio, poi risalì di corsa nello studio.
«Questo ci infonderà nuove energie» disse. «Come lo preferisci, liscio o con acqua?»
«Liscio» rispose Gerbert.
«Ce la farai poi a tornare a casa?»
«Certo! Comincio a reggerlo, il whisky» dichiarò Gerbert, dignitoso.
«Cominci…» ribatté Françoise.
«Quando sarò ricco e avrò una casa mia terrò sempre una bottiglia di Vat 69 nella dispensa» disse Gerbert.
«Sarà la fine della tua carriera» osservò Françoise. Lo guardò con un fondo di tenerezza. Egli aveva tratto di tasca la pipa e la stava caricando tutto assorto. Era la sua prima pipa. Ogni sera, vuotata la loro bottiglia di beaujolais, la posava sul tavolo e la contemplava con orgoglio infantile. Fumava mentre beveva un cognac o una grappa. Poi uscivano in strada con la testa appesantita dal lavoro, dal vino e dai liquori. Gerbert camminava a lunghi passi, col ciuffo nero calato sul volto e le mani affondate nelle tasche. Ora tutto era finito: lo avrebbe rivisto spesso, ma sempre con Pierre, con tutti gli altri; di nuovo due estranei.
«Anche tu, per essere una donna, reggi bene il whisky» disse Gerbert con tono equanime.
Squadrò Françoise:
«Però oggi hai lavorato troppo, hai bisogno di dormire un po’. Se vuoi ti sveglierò io.»
«No, preferisco finire il lavoro» disse Françoise.
«Non hai fame? Non vuoi che vada a comprarti un panino?»
«Grazie» rispose Françoise con un sorriso. Era stato così premuroso, così pieno di attenzioni; quando si sentiva scoraggiata, le bastava, per riacquistare fiducia, guardare quegli occhi ridenti. Avrebbe voluto trovare le parole adatte per ringraziarlo.
«È quasi un peccato che sia finito,» disse «mi ero abituata a lavorare con te.»
«Ma sarà ancora più divertente quando allestiremo lo spettacolo» ribatté Gerbert. I suoi occhi ebbero un lampo; l’alcool gli aveva infiammato le guance. «È così bello pensare che fra tre giorni si ricomincerà! Adoro l’inizio della stagione!»
«Certo, sarà divertente» disse Françoise.
Radunò le sue carte. Per Gerbert quei dieci giorni di lavoro in comune finivano senza rimpianti; era naturale, e neppure lei li rimpiangeva: non poteva pretendere che Gerbert fosse il solo a rammaricarsene.
«Questo teatro morto, tutte le volte che lo attraverso mi dà un brivido» disse Gerbert. «È lugubre. Questa volta avevo creduto davvero che sarebbe rimasto chiuso tutto l’anno.»
«L’abbiamo scampata bella» disse Françoise.
«Purché duri» replicò Gerbert.
«Durerà» ribatté Françoise.
Non aveva mai creduto che sarebbe scoppiata la guerra; la guerra era come la tubercolosi o come i disastri ferroviari: a me non capitano. Sono cose che succedono solo agli altri.
«Tu riesci veramente a immaginare che una disgrazia di quelle coi fiocchi possa piombarti sul capo?»
Gerbert fece una smorfia:
«Oh! molto facilmente» rispose.
«Io no» ribatté Françoise. Non era nemmeno il caso di pensarci. I pericoli dai quali ci si poteva difendere valeva la pena di esaminarli, ma la guerra non ha proporzioni umane. Se un giorno fosse dovuta scoppiare, nulla più avrebbe avuto importanza, neppure vivere o morire.
“Ma non succederà” ripeté Françoise fra sé. Si curvò sul manoscritto. La macchina da scrivere ticchettava. Nella stanza c’era odore di tabacco biondo, d’inchiostro, di notte. Dietro al vetro della finestra, la piazzetta raccolta dormiva sotto il cielo nero; nella campagna deserta un treno correva. Io sono qui. Ma per me che sono qui esistono la piazza, e il treno che corre: e Parigi tutta quanta, e tutta la terra nella penombra rosa di questo piccolo studio. E in questo minuto tutti i lunghi anni di felicità. Io sono qui nel cuore della mia vita.
«Peccato non si possa fare a meno di dormire» disse Françoise.
«E soprattutto peccato non riuscire a rendersi conto di dormire» ribatté Gerbert. «Nell’attimo in cui ce ne si accorge, ci si sveglia. Non c’è vantaggio.»
«Ma non ti pare meraviglioso vegliare mentre gli altri dormono?» Françoise posò la penna e tese l’orecchio. Non si sentiva alcun rumore, la piazza era nera, il teatro nero.
«Mi piacerebbe immaginare che tutti siano addormentati, che in questo momento i soli vivi sulla terra siamo tu e io.»
«Un’idea che farebbe piuttosto accapponare la pelle» rispose Gerbert, respingendo all’indietro con un gesto il lungo ciuffo che gli ricadeva sugli occhi. «È come quando penso alla luna: quelle montagne di ghiaccio, e quei crepacci e nessun abitante. Il primo che si arrampicherà lassù dovrà avere un bel fegato.»
«Se me lo proponessero, non direi di no» disse Françoise. Guardò Gerbert. Di solito erano l’uno accanto all’altra; Françoise era contenta di sentirselo vicino, ma non parlavano. Quella sera invece aveva voglia di chiacchierare. «È buffo pensare a come sono le cose quando noi non ci siamo» disse.
«Sì, è buffo» rispose Gerbert.
«È come provare a immaginare di essere morti; non ci si riesce, in fondo è sempre come se si stesse in un angolo a guardare.»
«È strano pe...