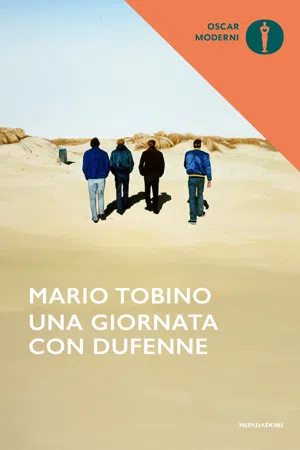![]()
Una giornata piuttosto interessante con Gastone Dufenne.
Circa un venticinque giorni or sono venne il portiere del manicomio a dirmi che mi voleva al telefono il “signor questore”.
Mi ingrugnii, sempre avendo avuto nausea e paura per quelli della polizia. Se non che, considerando rapidamente che avevo da poco pubblicato un libro e per la mia sincerità potevano essere sorte delle quistioni, mi dissi che era prudente di ascoltare all’altro capo del filo quel “signor questore”.
«Sono il dottor Giustiniani» pronunciai al telefono con un’ombra di cupezza.
«Sono Berlinga!» si esclamò festosamente dall’altra parte. «Siamo stati in collegio insieme. Non ti ricordi? Eravamo nello stesso banco.»
Mi sciolsi come una manciata di neve lanciata su una lastra di ferro bollente.
«Mi ricordo benissimo. Caro Berlinga, che bontà hai avuto a telefonarmi.»
In verità non mi ricordavo affatto di Berlinga, ma all’improvviso era risorto tutto l’anno del collegio a Collevinci, dai lasseriani, la mia prigionia, con quei sacerdoti di Don Lasser che mi salvarono, furono essi a fare il primo salvamento della mia gioventù un poco irrequieta, sull’orlo della casa di correzione, sulla lama del Tribunale per i minorenni. Non ero cattivo, soltanto bisognevole di una comprensione che però non trovavo da nessuna parte, e caparbiamente cercavo.
Tutto un anno di collegio mi si risollevò, e, per gratitudine a quei sacerdoti lasseriani, attraverso il filo del telefono:
«Ma sì, vediamoci.»
«Posso prendere la macchina e venire.»
«Ti aspetto.»
Il signor questore arrivò qui al manicomio. L’aveva accompagnato con l’automobile un suo dipendente, che ora se ne stava al suo fianco, riguardoso, ricco e dolce di premure. Tutti e due erano stati fatti passare in un salottino, vicino alla portineria, usato in questi casi.
Al momento opportuno entrai e vidi che il mio antico compagno di collegio era di media statura, il volto solcato dagli anni e dagli interni ripensamenti del suo mestiere. Mi sembrò di capire che in quel momento aveva un profondo desiderio: essere simile a tutti gli altri italiani, anche lui con un mestiere su per giù simile agli altri.
Prendemmo a rimbalzarci i ricordi del collegio. Il dipendente che l’accompagnava ogni tanto si immetteva nella conversazione, esclamando rapidamente, con garbatezza e riguardo verso di me e il suo superiore; aveva un accento toscano piuttosto largo, non si capiva bene, forse derivava dal centro della Maremma o forse da una regione appena più bassa.
«E come ti trovi nella questura?» domandai al mio compagno di collegio interrompendo la sequela delle rimembranze collegiali.
«Bene. Fu mio padre che mi iscrisse. Mentre ero ancora sotto le armi, in guerra; fece per me la domanda. Al ritorno mi trovai avviato alla carriera.»
«No, volevo dire, come ti trovi fra tutti i meridionali che affogano ogni questura, come fai a galleggiare?»
L’altro, il dipendente che l’aveva accompagnato, fece così col dito, alzandolo un poco per chiedere la parola, un gesto umile, di una strana consapevole grazia; vi unì anche una certa segreta energia come volesse avvertire che era bene parlasse lui, prima che si aggiungesse altro.
«Sono anch’io meridionale, sono di Lecce» sorrise con innocenza e perdono.
Per alcuni tempuscoli non seppi che dire, ma i due “agenti dell’ordine” furono buoni – il toscano e il meridionale, uniti ormai dalla stessa famiglia – e tirarono via, svoltarono, si dimenticarono, subito si parlò d’altro, immediatamente. Tutti e tre insieme ci si dimenticò dello sbaglio che avevo fatto.
Furono loro di scatto a iniziare il commento su i miei libri, che per la verità – fu facile scoprirlo – non avevano per nulla letto, ne avevano soltanto sentito parlare, in specie di quello sul manicomio, su i matti: Le libere donne di Magliano.
Mi accorsi che era per questo libro che mi perdonavano tutto. La vita è intricata, sovrapposta, intersecata di innumerevoli strati. Solo a lampi la si illumina.
Il mio ex-compagno di collegio aggiunse anche, come volesse tacitare una parte di se stesso, rimasta poco convinta:
«La critica ha detto la bellezza di quel libro. C’è stata la critica che l’ha detto, no?» E con quel «no?» smarrito di diverse interrogazioni, mi chiese aiuto ai suoi dubbi.
Sorrisi come tutto fosse pacifico, accettato da ognuno, e cambiai discorso riportandolo sul tema generale del tempo che fugge, che noi ci si conobbe quaranta anni fa ed ora loro due avevano certamente dei figli, che di sicuro davano molti pensieri ma anche tante tenere speranze.
Il dipendente meridionale non smentì la sua origine. Al motto dei figli prese l’aire, superò ogni ostacolo, descrisse suo figlio maggiore dichiaratamente un genio, un prossimo fisico nucleare di fronte al quale nessuna fama di attuale professore avrebbe resistito.
Non ne potevo più:
«Vi posso regalare il mio libro?»
«Saremmo contentissimi. Non ti nascondiamo che siamo venuti anche per quello» confessò Berlinga, il questore, il mio ex-compagno di collegio.
Corsi su, al piano di sopra, in camera mia, a prendere due copie delle Libere donne. Ormai ho l’abitudine. Mi libero e pago una modesta notorietà regalando libri.
Tornato giù, con loro soddisfazione vergai le dediche. Il meridionale mi invitò, invece che a lui, a dedicare la copia al futuro fisico nucleare, a suo figlio.
Infine, mentre erano già iniziati i saluti, il vecchio compagno di collegio venne al perché della visita, svelò l’innocenza che gli premeva il cuore, l’innocenza d’amore.
«Voglio ritornare laggiù insieme con te, dopo quarant’anni. Già da tanti mesi ti volevo telefonare. Poi ho sempre rimandato.»
Rimanemmo d’accordo che dopo venti giorni, alla prima domenica di giugno, il 5, il 5 giugno, insieme saremmo ritornati, dopo quaranta anni, al collegio di Collevinci, alla festa degli ex-allievi, e lì ne avremmo incontrati di quelli che insieme con noi avevano diviso il respiro caldo su quei banchi, nella chiesa, nel refettorio e nella lunga sala dello Studio.
«Allora, senz’altro, il 5 giugno» e intanto la mia mente risuscitava, come fosse stato appena ieri, tutto il passato.
Il Berlinga, il questore di S., era stato l’accendino, la scintilla, la pirite che dà fuoco alle secche fascine affastellate.
![]()
Come fino a oggi è accaduto, passarono i giorni, ognuno col suo avvenimento che fino a un certo punto distrae, ma all’àncora del cuore era rimasta quella data che si approssimava: la riunione degli ex-allievi lasseriani, di quei preti che mi avevano accolto, mi avevano salvato, laggiù, nella mia appena superata adolescenza, dopo i quindici anni, appena sedici, e mio padre non sapeva più da che parte avviare quel suo maledetto figlio, che alle scuole di Medusa ogni pochi giorni sospendevano dalle lezioni per vasti periodi, e lo bocciavano, era insomma ai professori ripugnante, e, come poteva, a lui padre, essere lo stesso? come non poteva tentare ancora perché mi salvassi?
E passano e passano le ore e arriva il cinque giugno. Dell’appuntamento che ho preso col questore qui al manicomio lo sanno tutti, medici e portieri. «Domenica 5 vado agli ex-allievi a Collevinci. Il questore mi verrà a prendere qui all’ospedale!» L’ho detto anche al capo amministrativo del nostro nosocomio, il professor Micheletti, che è proprio di Collevinci, nato e vissuto in quel paese dove c’è il collegio, in quel soffuso degradare di colline della ignota campagna pisana-livornese, in quello sfumare di piani e di accennati volumi.
Il sabato sono solito essere dalla mia cara Giovanna, la mia compagna, l’amante, insomma la moglie che da tanti anni mi aspetta; sono solito essere nella sua villa di San Miniato, e il giorno faccio il signore, libero, strafottente, dimentico, allegro. Arrivo da lei il venerdì dopopranzo, la sera mi imbriaco, parlo, mi effondo, rovescio come un borsellino il mio cuore, lei affettuosamente mi ascolta e attende; e il giorno dopo sono austero, smaltisco, a volte insieme si controllano i fatti degli altri, a volte si fa il punto sulla nostra reciproca storia, sulla nostra realtà, che è anche fatta di sogni e pazze aspirazioni, le quali purtuttavia accade che a strappi si attuino.
Invece questo sabato, alla sera, invece di addormentarmi tra le sue lenzuola, nel protetto silenzio, all’inizio della notte mi incamminai con le ruote dell’automobile verso il rifugio del mio manicomio perché la mattina dopo doveva venirmi a prendere – come da appuntamento – il questore di S., il dottor Berlinga, per andare alla cerimonia degli ex-allievi del collegio lasseriano di Collevinci.
E alle prime luci del mattino ero già sveglio; mi piaceva, dopo quaranta anni, ritrovarmi là, dove per sette mesi ero stato imprigionato; e in più qualcosa mi batteva nel petto come un dovere.
C’erano grosse quistioni: la Chiesa, i preti, l’onestà dei lasseriani, il loro essere piemontesi e contadini, l’avermi accettato, e, sentimentalmente, rivedere quelli che insieme con me erano stati ragazzi. Che ne era divenuto di loro in questi quaranta anni? E mi nascevano diverse domande:
Quelli che erano stati in collegio con me, in quegli anni, erano per caso «strani» come me? anche loro erano stati aiutati dai lasseriani? Forse che eravamo, non tutti, ma alcuni di noi, dei fuori legge?
Era questa la segreta funzione di questi lasseriani che salvavano dalle case di correzione chi ne era sull’orlo, soccorrevano coloro che erano per cascarvi dentro? Era questa la loro grande cristiana funzione?
In questo momento che è notte e scrivo – il cinque giugno da poche ore è passato – la mia mente serenamente pensa che sia giusto rispondere di sì. Quel Don Lasser fu un contadino santo che sa la vigoria della vita, note a lui le forze della natura; da lui stesso disprezzate o in non cale le insulse ipocrisie degli esseri senza personalità. Don Lasser attento, per lui importante chi ha dramma, chi ha forte contrasto dentro di sé. Questo il perché della sua santità, cioè aver risolto, aver dato aiuto attraverso i suoi uomini, i suoi preti, essere andato incontro ai virili drammi che a ogni generazione si presentano, a chi ama spontaneamente e con violenza le leggi della vita.
Insomma la mattina della domenica, la mattina del cinque giugno, nel fresco mattino ero già alzato. Dovevo fare il mio dovere prima di partire, sono pur primario, visitare gli ammalati, firmare qualche carta, domandare a Panelli in segreteria. E così essere pronto per le nove quando – come da appuntamento – mi sarebbe venuto a prendere con la sua automobile il caro Berlinga che, col passare dei giorni, sempre più amavo e rivedevo come un semplice ed umile compagno di scuola.
E infatti alle nove precise ero pronto, lì, presso il telefono, nella portineria superiore del manicomio, in attesa che dal telefono interno della portineria di fondo mi avvertissero che stava arrivando su il signor questore Berlinga, il mio vecchio compagno di collegio.
E invece trillò acuto il telefono centrale, l’esterno.
«Pronto» dissi.
«C’è il dottor Giustiniani?»
«È Berlinga? Sono io. Ti aspetto. Di dove telefoni?»
«Non posso venire.»
«Ma, come?»
«Sono malato. Ho la febbre, più di 38. Sono a letto. Mi dispiace; come mi dispiace! Tu non lo sai, ma erano cinque mesi che ci pensavo.»
«Che hai? che malattia?»
«Te l’avevo detto l’altro giorno, non ti ricordi?»
«Sì, che non stavi bene, una certa mastoidite. Mi telefonasti di striscio, non me ne rammentavo più.»
«Ho avuto una complicazione.» E mi dispiegò un ventaglio di sintomi che è inutile ripetere, una sintomatologia umana e triste.
«Ma, allora? Non si può partire?»
«Ho provveduto. Aspetta, ho provveduto. Ho telefonato a Dufenne, ieri, a Gastone Dufenne. Lo conosci, no?»
«Perbacco! È un mio caro amico, nostro compagno di collegio.»
«Gli ho detto di venirti a prendere al mio posto.»
«Sono contento di Dufenne, ma è un peccato che tu non venga.»
«Tu sapessi come mi dispiace! Erano dei mesi che sognavo quella festa degli ex-allievi. Allora, addio. Fra pochi minuti, alle nove precise, verrà lì al manicomio Dufenne.»
«Bene, grazie. Ma tu curati. Anzi, anch’io sono medico, che medicine prendi?»
Berlinga, di là dal filo, elencò le medicine, e poi ci furono i saluti, gli auguri. «Addio, Berlinga» e calai il ricevitore.
Ora aspettavo il Dufenne che conoscevo tanto più del questore, lui davvero un mio ex-compagno di collegio, sempre io stato a lui, e lui a me fedele, anche se lunghe erano state tra noi le fratture degli anni.
Suo padre aveva una cereria, un antico negozio di S., che è zeppa di chiese; faceva e vendeva ogni sorta di candele. Dopo la fine del collegio, ottenuta la licenza ginnasiale, ero stato a S. e a...