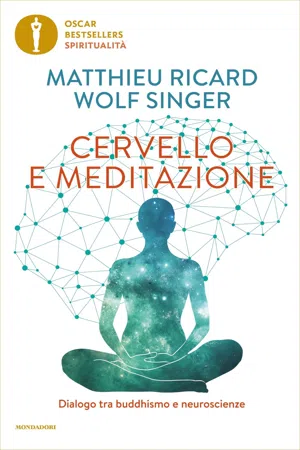Disponiamo di capacità di apprendimento di gran lunga superiori a quelle delle altre specie animali. Possiamo, grazie all’allenamento, sviluppare le nostre capacità mentali proprio come facciamo con le capacità fisiche? L’addestramento mentale può renderci più attenti, più altruisti e più sereni? Tali interrogativi vengono esplorati da una ventina d’anni da neuroscienziati e psicologi che collaborano con meditanti esperti. Possiamo imparare a gestire le emozioni perturbatrici in modo ottimale? Quali sono le trasformazioni funzionali e strutturali generate nel cervello dai diversi tipi di meditazione? Quanto tempo ci vuole per poter osservare tali trasformazioni nei meditanti principianti?
Una scienza della mente
MATTHIEUCredo che, tanto per cominciare, sia necessaria una constatazione: a differenza delle civiltà occidentali, il buddhismo non si è concentrato sulla conoscenza del mondo fisico e delle scienze naturali, benché esistano trattati di medicina tradizionale e di cosmologia. Per contro, ha dedicato oltre venticinque secoli a una profonda investigazione della mente; ha così accumulato, in modo empirico, una somma considerevole di risultati esperienziali. Innumerevoli persone hanno consacrato la loro intera vita alla scienza contemplativa, mentre la psicologia occidentale ha avuto inizio poco più di un secolo fa, con William James. Non posso fare a meno di citare l’osservazione fatta da Stephen Kosslyn, allora direttore della facoltà di Psicologia dell’Università di Harvard, in occasione dell’incontro organizzato dall’istituto Mind and Life presso il MIT, nel 2003, sul tema dell’“Investigazione della mente”: «Vorrei cominciare con una dichiarazione d’umiltà di fronte al quantitativo considerevole di dati che i contemplativi apportano alla psicologia moderna».
In realtà, non è sufficiente riflettere sul funzionamento della psiche umana e dedurne teorie complesse, come per esempio ha fatto Freud. Tali elaborazioni intellettuali non possono sostituire due millenni e mezzo di investigazione diretta del funzionamento della mente condotta attraverso una profonda introspezione da menti perfettamente allenate e capaci di raggiungere nello stesso tempo una grande stabilità mentale e una chiarezza incisiva. Le sofisticate elaborazioni di menti brillanti non possono confrontarsi con l’esperienza accumulata da milioni di persone che hanno dedicato l’intera esistenza ad approfondire gli aspetti più sottili della mente attraverso l’esperienza diretta. Fondandosi su un approccio empirico, e avendo una mente ben allenata, questi contemplativi hanno trovato metodi efficaci per giungere a una trasformazione graduale delle emozioni, degli stati d’animo e dei tratti caratteriali, così da erodere le tendenze ataviche più radicate, e che rappresentano un ostacolo a un modo di essere ottimale. Realizzare un tale obiettivo trasforma la qualità di ogni istante della nostra vita, rinforzando caratteristiche umane fondamentali, come la bontà, la libertà, la pace e la forza interiore.
WOLFPuoi essere un po’ più preciso rispetto a questa affermazione perlomeno audace? Perché ciò che la natura ci ha messo a disposizione sarebbe fondamentalmente negativo, tanto da esigere pratiche mentali particolari volte a eliminare questo nostro retaggio? E perché mai tale approccio contemplativo dovrebbe essere superiore all’istruzione convenzionale, alle diverse forme di psicoterapia, ivi compresa la psicanalisi?
MATTHIEUCiò che la natura ci ha dato non è affatto negativo, è soltanto un punto di partenza. La maggior parte delle nostre capacità innate sono latenti, a meno che non facciamo qualcosa per portarle al loro livello di funzionamento ottimale, ricorrendo, in particolare, all’addestramento della mente. Come ben sappiamo, la nostra mente può essere il nostro migliore amico come il nostro peggior nemico. La mente che ci è stata messa a disposizione dalla natura ha davvero il potenziale di sviluppare una bontà immensa, ma può anche essere all’origine di sofferenze inutili e considerevoli, sia per noi sia per gli altri. Se abbiamo il coraggio di guardarci allo specchio in tutta onestà, non possiamo che constatare di essere una miscela di qualità e di difetti. Davvero non possiamo fare di meglio? È questo il nostro modo di essere ottimale? Chiederselo è importante.
Sono davvero poche le persone che potrebbero affermare in tutta sincerità che nel loro stile di vita e nel loro modo di relazionarsi con il mondo non c’è nulla che meriti di essere migliorato. Alcune persone considerano le loro debolezze e le loro emozioni afflittive come una parte distinta e preziosa della loro “personalità”, tutti fattori che contribuirebbero alla pienezza della loro esistenza. Ma non si tratta forse di un modo fin troppo semplice per rinunciare a qualsiasi miglioramento della loro qualità della vita?
La nostra mente è assillata da vari problemi. Trascorriamo una notevole quantità di tempo lasciandoci sopraffare dai nostri pensieri dolorosi, dalla rabbia e dalla collera. Spesso vorremmo essere capaci di gestire meglio le nostre emozioni, così da liberarci da quegli stati mentali che perturbano e oscurano la mente. Ma in sostanza, immersi come siamo in una confusione che non sappiamo padroneggiare, ci risulta molto più semplice concludere che tale caos sia “normale”, e che sia proprio questa la “natura umana”. Certo, tutto ciò che è relativo alla natura è “naturale”, ivi compresa la malattia, ma non per questo è necessariamente auspicabile.
Nessuno si sveglia al mattino pensando: “Possa io soffrire tutta la giornata, persino tutta la vita”. Speriamo sempre di poter trarre un qualche beneficio o soddisfazione dalle attività a cui ci dedichiamo, o almeno una riduzione della sofferenza. Se dovessimo constatare che le nostre attività non sfociano in null’altro che nella disperazione, non faremmo più niente e ci lasceremmo andare allo scoramento.
Non ci pare per nulla strano consacrare anni e anni all’apprendimento della lettura e della scrittura, e più tardi di un mestiere. Passiamo intere ore a fare ginnastica, al fine di mantenere il nostro corpo in buona forma fisica. Per dedicarsi a tali attività è indispensabile provare un minimo di interesse o di entusiasmo. Tale interesse scaturisce dall’essere convinti che quegli sforzi comporteranno dei benefici nel lungo termine. Il lavoro sulla mente procede secondo la stessa logica. Come possiamo pensare che la nostra mente cambi senza che facciamo il benché minimo sforzo, limitandoci cioè ad auspicare un tale cambiamento?
Dedichiamo un considerevole quantitativo di tempo a migliorare le condizioni esteriori della nostra vita, ma in fine dei conti è sempre la mente che crea la nostra esperienza del mondo e la traduce in benessere o in sofferenza. Se trasformiamo la nostra modalità di percezione delle cose, modifichiamo anche la qualità della nostra vita. Possiamo giungere a una tale trasformazione attraverso l’addestramento mentale, ciò che chiamiamo “meditazione”.
Sottovalutiamo ampiamente la nostra capacità di cambiamento. I nostri tratti caratteriali sono gli stessi da così tanto tempo che non facciamo più nulla per cambiarli. A ben guardare, la condizione che noi definiamo come “normale” è solo un punto di partenza, e non l’obiettivo su cui dovremmo concentrarci. In realtà giungere gradualmente a un modo di essere ottimale è possibile.
Comprendere il nostro potenziale di cambiamento è una fonte d’ispirazione molto potente, qualcosa che ci spinge a impegnarci in un processo di trasformazione interiore. Dedicare la nostra energia all’obiettivo di raggiungere tale cambiamento interiore rappresenta di per sé un processo di guarigione.
L’istruzione convenzionale moderna non si concentra sulla trasformazione della mente, né sull’acquisizione di qualità umane fondamentali come la bontà e l’attenzione. Come vedremo più avanti, la scienza contemplativa buddhista ha numerosi punti in comune con le terapie cognitive e, più in particolare, con quelle che fanno ricorso all’attenzione per rimediare allo squilibrio mentale. Per quanto concerne la psicanalisi, mi sembra incoraggi la “ruminazione”, inducendoci a esplorare senza posa e nei minimi dettagli gli arcani delle nubi di confusione mentale e di egocentrismo che oscurano l’aspetto più fondamentale della mente: la luminosità della coscienza risvegliata.
WOLFQuindi una tale ruminazione sarebbe il contrario di ciò che accade durante la meditazione?
MATTHIEUAssolutamente. Peraltro è risaputo che rimuginare continuamente è uno dei principali sintomi della depressione.
WOLFTrovo che per il nostro dialogo sia incoraggiante il fatto che abbiamo punti di vista divergenti relativamente alle strategie che permettono di guarire la mente! Ho l’impressione che la pratica della meditazione sia spesso fraintesa. Ne ho fatto io stesso una piccola esperienza, che mi ha permesso di comprendere perlomeno ciò che non è: non consiste nel confrontarsi con i problemi irrisolti, nel ricercare le loro cause così da eliminarli. È l’esatto opposto.
MATTHIEUQuando si osservano i processi della ruminazione mentale, è facile constatare fino a che punto possa costituire un fattore di perturbazione. Liberarsi dalle catene di reazioni mentali perpetuate proprio da un tale rimuginare è assolutamente fondamentale. Bisognerebbe imparare a lasciare che i pensieri emergano e poi si dissolvano appena comparsi, anziché permettere loro di invadere la nostra mente. Nella freschezza del momento presente il passato non c’è più, e il futuro non c’è ancora; quando si dimora nella pura coscienza risvegliata – l’autentica libertà -, i pensieri che avrebbero potuto perturbarci sorgono e si dissolvono senza lasciare nessuna traccia.
WOLFIn uno dei tuoi libri hai scritto che ogni essere umano possiede nella sua mente una “pepita d’oro”, un nocciolo di purezza e di qualità positive, che sono peraltro nascoste ed eclissate dalle molteplici emozioni e dai tratti caratteriali negativi che deformano le nostre percezioni e rappresentano la principale causa delle nostre sofferenze. Tale ipotesi mi sembra un po’ troppo ottimista, e non verificata. Si avvicina un po’ alle fantasticherie di Rousseau, e sembra essere in contraddizione con alcuni casi, come per esempio quello di Kaspar Hauser, “il ragazzo selvaggio”. Siamo ciò che l’evoluzione ha scritto in noi attraverso i nostri geni, e ciò che la cultura ci ha inculcato attraverso l’istruzione, le norme morali e le convenzioni sociali. Che cosa sarebbe allora questa “pepita d’oro”?
MATTHIEUUn frammento d’oro che è rimasto profondamente sepolto nella sua ganga, nella roccia o nel fango. L’oro di per sé non perde la sua purezza intrinseca, ma il suo valore non viene concretizzato. Analogamente, se vogliamo che il nostro potenziale umano si esprima appieno, deve trovare le condizioni appropriate al suo sviluppo. È lo stesso discorso che si fa per i semi: devono essere piantati in un terreno fertile e sufficientemente umido.
La coscienza risvegliata e le costruzioni mentali
MATTHIEUL’idea di una coscienza la cui natura fondamentale sarebbe perfettamente pura non è una semplice concezione ingenua della natura umana. Si fonda sul ragionamento e sull’esperienza introspettiva. Se consideriamo i pensieri, le emozioni, le sensazioni nonché tutti gli altri eventi mentali, possiamo constatare che hanno tutti quanti un denominatore comune: la facoltà di conoscere. Secondo il buddhismo, tale facoltà fondamentale della coscienza è la natura fondamentale della mente. Questa natura è “luminosa”, nel senso che ci permette di conoscere il mondo esterno attraverso le nostre percezioni e che rischiara il nostro mondo interiore attraverso le sensazioni, i pensieri, i ricordi, le anticipazioni e la coscienza del momento presente. Viene definita “luminosa” in contrasto con un oggetto inanimato che è opaco, vale a dire privo di qualsiasi capacità cognitiva.
Proviamo a servirci dell’esempio della luce. Se, con l’aiuto di una lampada, rischiariamo in successione un bel viso sorridente, un viso preda della collera, una montagna di gioielli e un mucchio di spazzatura, la luce non diventa per questo altrettanto bella, collerica, preziosa o sporca. Oppure consideriamo l’esempio dello specchio, la cui specificità è quella di riflettere ogni genere di immagine. Tuttavia, nessuna di queste immagini appartiene allo specchio, non lo penetra né dimora in lui. Analogamente, la caratteristica fondamentale della mente è di permettere a tutte le costruzioni mentali (l’amore, la collera, la gioia e la gelosia, il piacere e il dolore) di manifestarsi senza subire alterazioni. Gli eventi mentali non fanno intrinsecamente parte dell’aspetto più fondamentale della coscienza. Si dispiegano semplicemente nello spazio della coscienza risvegliata, nei diversi momenti di coscienza; è proprio tale coscienza risvegliata fondamentale a permettere la loro manifestazione. Si può quindi definire questa coscienza come pura coscienza, o componente fondamentale della mente.
WOLFCiò che hai appena detto ha due implicazioni. La prima è che sembri attribuire un valore alla stabilità, o all’obiettività, che funzionerebbe come criterio di convalida. La seconda è che dissoci la coscienza fondamentale dai suoi contenuti. Lasci supporre che esisterebbe nel cervello un’entità di base che funzionerebbe alla stessa stregua di uno specchio ideale, un’entità che, di per sé, non introdurrebbe nessuna distorsione e non sarebbe influenzata dal contenuto che riflette. Non è che forse stai difendendo una posizione dualista, una dicotomia tra, da un lato, una mente immacolata che sarebbe l’osservatore e, dall’altro, i contenuti che comparirebbero di fronte a tale mente e rappresenterebbero molteplici interferenze e distorsioni? Le concezioni contemporanee dell’organizzazione del cervello negano categoricamente qualsiasi distinzione tra le funzioni sensoriali ed esecutive, e comprendono la coscienza come proprietà emergente delle fu...