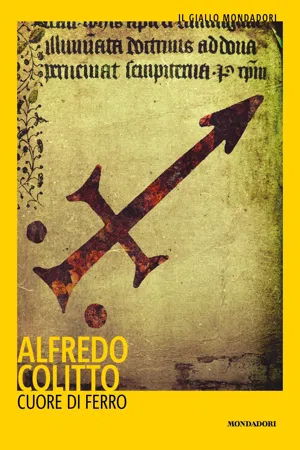Uberto da Rimini lavorava a cuor leggero. L’arcivescovo si era intestardito a rileggere ogni singolo foglio relativo al processo. Era un segno palese di sfiducia nei suoi confronti, eppure la cosa non lo toccava più di tanto. Un’ora prima Guido Arlotti era venuto di persona a dirgli che il piano era riuscito. La folla riunita in piazza difficilmente si sarebbe dispersa prima di aver visto il cadavere del finto studente, e il capitano del popolo aveva inviato un manipolo di birri ad arrestare Mondino de’ Liuzzi.
Il frate che Uberto aveva mandato ad avvisare il podestà del loro arrivo era tornato con la notizia allarmante che la piazza era piena di gente inferocita e che non era riuscito ad arrivare al palazzo. L’arcivescovo aveva detto che non si sarebbe lasciato intimorire, ma secondo Uberto si trattava solo di una posa. Era sicuro che al momento buono avrebbe rinunciato all’interrogatorio, restandosene al sicuro entro le mura del convento. E il giorno dopo sarebbe stato troppo tardi.
Tutto era sistemato. Bastava solo aspettare.
«Qui dice che, all’accusa di aver praticato il rito dell’osculum sub cauda, l’interrogato ha mentito protestando la sua innocenza» disse Rinaldo da Concorezzo, sollevando la testa dai verbali degli interrogatori.
«Infatti» confermò Uberto, soprappensiero. «Non fanno altro che dichiararsi innocenti di tutto.»
«Non era quello che intendevo» ribatté l’arcivescovo, secco. «Volevo attirare la vostra attenzione sulle parole che avete usato. Non avete detto: “Si è dichiarato innocente”, ma: “Ha mentito protestando la sua innocenza”. Come fate a essere certo che mentisse?»
«Perdonatemi, monsignore» rispose Uberto, ormai al limite della sopportazione. «È stata una mia leggerezza. Ho solo immaginato che l’ufficio del Santo Padre non avrebbe incluso nella lista una colpa così oscena come quella di chiedere ai novizi di baciare l’ano dei confratelli anziani, se prima non fosse stato certo che si trattava di un’accusa fondata. Perciò ne ho inferito che la dichiarazione di innocenza dell’accusato fosse mendace. Si trattava di dubitare di lui o dell’ufficio del Santo Padre.»
L’arcivescovo annuì tra sé. «Vedo che parliamo due lingue diverse, padre Uberto» disse. «Per voi si tratta sempre di credere o non credere a qualcuno in base alla presunta affidabilità della persona. La questione delle prove è del tutto aliena al vostro modo di pensare.»
«È un mio limite, lo riconosco.» Ormai, dopo tutto il tempo trascorso a sopportare i rimproveri di Rinaldo, la rabbia traspariva dalle parole di Uberto senza che potesse fare nulla per evitarlo. «Il fatto è che sono un monaco, e fin da piccolo mi è stato insegnato che la fede non ha bisogno di prove.»
«Quindi vi sembra logico applicare lo stesso sistema di giudizio ai peccati umani e all’insegnamento di Cristo, come se fossero uguali.»
«Non ho detto questo, monsignore.»
«Non lo avete detto, ma le vostre azioni parlano per voi. Sarò sincero, padre Uberto. Comincio a nutrire forti dubbi che siate la persona adatta a svolgere questo incarico.»
Quello era un colpo basso al quale Uberto non era preparato. Aprì e chiuse la bocca due volte senza emettere suono, poi finalmente riuscì a dire: «Volete destituirmi? Ma non è possibile. Mancano solo poche settimane alla chiusura del processo. Siamo già in ritardo sui tempi previsti dal pontefice, e…».
«Calmatevi, lo so anch’io che è tardi per pensare a una sostituzione. Intendo solo affiancarvi due padri francescani di mia fiducia, in modo che, attraverso un confronto costruttivo, possiate prendere insieme le decisioni più giuste.»
Stavolta Uberto rimase davvero senza parole. Essere sottoposto al giudizio dei francescani in ogni sua decisione era una umiliazione peggiore della rimozione dall’incarico. Ormai era chiaro: l’arcivescovo gli aveva dichiarato guerra.
«Se questa è la vostra decisione, la rispetto e la accetto senza discutere» disse, con uno sforzo visibile per conservare la calma. «Se tuttavia c’è qualcosa che posso fare per riconquistare la vostra fiducia, vi prego di dirmelo.»
L’arcivescovo sospirò. «Vedremo. Molto dipende da cosa ci dirà il prigioniero, quando andremo a interrogarlo. Se risulterà chiaramente colpevole degli omicidi che gli vengono imputati, e se si vedrà in tale colpa una responsabilità non solo sua, ma anche di altri membri del suo ordine, come voi sembrate pensare, il processo arriverà a una rapida conclusione senza bisogno di cambiare incarico a nessuno.»
«Vi ringrazio, monsignore. Ho fiducia che le cose andranno come avete appena detto.»
Rinaldo fece un gesto come a dire che era presto per i ringraziamenti, poi guardò fuori dalla finestra e disse: «A questo punto, direi che è arrivato il momento di interrompere il nostro lavoro in convento e andare al palazzo del podestà».
Era il momento che Uberto aspettava. Aveva pensato di cercare di convincere il prelato a cambiare idea, ed era certo che, dopo una insistenza solo formale, Rinaldo avrebbe ceduto. Ma in quel momento la sua rabbia era troppa. “Lasciamo che si trovi ad affrontare le conseguenze della sua testardaggine” pensò.
«Certamente, monsignore. Darò subito disposizioni per formare un piccolo corteo di accompagnamento.»
«Niente cortei e niente pompa» ribatté Rinaldo. «Non faremmo che eccitare di più la folla. Andremo solo noi due, accompagnati da due monaci con turibolo e navicella e da un crucifero.»
Uberto chinò la testa, come se quella idiozia fosse un’idea sensata. «Come desiderate» disse, e uscì dallo studio.
Scendendo le scale, aveva già in mente i nomi dei monaci che li avrebbero accompagnati. Uno di loro era quasi certamente la spia che andava a riferire ogni cosa all’arcivescovo. Nel corso del giorno precedente l’aveva sorpreso due volte a colloquio con Rinaldo. Lo avrebbe incaricato di portare la croce. Era giusto che condividesse i rischi di una situazione che si era venuta a creare anche per colpa sua. Gli altri erano due giovani robusti che in caso di guai avrebbero potuto difenderli.
Davanti alla porta chiusa dello studio del priore, Uberto si fermò con la mano alzata per bussare, folgorato da un pensiero improvviso. In un momento così importante per la sua vita, prima di fare qualsiasi cosa doveva pregare. Si allontanò in fretta e si diresse verso la piccola cappella ricavata nella cella in cui era spirato san Domenico.
Appena entrato, cadde in ginocchio e si rivolse direttamente al santo, chiedendogli di intercedere per lui presso il Signore. La sua carriera ormai era finita, questo Uberto lo sapeva. Se non fossero riusciti a interrogare il prigioniero, l’arcivescovo lo avrebbe sottoposto all’umiliazione di dover rendere conto a due frati francescani, il che era quasi peggio che essere destituito. Se invece fossero arrivati sani e salvi al palazzo del podestà, Rinaldo avrebbe saputo che il Templare era stato interrogato sotto tortura in presenza di Uberto, e lo avrebbe sospeso a divinis dall’incarico.
Solo un intervento divino poteva salvarlo.
Uberto esaminò la propria coscienza e concluse che aveva fatto il proprio dovere per estirpare l’eresia. Ora la responsabilità non era più nelle sue mani. Se Dio voleva che continuasse a difendere la causa della fede, doveva mandargli un segno, eliminando gli ostacoli dalla sua strada.
In quell’attimo preciso nella sua mente si formò l’immagine dell’arcivescovo assassinato dalla folla.
Uberto si portò le mani al viso, inorridito. Era possibile che san Domenico, il santo predicatore fondatore del suo ordine, gli suggerisse un’azione così efferata? Senza ammettere con se stesso di considerare possibile l’assassinio di un ministro della Chiesa, si mise a esaminarne le ricadute in modo spassionato, come una sorta di esercizio intellettuale. Se Rinaldo da Concorezzo fosse scomparso dalla sua strada, la Chiesa ne avrebbe guadagnato e la sua carriera invece di essere stroncata avrebbe compiuto un balzo in avanti. In mancanza dell’arcivescovo, poteva darsi benissimo che papa Clemente V affidasse a lui la direzione del processo. E anche se un altro arcivescovo fosse stato nominato in fretta e furia, il direttore in pectore del processo sarebbe comunque rimasto Uberto, che l’aveva seguito fin dalle sue prime fasi e ne conosceva i risvolti meglio di chiunque altro.
Sempre come possibilità astratta, l’inquisitore esaminò i modi in cui un eventuale sicario avrebbe potuto portare a termine l’omicidio, e si rabbuiò. In pratica, per incarichi di quella natura poteva contare solo su Guido Arlotti, e lo spretato non avrebbe mai acconsentito ad assassinare un arcivescovo della Chiesa di Cristo, a meno che non glielo ordinasse il pontefice in persona.
L’unica altra possibilità era che fosse lui stesso a farsi esecutore della volontà del santo. Ma anche questo non aveva senso. L’arcivescovo doveva sparire subito, e anche se avesse voluto, Uberto non poteva certo pugnalarlo nel suo studio o in mezzo alla strada, sotto gli occhi di tutti.
Rassegnato, confessò mentalmente a san Domenico di non riuscire a comprendere il suo messaggio, si fece il segno della croce e aprì gli occhi.
E in un attimo tutto gli fu chiaro.
Quello che era stato il letto del santo, il luogo preciso in cui era spirato, era illuminato da un raggio di sole che entrava dall’imposta socchiusa. Il resto della stanza era in ombra, ma quel modesto pagliericcio posato su poche assi di legno grezzo splendeva come un trono regale. Uberto comprese di aver peccato di presunzione, e si affrettò a chiedere perdono, con le lacrime agli occhi dalla commozione.
Aveva creduto di dover essere lui a farsi interprete del messaggio, di dover essere lui ad agire. Nella propria superbia aveva considerato, benché in modo astratto, l’idea di commettere un omicidio, dannandosi l’anima per l’eternità. Invece l’immagine dell’arcivescovo ucciso dalla folla era solo una premonizione, inviatagli da san Domenico per tranquillizzarlo. Dio e i santi erano in grado di rimuovere da soli ogni ostacolo dalla propria strada. Come aveva potuto pensare di sostituirsi a loro? Uberto promise che si sarebbe imposto una dura penitenza, umiliandosi nel corpo e nello spirito, per espiare quel peccato di presunzione. E subito dopo ringraziò per ciò che gli veniva concesso: l’opportunità di salire di grado in seno alla Chiesa per poter essere più efficace nella lotta contro l’eresia.
Come in risposta ai suoi pensieri, il raggio luminoso svanì lentamente e la stanza tornò in penombra. Uberto si alzò in piedi e uscì dalla cappella, pieno di energia. Passò dall’ufficio del priore a chiedere l’autorizzazione per portare con sé i tre monaci e la croce. Alle rimostranze dell’omone spiegò che si trattava di una richiesta esplicita dell’arcivescovo, e ottenuto il permesso andò ad avvisare i monaci prescelti di prepararsi. Poi risalì le scale per tornare nel suo studio. Era certo che l’ora di Rinaldo da Concorezzo fosse suonata. Guidato da mani divine, un sasso o una bastonata lo avrebbero ucciso quella mattina stessa.
Lui non avrebbe dovuto sporcarsi le mani, e ne era felice. Tuttavia avrebbe tenuto gli occhi aperti, e se si fosse presentata l’occasione di aiutare la divina provvidenza, non l’avrebbe sprecata.
Per condurre Mondino al palazzo del podestà le guardie fecero il giro lungo, evitando di attraversare Piazza Maggiore, dove stavano convergendo sempre più persone. Anche da lontano si udivano provenire dalla piazza grida e rumori, nonostante il mercato che vi si svolgeva di solito fosse chiuso perché era domenica.
«Cosa succede?» chiese il medico, a nessuno in particolare.
Non l’avevano legato. Per impedirgli la fuga i due che l’avevano preso in consegna si limitavano a tenerlo in mezzo a loro, mentre Luca, il caposquadra, li precedeva di un paio di passi.
Fu lui a rispondergli, senza voltarsi a guardarlo. «Si è sparsa la voce che è stato arrestato lo stregone che ha ucciso quegli uomini trasformandogli il cuore in un pezzo di ferro, e che siccome si tratta di un monaco templare, il podestà pensa di liberarlo e mettere tutto a tacere, per non entrare in urto con la Chiesa. La folla vuole fare giustizia senza aspettare il processo.»
Mondino sentì il cuore perdere un colpo. La sua ultima speranza di salvezza se ne andava con quelle parole.
«Come si chiama l’uomo che avete arrestato?» chiese, tanto per essere sicuro.
«Francesco Salimbene. Ma si dice che sia un nome falso. Dovreste conoscerlo, direi.»
«E davvero il podestà vuole liberarlo?»
«Scherzate? Non so chi abbia messo in giro questa voce.»
Stavano passando dietro il palazzo di Accursio, che era stato acquistato dal Comune ed era diventato la sede del Consiglio degli Anziani. La messa era finita e la gente sciamava fuori dalle chiese, dirigendosi alla spicciolata verso la piazza. Nessuno prestava particolare attenzione al gruppetto di birri.
«Vi conviene stare zitto e non creare problemi» disse Luca, fermandosi di botto e voltandosi a guardarlo. «Se sapessero che anche voi siete implicato in quegli omicidi, vi farebbero a pezzi sul posto e non potremmo fare nulla per difendervi.»
«Io sono innocente» disse Mondino, guardandolo negli occhi.
«Allora vi conviene doppiamente tacere» rispose Luca, con una sfumatura di sarcasmo nella voce.
Ripresero a camminare, e poco dopo sbucarono nella piazza contigua a Piazza Maggiore, dove nei giorni feriali tenevano i loro banchi i ramaioli. Tutto lo spazio tra il palazzo degli Anziani e il palazzo vecchio del Comune, che era servito da prigione per re Enzo, straripava di gente. La piazza era affollata come il giorno di San Bartolomeo, durante la Festa della Porchetta. Ma il popolo lì riunito non aveva affatto l’aria di gioiosa attesa di quando si aspettava il tradizionale lancio di cibarie e monete dal balcone del Comune. Le grida e il brusio erano quelli di una folla inferocita, che voleva sangue.
Mondino chinò la testa e continuò a camminare.
Le poche decine di passi che lo separavano ancora dall’ingresso posteriore del palazzo del podestà gli sembrarono leghe. Per evitare di essere riconosciuto non alzò la testa neppure quando entrarono sotto il voltone a crociera che sosteneva la torre dell’Arengo. A parte i soldati che sorvegliavano le porte d’accesso ai tre palazzi contigui del...