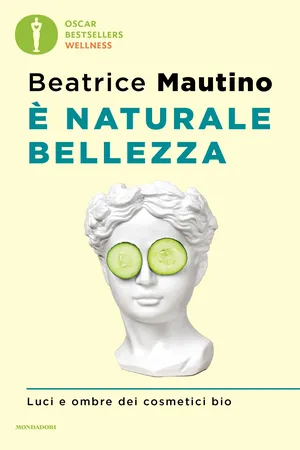Nel capitolo precedente abbiamo visto che non sempre un prodotto naturale è la scelta più etica per un consumatore particolarmente sensibile e attento. E se la cosa vi ha spiazzato, in questo capitolo vi spiazzerò ancora. Se siete tra le tante persone che pensano che «tutto ciò che è naturale fa bene» o che un prodotto naturale non possa in alcun modo essere pericoloso o dannoso, ebbene, troverete di che stupirvi. Perché anche gli ingredienti naturali, come tutti, contengono insidie e pericoli – qualcuno ricorda la famosa cicuta? –, dunque è importante conoscerli e, ancora una volta, mettere da parte storytelling e ideologie per addentrarsi nei meandri della scienza.
Il processo
È il pomeriggio del 20 maggio 2021, siamo nelle aule virtuali del Senato della Repubblica alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero della Salute Pierpaolo Sileri e di Massimo Casciello, al vertice della direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del ministero della Salute. Il tema dell’audizione sono gli effetti dell’entrata in vigore del Regolamento 2021/468 della Commissione europea che «mette in difficoltà molte nostre aziende e per alcune prefigura un serio rischio di sopravvivenza» dichiara in apertura l’onorevole Dario Stefano, presidente della Commissione permanente sulle politiche Ue del Senato, definendo «incomprensibile» il divieto imposto dal Regolamento della commercializzazione di prodotti contenenti determinate sostanze chimiche.
«Il regolamento si basa su un parere dell’Efsa non del tutto ultimativo» continua Stefano, «che rileva una presunta dannosità per la salute [...] e ci è sembrato evidente da subito che vi fosse una mancanza di proporzionalità tra il tenore del parere, formulato non in termini assoluti, e il divieto di commercializzazione previsto dal regolamento.» Per questo motivo, il presidente chiede che «il Governo si attivi a livello politico presso le istituzioni europee per cercare di integrare e di modificare la normativa appena approvata, in modo tale da renderla un po’ meno drastica e severa nei confronti degli operatori interessati dal divieto di commercializzazione», in più si aspetta che «il Governo immagini una qualche forma di compensazione finanziaria nei confronti dei soggetti privati che dall’oggi al domani hanno dovuto cessare o dovranno limitare fortemente le loro attività a causa dell’entrata in vigore del regolamento» e per ultimo che valuti «l’opportunità di ricorrere presso il giudice europeo al fine di chiedere l’annullamento di questo regolamento».
Gli danno man forte i rappresentanti delle associazioni di categoria che entrano nel merito scientifico del provvedimento dichiarando che «il divieto si basa su un possibile problema di cancerogenicità e genotossicità. In sintesi, l’Efsa nella sua scientific opinion conclude il suo rapporto ipotizzando che potrebbe esserci un reale rischio», ma «si riporta tuttavia che permane l’incertezza scientifica di tali effetti, che pertanto andrebbero verificati». Insomma, potrebbe essere cancerogeno, ma non ne siamo ancora del tutto sicuri.
«L’Italia è leader mondiale nel settore» aggiunge il rappresentante delle aziende, quindi «è necessario valutare la ricaduta economica che l’applicazione di tale regolamento avrebbe con ripercussioni negative rilevanti su tutta la filiera.» Un mercato che, continua un altro esponente delle aziende coinvolte, «vale circa 3,8 miliardi di euro; di questi, 800 milioni vengono esportati. Già questo, quindi, fa capire l’importanza del settore che annovera circa 22.000 addetti». A questo si aggiunge il «dubbio che in casi come questo non la salute del cittadino europeo sia stata messa al primo posto, ma che la scelta proibizionistica sia solo il frutto di una contrapposizione commerciale in atto tra i Paesi del Nord Europa e quelli del Sud» sulla base di una differenza nell’approccio a questo genere di prodotti, «quindi tra lobby di interessi industriali».
Tipico delle aziende, potremmo pensare, cercare di ridimensionare un allarme lanciato da un ente indipendente di controllo facendo invece leva sull’utilizzo diffuso e sull’importanza per l’economia. Quante volte lo abbiamo visto fare? Quante volte abbiamo visto emergere i distinguo di fronte alla valutazione negativa di una sostanza chimica importante per un certo settore industriale? Nel mio libro precedente, La scienza nascosta dei cosmetici, ho raccontato del lavoro che stanno facendo le associazioni di categoria delle aziende cosmetiche nazionali e internazionali per contenere i danni di un’annunciata restrizione delle microplastiche. In fondo, il lavoro di queste associazioni è proprio quello di difendere gli interessi delle proprie aziende associate. Starà poi agli organi politici trovare il giusto compromesso tra gli interessi di tutti (cittadini compresi, ovviamente) e la valutazione scientifica di enti come Efsa o, nel caso delle microplastiche, l’Autorità europea per le sostanze chimiche Echa.
Quando però si parla di salute e di sostanze cancerogene ci aspettiamo che la bilancia degli interessi penda dalla parte dei cittadini e che si prendano provvedimenti, magari più restrittivi del necessario, «per precauzione». Quante volte avete sentito pronunciare da chi è sospettoso verso l’industria chimica o la chimica stessa frasi come «Il sicuro per legge non esiste!», «Con la salute non si scherza!», magari protestando per i tempi lunghi che intercorrono tra l’inizio della valutazione del rischio di una sostanza e l’effettivo provvedimento restrittivo? Su un forum dedicato ai cosmetici naturali ho letto un’invettiva contro aziende e autorità europee responsabili di aver fatto ammalare molte persone per non aver agito tempestivamente per vietare una determinata sostanza chimica.
Mi aspettavo di leggere proteste simili anche per questa audizione e per la risposta accondiscendente di Sileri, che ha spiegato ai presenti che l’Italia aveva votato contro il provvedimento restrittivo e che aveva chiesto di «mettere queste sostanze sotto monitoraggio, alla luce dell’incertezza sulla loro effettiva tossicità, piuttosto che bandirle del tutto». Insomma, dare ancora tempo alle aziende – oltre quello che hanno già avuto a disposizione dalla valutazione di Efsa del 2017 – per adeguarsi, produrre documentazione o cambiare produzione. Sileri aggiunge che il ministero sarà «al fianco di coloro che proporranno ricorso, supportandoli in questo contenzioso, sottolineando, come abbiamo appena fatto, tutte le criticità del regolamento».
Dicevo che mi aspettavo di vedere proteste tonanti contro questa iniziativa, interrogazioni parlamentari contro il ministero al soldo delle associazioni industriali, petizioni su Change.org, dibattiti indignati sui giornali sul pericolo delle lobby, «La salute dei cittadini deve venire prima dei profitti delle aziende!», ma niente.
Non una riga. Non una protesta. Manco un j’accuse. Nulla.
Sapete perché? Perché la protagonista di tutta questa vicenda non è una sostanza chimica di quelle che abbiamo imparato a conoscere nel dibattito pubblico. Non parliamo di siliconi, non parliamo di filtri solari, non parliamo nemmeno di glifosato.
Parliamo di aloe. Già, proprio la pianta, quella che si usa per alleviare i sintomi delle scottature, della quale molte persone bevono il succo, che tanti usano come integratore, che la stragrande maggioranza considera non solo innocua, ma anche benefica. Peccato però che contenga «naturalmente» delle molecole, chiamate idrossiantraceni, genotossiche e cancerogene.
A difenderle in Senato non c’erano le classiche multinazionali della chimica, non c’era Big Pharma, ma c’erano FederSalus, che riunisce i produttori di integratori alimentari, e la Federazione erboristi italiani.46
Quella che avete letto è una storia abbastanza normale nel rapporto tra istituzioni e aziende. Non c’è nulla di male nel chiedere di salvare un settore produttivo importante, ed effettivamente, come ricordato dagli industriali, l’Italia è leader mondiale nel settore degli integratori. Sono vere anche alcune delle osservazioni tecniche presentate nell’audizione, sono veri certi distinguo e certe sottigliezze, ed è ragionevole la richiesta di pensare a un compromesso che permetta di continuare a utilizzare questi prodotti nonostante contengano sostanze cancerogene. In fondo, lo facciamo anche in altri casi, pensate al vino, alla birra e agli insaccati. Perché il prosciutto di Parma o di San Daniele possiamo continuare a mangiarli, mentre l’integratore con l’aloe no?
Per trovare una risposta dobbiamo partire dall’inizio della vicenda; userò come spunto una domanda posta dall’onorevole Pietro Lorefice, presente all’audizione. Lorefice osserva che «l’impulso di tutto è partito dall’Efsa, che è l’Autorità europea per la sicurezza alimentare», e fin qui ci siamo. «Vorrei capire meglio con quale tipo di studio e a quale livello di approfondimento l’Efsa normalmente fa questo tipo di attività? Ci sono altri casi di segnalazioni provenienti dall’Efsa che poi sono stati trasfusi in un regolamento europeo?» La domanda di Lorefice esprime bene la curiosità che può avere un comune cittadino di fronte alla complessità della macchina europea. Stupisce che un politico queste cose non le sappia, così come stupisce che, «visto che l’Efsa ha sede a Parma», voglia «chiedere direttamente un’audizione dei suoi rappresentanti per approfondire la questione con i diretti interessati che hanno originato gli studi».
Partiamo quindi dalle basi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare non conduce ricerche, nella sede di Parma non ci sono laboratori, gli esperti dell’Efsa non fanno test sulle sostanze. «Paragono quello che faccio a un processo giudiziario» mi spiega Camilla Smeraldi, team leader del gruppo di lavoro dell’Efsa sugli additivi e gli aromi, che si è occupata, tra le tante cose, della valutazione sugli idrossiantraceni presenti nell’aloe. Ho raccolto il suggerimento dell’onorevole Lorefice e ho chiesto un’audizione personale a Efsa per provare a raccontare il lavoro che fanno.
«Quando dopo la maturità dovevo decidere che corso di laurea seguire ero indecisa come tutti, ma avevo un’unica certezza: non avrei mai fatto giurisprudenza.» Smeraldi si è poi laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche, ma scherza sul fatto che «per una specie di contrappasso» si è ritrovata a lavorare con leggi e regolamenti quasi di più che se non avesse fatto l’avvocato. L’Efsa è un ente scientifico al servizio della Commissione europea. È stato fondato nel 2002 con il Regolamento n.178 del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa e la sua nascita ha segnato un passaggio storico perché ha diviso formalmente e in maniera netta le due fasi di valutazione e gestione del rischio degli alimenti che fino a quel momento erano condotte dalla Commissione stessa.
«L’Europa è tripolare» mi spiega Michele Fino, mio esperto da taschino di questioni europee. «Abbiamo un Consiglio partecipato dai governi degli Stati membri, abbiamo un Parlamento che eleggiamo noi cittadini e abbiamo poi la Commissione che è il braccio operativo, quella che si occupa della gestione ordinaria.» La Commissione è una struttura gigantesca, ci lavorano ventimila persone, qualificatissime e con competenze che vanno dalla salute all’agricoltura, passando per l’economia e il clima, e ha il compito di emettere direttive o proporre leggi e regolamenti al Parlamento che poi voterà.
Fino mi spiega che il sistema che prevedeva che fosse la Commissione a valutare e poi gestire il rischio «è andato bene fino a quando non è arrivato il morbo della mucca pazza», una malattia provocata da alcune proteine modificate chiamate prioni che si aggregano nel cervello dei bovini formando delle placche che portano inevitabilmente alla morte. Questa malattia può essere trasmessa agli esseri umani provocando conseguenze analoghe nel nostro cervello. La situazione è diventata preoccupante a metà degli anni Novanta, soprattutto nel Regno Unito, quando la malattia si è trasformata in epidemia a causa delle condizioni di allevamento dei bovini alimentati con farine animali, provocando la morte di quasi duecento persone in tutto il mondo. «La Commissione è un organo politico» continua Fino, «e un organo politico subisce pressioni che possono influenzare il processo di valutazione del rischio. Sulla vicenda della mucca pazza si è mossa tardi e male» provocando una serie di reazioni a catena come la chiusura delle frontiere e il blocco delle importazioni. Il Regolamento 178/2002 è figlio di quel disastro lì e separa, come dicevamo, nettamente la parte di gestione del rischio, che rimane in capo alla Commissione, da quella della valutazione, che viene affidata alla nascente Efsa, un ente indipendente, formato da scienziati che non prendono provvedimenti, non hanno potere esecutivo, ma forniscono un parere scientifico su un determinato tema che la Commissione userà come base per le proprie proposte o decisioni. In campo cosmetico, il ruolo che l’Efsa svolge per gli alimenti è svolto dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (Cssc), del quale abbiamo già parlato più volte nelle pagine precedenti, ma è importante anche il ruolo dell’Autorità europea per le sostanze chimiche, che si occupa anche di proporre revisioni dei diversi settori, come nel caso degli inchiostri per tatuaggi – lo vedremo più avanti.
Sul piano pratico, Camilla Smeraldi mi racconta che «l’Efsa riceve l’incarico di fare una valutazione di sicurezza prevalentemente da parte della Commissione o, occasionalmente, dagli Stati membri» e queste richieste sono sostanzialmente di due tipi: «richieste di autorizzazione all’immissione in commercio o all’uso di una particolare dicitura che derivano dall’inoltro di dossier provenienti da aziende del settore, per esempio», oppure «quelli che chiamiamo mandati generali, cioè la richiesta da parte della Commissione di valutare questioni di natura più generale o non necessariamente riconducibili a una sola azienda, come, per esempio, la valutazione del rischio di contaminanti presenti nella catena alimentare o la rivalutazione di tutti i coloranti consentiti».
Ricade nel primo caso la storia dell’aloe che tanto ha fatto smuovere gli animi degli erboristi e dei produttori di integratori, mentre è finito sotto l’esame di un mandato generale un altro ingrediente famoso di cui, nei mesi di scrittura di questo libro, si è parlato molto nel dibattito pubblico, il biossido di titanio.
Il difficile caso del titanio
Il biossido di titanio è uno degli ingredienti storici di moltissimi settori produttivi, dalle vernici alla pasticceria, dai cosmetici all’edilizia. In campo alimentare si usa, con la sigla E171, come colorante bianco per integratori, prodotti da forno, zuppe, brodi, salse, insalate, creme salate da spalmare, nella pasta da zucchero e, più in generale, nei prodotti per la decorazione e il modellaggio delle torte; mentre in campo cosmetico ha le applicazioni più disparate: viene utilizzato come protezione solare (insieme all’ossido di zinco è uno dei famosi «filtri fisici» che sono percepiti come più «naturali» dei temutissimi «filtri chimici»), base per la produzione di pigmenti perlescenti, riempitivo per far volume.
Il 6 maggio del 2021 è uscita una nota di Efsa nella quale si comunicava che proprio a proposito del biossido di titanio l’Autorità «non ha potuto escludere timori in termini di genotossicità, ovvero la capacità di una sostanza di danneggiare il Dna. Dopo l’ingestione l’assorbimento di particelle di biossido di titanio è basso, tuttavia esse possono accumularsi nell’organismo. Tale elemento, insieme alla carenza di dati, ha comportato per il gruppo di esperti scientifici l’impossibilità di trarre conclusioni circa la sicurezza del TiO247 per gli animali, i consumatori e l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, il biossido di titanio, se inalato, è considerato potenzialmente cancerogeno».
Leggere le parole «genotossico» e «cancerogeno», pur con tutte le cautele espresse nella nota, associate a un prodotto utilizzato per le torte di compleanno dei bambini potete immaginare che tipo di reazioni abbia generato. Le associazioni di consumatori si sono mosse per chiederne il bando, i pasticceri hanno domandato preoccupati delucidazioni alle aziende, le aziende hanno minimizzato appellandosi al fatto che la valutazione di Efsa non è un divieto all’uso del colorante, gli altri settori produttivi, come quello cosmetico, hanno iniziato a sudare freddo, perché quando succede qualcosa di grosso in campo alimentare, poi sicuro arriva anche a loro, moltiplicato per dieci.
Per esempio, sappiamo già da molto tempo che il naturalissimo biossido di titanio tanto in voga nel make-up minerale e nei solari con filtri fisici è «cancerogeno se inalato», come riportato dalla nota di Efsa, ma anche nei pareri del Cssc che, infatti, lo ha valutato come non sicuro negli spray, con un processo simile a quello dell’ossido di zinco di cui abbiamo già parlato.
In campo alimentare, la storia della valutazione del biossido di titanio parte da lontano, mi racconta Camilla Smeraldi, «nel 2010, dopo la pubblicazione della lista con tutti gli additivi in uso fino a quel momento, circa trecento, e la Commissione ci ha chiesto di valutarli nuovamente tutti»48 con un ordine di priorità che metteva per primi i coloranti, a seguire i conservanti, poi gli emulsionanti, per ultimi i dolcificanti subito dopo le sostanze non classificabili in nessuna di queste categorie.
Per ognuna di queste sostanze «bisogna seguire una procedura ben definita» continua Smeraldi, che serve a garantire uno standard comune a tutte le valutazioni. Ogni sostanza, sia essa di origine naturale o sintetica, riceve lo stesso trattamento.
Questo potrà forse stupire qualcuno che si aspetta, magari inconsciamente, un qualche «trattamento di favore» per le sostanze presenti in natura, ma dal punto di vista della sicurezza non fa alcuna differenza se una molecola è stata sintetizzata in un laboratorio o prodo...