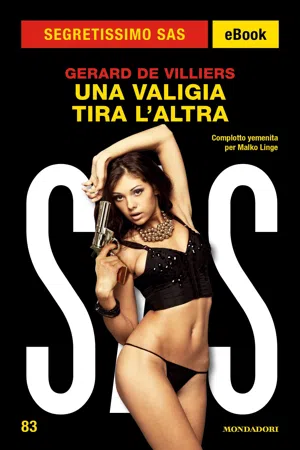Un gatto nero, senza coda, coperto di mosche, miagolava in equilibrio su un bidone delle immondizie. Oleg Kopecki voltò la testa e si fermò davanti a una delle passerelle che scavalcavano l’enorme fogna scoperta, profonda più di due metri, che divideva in due la Ring Road. Data la carenza di scarichi, l’utilità di tale fogna, l’unica di Sanaa, appariva dubbia. In realtà era una trappola per gli automobilisti distratti o maldestri che ci finivano dentro.
Un cartello attaccato alla passerella indicava AL GHALEDI GROUP e una freccia era rivolta verso l’altro lato della strada. Lì sorgeva, tra una viuzza sassosa e un terreno incolto, un palazzo moderno di quattro piani. La facciata marrone era tutta lavorata e i locali commerciali al pianterreno erano protetti da serrande di ferro. Oleg Kopecki, in attesa di un momento di calma nel traffico, si asciugò la fronte con un fazzolettone a scacchi. Il sole picchiava ancora forte e nemmeno il berretto di tela bianca riusciva a proteggerlo. Aveva lasciato la sua Mercedes 200 grigia all’angolo di Az Zubayri Road, duecento metri più in là.
Si guardò istintivamente intorno. Sul marciapiede che aveva appena lasciato vide solo un droghiere sdraiato su sacchi di semola davanti al suo baracchino, con la guancia sinistra gonfiata da una grossa cicca e lo sguardo perso nel nulla. Anche se tutto l’esercito sovietico gli fosse sfilato davanti non ci avrebbe fatto caso.
Effetto del qat: le foglie di un arbusto che cresceva un po’ dappertutto, che venivano masticate per ore e il cui succo procurava uno stordimento passeggero, simile a quello procurato dall’oppio. La follia dello Yemen. Tutti i pomeriggi, la vita rallentava o si interrompeva fino alla preghiera della sera. Tutti “qatavano”. Da soli. Con amici. A casa loro. Al lavoro. Dappertutto. Talvolta un guidatore di taxi troppo euforico si schiantava contro un muro con tutti i passeggeri. A cinquanta o cento rial al mazzo, il qat costituiva un mercato fantastico. La principale preoccupazione degli impiegati la mattina era di sapere come si sarebbero procurati il loro mazzo quotidiano. Non conveniva trattare affari con loro durante la mattinata: le mance salivano alle stelle. Verso mezzogiorno la pressione diminuiva, mandavano un ragazzino a cercare la loro razione al mercato e, finalmente sereni, si apprestavano a ciccare per il resto della giornata.
Nessuno aveva ancora capito come mai il paese potesse andare avanti, dato che la quasi totalità degli yemeniti si dava alle gioie del qat, il che affilava le guance e conferiva a tutti un’aria sempre allucinata. Le persone serie si limitavano a ciccare il giovedì e il venerdì…
Mentre il sovietico lo osservava, il droghiere sfilò dalla larga cintura, nella quale era infilata l’enorme e oscena janbiya, il caratteristico pugnale ricurvo, una bottiglietta di acqua minerale e ne bevve una sorsata. Il qat dava sete e le vie di Sanaa erano cosparse di bottigliette di Shamran, la Perrier locale.
Oleg Kopecki guardò con disgusto il vecchio yemenita e si avventurò nell’attraversamento della strada, approfittando di una pausa del traffico.
Col loro berretto bianco, i pantaloni troppo larghi, la faccia rubiconda e la camicia dalla tinta smorta, i russi si riconoscevano a un chilometro di distanza. Ce n’erano migliaia a Sanaa, tra consiglieri militari e civili, diplomatici, tecnici…
Passando accanto a una Mercedes nera dai vetri oscurati e provvista di un telefono, ferma davanti all’edificio, il sovietico entrò nell’atrio buio e si diresse verso la scala, subito bloccato da un soldato che gli sbarrò la strada, con la mano destra alzata e le dita riunite verso l’alto, in un gesto tipicamente yemenita che significava “stop”. Ne arrivò un altro che gli sussurrò qualcosa all’orecchio, e il primo si scostò. Tutti e due tenevano infilata nel cinturone una grossa pistola. Gli yemeniti non potevano sopportare le fondine. Oleg Kopecki premette un bottone dell’interfono a sinistra della scala: era già a corto di fiato.
Sanaa si trovava a 2200 metri di altitudine, e il cuore foderato di grasso del sovietico faceva fatica a pompare. Doveva partecipare a una riunione, una riunione che lo preoccupava molto.
Il colonnello Mohammed Bazara era affetto da un incontrollabile battito di palpebre: per questo aveva l’aria di uno che nascondesse sempre il proprio pensiero, cosa peraltro vera. Quando si metteva gli occhiali neri, con quei suoi capelli ondulati, il naso lungo e un po’ forte, e la bocca ben disegnata sembrava un playboy.
Accolse Oleg Kopecki con un abbraccio caloroso e lo salutò in russo. Prima di diventare capo dell’Elham El Makasi, ossia la Sicurezza di Stato, aveva frequentato una scuola per ufficiali a Sebastopoli e aveva soggiornato più volte in Unione Sovietica. Un donnone dalla faccia sgraziata e dagli occhi neri e infossati, vestita come una stracciona, portò del tè e poi scomparve. Oleg Kopecki si lasciò cadere su un gracile divanetto per riprendersi dalla salita di quattro piani.
Dopo avere bevuto un po’ di tè, chiese in tono troppo cordiale: — Allora, Mohammed, perché volevi vedermi? Qualcosa non va nel nostro progetto?
Oleg Kopecki, rezident del KGB a Sanaa, sotto la copertura di direttore del Centro di Espansione Economica, utilizzava quel recapito solo per gli incontri segreti. Quelli che non rientravano nel quadro delle relazioni strette e ufficiali yemenosovietiche.
Il colonnello Bazara batté furiosamente le palpebre.
— No, no, non c’è nessun contrordine. Prima di tutto volevo consegnarti questo.
Porse al sovietico una valigetta ventiquattr’ore nera nuovissima, ancora avvolta nel suo imballaggio originale di plastica. Un oggetto stupendo, firmato Asprey, con due serrature a cifre. Oleg Kopecki la guardò e chiese: — L’altra è stata consegnata al suo destinatario?
— Sì.
— Allora va tutto bene.
L’ufficiale yemenita si passò nervosamente la lingua sulle labbra aride. Tra la polvere e l’altitudine, si aveva sempre sete a Sanaa. E se poi vi si aggiungeva l’angoscia…
— Mi chiedo se non ho commesso un’imprudenza… — attaccò il colonnello.
Oleg Kopecki si irrigidì.
— Cioè? — disse in tono troppo calmo.
Mohammed Bazara si sporse in avanti, come se qualcuno avesse potuto ascoltarli, benché fossero soli nell’appartamentino.
— Ecco, tu sai che avevo ordinato le valigette tramite un’amica. Quando le ha ricevute, le ha depositate presso quella ragazza etiope che…
— So chi è — lo interruppe Oleg un po’ bruscamente. — Continua.
— Ho autorizzato l’etiope ad avere contatti con un tuo omologo. Capisci cosa voglio dire?
— Sì. E allora?
Era dura da mandare giù. Il sovietico teneva gli occhi fissi in quelli del suo interlocutore, come per fargli sputare fino all’ultima briciola di verità.
— Bene, quando quell’uomo è andato da lei, ha visto le due valigette e le ha chiesto a chi erano destinate. Lei ha risposto che una era per me e l’altra per il capitano Sharjaq. Questo pare che gli sia bastato e credo che non ne farà alcun cenno nel suo rapporto. Però in seguito potrebbe ricordarsene…
Oleg Kopecki scosse lentamente la testa come un elefante stanco e disse in tono rassegnato: — Ti ho sempre detto che queste storie di agenti doppi finiscono male.
— Credi che sia grave? — domandò ansiosamente Bazara.
Il sovietico gli rivolse un’occhiata da gelare l’Everest.
— Non è grave. È disastroso.
Un pesante silenzio fece seguito alle sue parole. Bazara non osava più guardarlo in faccia e nemmeno accendere una sigaretta. Oleg Kopecki si appoggiò allo schienale del divanetto, imprecando tra sé in russo. Che tristezza lavorare con simili cretini! Se Bazara fosse stato un suo dipendente lo avrebbe imbarcato sul primo aereo per Mosca, con l’ordine di fargli finire la carriera a Ninji-Novgorod… Purtroppo non era così e oltretutto aveva ancora bisogno di lui.
— Capirai bene — disse in tono tagliente — che dobbiamo rinunciare a tutta l’operazione. Non possiamo rischiare che si possa risalire fino a noi, anche se il rischio è minimo. A meno che…
— A meno che?
Il sovietico non rispose e i due uomini si scambiarono un’occhiata molto esplicita. L’ufficiale yemenita si alzò come mosso da una pila elettrica.
— Me ne occupo immediatamente!
— Siediti e ascoltami — gli ordinò in tono gelido Oleg Kopecki. — Non è il caso di partire a testa bassa, ma di mettere in piedi una scena che impedisca di pensare subito a noi. I nostri omologhi non sono degli imbecilli, ma anche se non crederanno alla messinscena avranno solo dei sospetti, niente di solido.
— Ho un’idea — disse Bazara.
La espose al sovietico, che alla fine disse a fior di labbra: — Può funzionare. Ma bisogna fare presto. Ogni minuto rappresenta un rischio potenziale. E per il momento lascia stare l’altra ragazza. Falle solo paura.
— Nulla è possibile fino a dopodomani, se procediamo in questo modo — disse Bazara.
Oleg Kopecki guardò l’orologio, prese la valigetta avvolta nella plastica e si alzò.
— Alla settimana prossima.
Mohammed Bazara lo accompagnò alla porta. Si abbracciarono di nuovo, poi il sovietico si avviò con passo pesante giù per le scale. Per tutti i quattro piani si chiese se avrebbe dovuto inviare a Mosca un rapporto su quell’incontro, o no… Se l’avesse fatto, il Centro avrebbe potuto gelare indefinitamente un’operazione sulla quale lui stava lavorando da mesi. Se non l’avesse fatto e qualcosa fosse andato storto, di sicuro l’avrebbero richiamato immediatamente a Mosca dove la sua carriera si sarebbe conclusa… come archivista.
Appena uscito nel polverone della Ring Road, risuonò il richiamo autoritario di un muezzin vicinissimo, subito seguito da decine d’altri che chiamavano alla preghiera della sera. A Sanaa nessuno doveva dimenticare che Dio è Dio e Maometto il suo profeta.
Jack Penny uscì dall’edificio nuovissimo dell’USIS, il servizio Informazioni degli Stati Uniti, che spesso serviva come copertura alla CIA. Si trattava di un capolavoro dell’architettura yemenita, con fontane, porte e finestre a ogiva, decorate con motivi di gesso bianco, e con pavimenti armoniosi. L’americano fece fatica a sistemare i suoi centonovanta centimetri nel Pajero di servizio. La maggior parte delle strade di Sanaa somigliavano a piste del Ténéré, e nessuna berlina di serie resisteva a lungo.
Uno degli assistenti di Penny, un nero della Georgia, gli gridò: — Dove vai?
— Al tennis — rispose Jack Penny.
L’altro abbozzò un risolino complice. — Balle! Hai trovato un’altra ragazza. Bastardo!
Il giovane americano era l’idolo di Sanaa. Un fisico da atleta, un profilo da gladiatore, denti smaglianti, gesti ampi e posati, e perfino un leggero tic che di tanto in tanto gli sollevava una narice, gli conferivano un fascino incredibile.
Aggrappato al volante, si apprestò a superare le gobbe e le buche che lo dividevano da Haddah Road, disperdendo un gregge di capre. L’USIS si trovava nella parte sud di Sanaa, dove la città e il deserto si fondevano in sfumature gialle e polverose. Dietro a lui, anche un’imponente Toyota Land Cruiser Saloon lottava contro il polverone. Era il non plus ultra, nello Yemen. Alta di carrozzeria, potente, comoda, veloce sia sulla strada che sulle piste, quel tipo di macchina affascinava i beduini che se la procuravano con qualsiasi mezzo, furto compreso. A Sanaa pullulavano. Lo Yemen del Nord era ufficialmente un paese povero, ma pieno di gente ricca.
Arrivato finalmente in Haddah Road, Jack Penny svoltò a destra, verso sud. Percorse un chilometro, poi girò a sinistra su una pista spaventosa.
Sballottato come un fuscello, si chiese d’un tratto se gli yemeniti avessero capito che lui era un agente della CIA. In carica da sei mesi, non aveva allacciato molti contatti, rifugiandosi nel lavoro di analisi. La ragazza che andava a trovare era la sua prima informatrice, cosa di cui andava fiero. Oswald Byrnes, il capo della stazione CIA di Sanaa, gli aveva raccomandato la prudenza. Gli americani non erano ufficialmente ben visti a Sanaa. Colpa dell’influenza sovietica e in ugual misura dei loro buoni rapporti con i sauditi, che erano detestati dagli yemeniti in modo particolare. Tuttavia non c’erano mai state dimostrazioni ostili. Il governo yemenita si era specializzato in un difficile numero di equilibrismo tra Est e Ovest. Una macchina incrociò il Pajero, lasciandosi dietro una scia sonora assordante. Il guidatore inturbantato picchiava sul volante rivestito di pelliccia sintetica, al ritmo di un versetto del Corano che usciva dall’altoparlante. L’uomo rivolse un sorriso cordiale a Jack Penny: aveva la guancia deformata da una grossa palla di qat. Gli yemeniti sembravano tutti affetti da mal di denti…
La notte era quasi scesa e il muezzin di una moschea vicina si scatenò, assordante. Jack Penny compì qualche g...