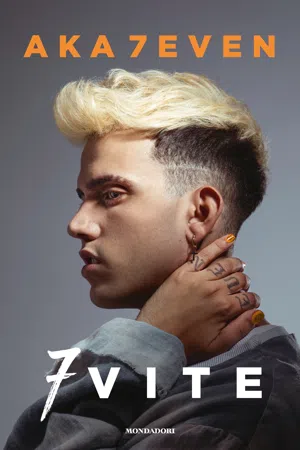![]()
![]()
HO VISTO IL NERO TRASFORMARSI IN BLU PER DIVENTARE GIALLO.
HO SENTITO LE LACRIME ASCIUGARSI SULLE GUANCE NELLA FORMA DI UN SORRISO.
HO CAPITO CHE A VOLTE BISOGNA CAMBIARE PER POTERSI ACCETTARE.
HO SENTITO PAROLE DI ODIO TRASFORMARSI IN IDOLATRIA E MI È VENUTO DA RIDERE.
HO FINALMENTE TROVATO IL CORAGGIO DI DIRMI ALLO SPECCHIO CHE VADO BENE COSÌ.
NON È STATO FACILE PER NIENTE.
NON TI DICO CHE NON INCONTRERAI IL BUIO.
MA TI PROMETTO CHE TORNERÀ LA LUCE.
![]()
Il 14 ottobre 2008 sono entrato in coma e ci sono rimasto per 7 giorni e 7 notti.
Avevo 7 anni.
E da quel giorno tutto è cambiato.
Non ho tanti ricordi di chi fossi prima. Di cosa mi piacesse. Di che carattere avessi.
Dei primi anni della mia vita ricordo poco, in generale.
Mi capita spesso di chiedere alle persone che fanno parte della mia vita quanto abbiano memoria della loro infanzia. In fondo davvero si può ricordare qualcosa avvenuto prima dei sette anni? Mi dicono: «Sì, io mi ricordo un sacco di cose» e partono i racconti del primo giorno di scuola, di episodi successi a quattro anni, di piccoli dettagli incastrati nella mente.
Io non ho niente. E allora do la colpa al coma. Qualcosa si è portato via.
Nessuno mai riuscirà davvero a spiegarmi che cosa successe in quei 7 giorni, ma so che ho rischiato di morire. Tredici anni fa ho rischiato di morire davanti agli occhi di mio fratello, tra le braccia di mia madre. Per una settimana la mia famiglia ha creduto di dovermi salutare per sempre. Non sono morto quel giorno, ma da quel giorno mi sento un sopravvissuto.
Non ricordo nulla, solo qualche sogno. Qualche voce, non saprei dire se reale o immaginata. Però so di aver visto una luce, proprio come si sente raccontare nei film. Ho sentito chiaramente una presenza divina, ho visto quello che forse è davvero l’ingresso dell’aldilà. E ricordo chiaramente, nitidamente, di aver incontrato i miei nonni. Non li avevo mai visti, non c’erano già più quando sono nato. In casa avevo visto solo qualche foto in bianco e nero. E invece, in coma, io li ho visti a colori, con gli abiti che indossavano prima di morire, quelli giusti, con quegli esatti colori.
Ho visto anche il mio cane. Lo avevamo dovuto regalare, non potevamo tenerlo. E io sapevo che era a Roma. Ma quando mi sono svegliato ho detto alla mamma che era morto.
Lei è convinta che io abbia visto il Paradiso, i nonni erano loro, il cane non c’era effettivamente più. Io non lo so che cosa ho visto, ma mi piace credere di aver visto oltre la vita.
Il resto è solo buio, sono le uniche cose che ho raccontato appena mi sono svegliato.
Il resto è tutto nero.
Ma sono certo che la mia testa in quei giorni sia andata da qualche parte, ed è come se in quel viaggio avessi abbandonato qualche pezzo di me. Non so chi fossi davvero prima del coma, ma da lì ho imparato a diventare quello che sono oggi. E no, non è stato per niente facile.
![]()
Sono da sempre convinto che tanto di quello che impari, sogni, desideri dipende dal contesto in cui nasci, dai luoghi e dalle loro influenze, da quello che vedi, incontri, ascolti. E soprattutto dalla tua famiglia. Il ruolo all’interno del proprio nucleo famigliare influenza il comportamento dell’adulto che sarai. Ognuno di noi, anche senza accorgersene, diventa qualcosa agli occhi di qualcuno. Puoi essere un figlio dal carattere vivace, un genitore severo, un fratello timido. Oppure puoi improvvisamente trasformarti nel bambino da proteggere. Quando la morte tocca così da vicino una famiglia, tutto quello che funzionava in un certo modo si stravolge. Da Luca, quello che non dà problemi, a Luca, quello che potevamo perdere.
Io sono l’ultimo di cinque fratelli. Il più piccolo. Una famiglia numerosa, molto unita. Non c’è nulla a cui io sia più legato. Papà camionista, mamma casalinga, hanno sempre avuto un gran da fare. Fin dai primissimi anni di vita io sono stato quello un po’ da proteggere e forse coccolare di più. Il bimbo più piccolo, il fratello minore. Per me non ci sono mai stati solo mamma e papà, per crescere, ma anche i miei fratelli maggiori, tanto più grandi e per questo immediatamente i miei punti di riferimento, quasi quanto i miei genitori. Nunzia, che ha sedici anni più di me e oggi fa la parrucchiera ed è mamma dei miei due nipotini, Miriam e Vincenzo, è la sorella grande, quella che aveva sempre qualcosa da fare. Domenico, maggiore di quindici anni, che insegna al conservatorio, è il fratello che più di tutti ha condiviso con me la mia passione per la musica. Poi Marianna, estetista, più grande di quattordici anni, che quando non c’era mamma c’era lei. E infine Mario, il più vicino a me in termini di età: ha ventitré anni ed è attualmente la persona della mia famiglia con cui vado più d’accordo. Siamo sempre stati tutti uniti dalla musica, cinque fratelli accomunati dalla stessa passione, chi più chi meno.
Ognuno di loro, a modo suo, mi ha sempre appoggiato quando è stato chiaro che la musica per me stava diventando qualcosa di più di una semplice passione. Non so dire se anche loro hanno mai sognato un posto nel mondo della discografia, ma so che non hanno mai fatto nulla per impedirmi di sognare in grande, e anzi, Marianna mi ha sempre spronato a non abbandonare la speranza di farcela, anche quando forse mi sembrava tutto troppo difficile. Me la ricordo, da piccolo, mi chiamava in salotto, con il microfono in mano: «Tieni, canta tu». Me lo passava e trascorrevamo tutta la sera a fare il karaoke insieme.
Nella vita mi è capitato spesso di chiedermi: “Che cosa sarebbe successo se…”. Me lo sono domandato tantissime volte per il coma. Che cosa sarebbe successo se non fosse successo? Credo sia una questione di indole, di carattere, sono abituato ad analizzare tanti piccoli aspetti del quotidiano. Spesso mi domando che cosa sarebbe successo se Marianna non mi avesse detto: «Hai una voce bellissima, Luca. Non smettere mai di cantare, per favore». E se mio fratello Domenico non avesse deciso di dedicarmi il suo tempo, per accompagnarmi ai provini, mollando tutto, dicendo: «Io ti seguo. Dove vorrai andare, io sarò al tuo fianco». È sempre stato il mio punto di riferimento in casa. Il mio fratello preferito, senza che gli altri si dovessero offendere. C’era un rapporto speciale e so di dovergli molto. Quello che non so è come sia possibile che due fratelli che si amano così tanto possano arrivare a non parlarsi e a non cercarsi per qualche tempo. Do la colpa all’orgoglio, di entrambi. Al non sapersi dire le cose in faccia senza paura di ferirsi. È la persona che forse mi ha aiutato di più e ogni tanto vorrei selezionare il suo nome dalla rubrica solo per dire: «Ehi, Domenico, sono ancora qui. Lo stesso di prima». Ma non lo faccio.
Ero con lui quando ho rischiato di morire.
![]()
Venivo da un paio di giorni di febbre. Ero a casa, in salotto. Stavo giocando con il Nintendo, dovevo stare a riposo. Adoravo i giorni di convalescenza in cui nessuno mi diceva di staccarmi dalla tv o dai videogiochi. Potevo starci appiccicato tutto il giorno, dovevo solo riposare. Domenico era vicino alla porta. Si accorse che stavo scrivendo sullo schermo a zig-zag, senza riuscire a inserire i caratteri corretti, ma non ci badò. Perché mai avrebbe dovuto preoccuparsene? Uscì per un attimo dalla stanza e quando rientrò mi trovò accasciato, con il volto completamente viola. Stavo avendo una crisi epilettica. Chiamò mamma, urlò, terrorizzato. Credo che a salvarmi sia stata la prontezza di riflessi di mia madre. Respirazione bocca a bocca, mi tirò fuori la lingua per impedirmi di soffocare, mentre Domenico chiamava l’ambulanza. All’ospedale di Castellamare furono sbrigativi: «Stia tranquilla, signora Marzano, non si deve preoccupare. Sono cose che capitano, suo figlio starà benissimo. È una situazione recuperabile». Ma mia madre non li ascoltò. Si mise a sbraitare, chiese maggiori attenzioni. Aveva fatto per anni le pulizie nei centri medici, aveva acquisito una certa metodologia diagnostica, sapeva che quello che avrebbero dovuto fare per accertarsi delle mie condizioni non era stato fatto. Minacciò tutti, il primario, l’inserviente, tanto che una dottoressa del reparto si prese a cuore la situazione e mi fece trasferire a Napoli d’urgenza. Ed è lì che mi colpì una seconda crisi epilettica, molto più violenta della prima. Tac, encefalogramma, esami su esami: scoprirono che avevo un virus al cervelletto. Nessuno ha mai saputo spiegare come lo avessi preso, come fosse arrivato. La sentenza fu implacabile, violenta, durissima: «Guardi, signora, non sappiamo se suo figlio si sveglierà. Ma se anche dovesse farlo, sarà un vegetale o riporterà gravi handicap, non potrà più muoversi. Faremo altri accertamenti. Ma dovete prepararvi».
Prepararsi a cosa? A vedere morire un figlio di sette anni? A decidere di staccare le macchine che mi stavano tenendo in vita, alimentandomi?
«Prendetevi il tempo che vi serve per decidere, ma sappiate che non ne resta molto.» Me li immagino abbracciati, mamma e papà, li vedo piangere. Sento la disperazione. Sono certo sia stato un incubo. Non lo so davvero che cos’hanno provato, ma faccio fatica a immedesimarmi perché se ci penso mi fa molto male.
Dovevano decidere di me, staccare la spina o aspettare magari per sempre. Non si può prendere una decisione del genere, come si fa? Mia madre si affidò alla sua fede e a Gesù Bambino di Praga, a cui è molto devota. Pregò tutte le sue preghiere, chiese un miracolo, sentendosi completamente persa. Doveva decidere che cosa fare, ma non poteva farlo.
Mi restarono tutti vicino. I miei fratelli mi venivano a trovare, mi stringevano le mani, mi parlavano. Mamma e papà si alternavano per stare al mio fianco e non lasciarmi mai solo. Ma sembrava davvero persa ogni speranza.
Mia sorella Marianna provò anche a registrare le voci dei miei compagni di classe, dei miei amici per farmele ascoltare, insieme alle mie canzoni preferite. Iniziarono a uscirmi lacrime dagli occhi chiusi. I medici parlarono di svuotamento delle sacche lacrimali causato dal coma – perché quando tieni gli occhi chiusi per troppo tempo, gli occhi si svuotano –, ma io preferisco pensare che mi fossi emozionato e stessi piangendo davvero. D’altronde piangevano tutti, perché io non avrei dovuto? Arrivata al sesto giorno, mia madre, continuando a pregare, scese a fumare una sigaretta nel cortile dell’ospedale. Le si avvicinò una donna. Non l’aveva mai vista prima, non la conosceva. Le disse: «Tuo figlio Luca si sveglia, io sono qui per lui». Mia madre sgranò gli occhi. Come faceva a sapere di suo figlio? E come si permetteva di parlare così?
«Sono qui per pregare per chi ha bisogno. Una volta all’anno, quando sento che c’è qualcuno che necessita del mio aiuto, sento di dover venire qui all’ospedale.»
Mia madre era sotto shock, aveva anche un po’ paura. «Io… io non ti conosco.»
«Mi chiamo Silvia» disse quella strana signora.
Mia madre ancora oggi, dopo anni, non sa chi fosse quella donna e che cosa sia successo davvero in quei minuti in cui rimasero a parlare e lei si ritrovò a confidarle i suoi pensieri e le sue paure più intime come se la conoscesse da sempre. «Quanti figli hai?» le chiese.
E Silvia rispose cinque, mostrandole le foto nel portafoglio di cinque Gesù Bambino di età diverse, come fossero i suoi bambini. «Anna, devi stare tranquilla ora. Luca si sveglia.» Non l’ha mai più incontrata da allora.
So benissimo quanto un racconto del genere possa far sorridere gli scettici. E nessuno di noi sa se i miracoli esistono davvero. Ma ero dato per spacciato e invece il giorno dopo mi sono svegliato.
«Ce l’abbiamo fatta» disse il medico con un sorriso che mescolava gioia a incredulità. Sembrò impossibile anche a lui.
«Sembra un miracolo» disse qualcuno. E mia madre era certa lo fosse.
Mia madre crede nei miracoli. E da quel giorno forse anche io.
Ho rischiato di andarmene e invece sono ancora qua. Il bracciale di Gesù Bambino che non tolgo mai dal polso è il mio monito, per non dimenticarlo mai. Per continuare a credere.
![]()
AMA OGNI GIORNO. VIVI OGNI GIORNO.
SII GENTILE.
DATTI LA POSSIBILITÀ DI CREDERE A QUALCOSA DI PIÙ GRANDE DI TE.
E ANCHE QUANDO SENTI DI NON AVERE PIÙ SPERANZA, CONTINUA A CREDERE CHE LE COSE POSSANO CAMBIARE.
ABBI FEDE.
NON SEI MAI DA SOLO.
![]()
Sono nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre del 2000. Tutta la mia infanzia, prima e dopo il coma, si è svolta a Santa Maria la Carità, un piccolo paesino nella provincia di Napoli. Casa mia si trova nella frazione di Petraro, la vedi all’incrocio che divide la città da Castellammare di Stabia. È un quartiere abbandonato, non viene ristrutturato né controllato come dovrebbe, ma c’è tutto quello che serve per le prime necessità: una macelleria, la pizzeria, il negozietto di vestiti.
Nel palazzo giallino, quasi bianco, senza cortile, con le pareti scrostate perché nella periferia della periferia l’estetica non è mai stata una priorità, ha sempre vissuto la mia famiglia. Quando ti avvicini noti il parrucchiere, ma non ti viene tanta voglia di tagliarti i capelli lì…
Se entri nel vicoletto chiuso che conduce al portone e sali al primo piano, trovi noi. Una casa di centosessanta metri quadrati, due bagni, tre camere, la cucina insieme al salotto, un corridoio.
Da piccolo salivo i gradini di corsa anche quattro alla volta, per rientrare in casa. Ero sempre in ritardo, a giocare per strada fino all’ultimo, tra i richiami di mia madre, con la cena già servita in tavola, oppure chiuso in camera, tra i peluche del Napoli, perso tra le mie cose. Riuscivo a farmi trovare già seduto al mio posto solo quando c’era il ragù. Lo adoravo, il mio piatto preferito.
Il mio paese ha 11.800 abitanti, in mezzo ai quali sono cresciuto. I miei amici li ho trovati lì, in quella periferia che ti obbliga a tirare fuori qualcosa se non vuoi finire male. Ho tanti amici finiti male. In quelle strade senza spazi di ritrovo per i ragazzi ho preso le mie prime lezioni di musica, ho frequentato il coro, sono andato a scuola. La scuola elementare era dietro casa. Ci andavo a piedi anche da solo e arrivavo regolarmente in ritardo. Così vicino da rimandare sempre tutto all’ultimo e prendermi le sgridate della maestra, senza che mi toccassero poi più di tanto. Il mattino dopo ci provavo, cercavo di arrivare prima del suono della campanella. Ma poi era più forte di me. Mi alzavo presto, non era un problema di sonno. Avevo davanti a me, in teoria, tutto il tempo necessario per lavarmi e vestirmi, senza dover correre. Ma ero lentissimo, e quindi quel tempo non bastava mai. Mi perdevo a fissare la tazza piena di latte inzuppando biscotti alla panna e giocando con la cannuccia di plastica, di quelle che oggi non esistono più. Un biscotto, lo sguardo perso contro il muro della cucina oppure sul divano in salotto davanti alla tv. Fratelli e sorelle in movimento per casa, chi in ritardo, chi in anticipo, tutti a occupare il ba...