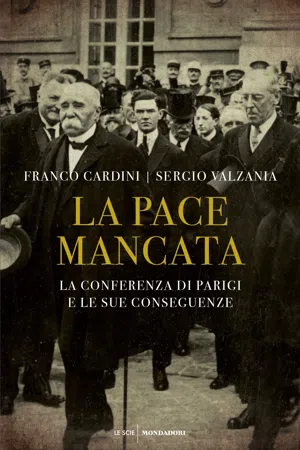La pace con i vinti
Come abbiamo visto, formalmente la Conferenza di pace di Parigi durò un anno esatto, dal gennaio 1919 al gennaio 1920. La prima evidenza che si ricava da queste date concerne il fatto che solo una parte delle questioni in essere alla fine della Grande guerra venne affrontata e risolta nel corso delle trattative che si svolsero nella capitale francese in quei dodici mesi. Al momento della chiusura della Conferenza neppure i combattimenti erano terminati in buona parte del continente e in Asia. L’attività diplomatica legata alla stipula di accordi finalizzati a risolvere importanti questioni create dalla guerra continuò dopo la cerimonia di chiusura dell’assise parigina.
I trattati di pace fra i vincitori e tre degli sconfitti, Germania, Austria e Bulgaria, furono firmati rispettivamente il 28 giugno, il 10 settembre e il 27 novembre 1919, ma quello con l’Ungheria e quello con il governo sultaniale furono sottoscritti dopo la conclusione ufficiale dei lavori: il 4 giugno 1920 al Trianon e il 10 agosto dello stesso anno a Sèvres. Come già detto, in questo secondo caso si scoprì presto che l’interlocutore individuato per la stipula era sbagliato, dato che il nuovo Stato turco che si andava formando in Anatolia non riconosceva il sultano ottomano come proprio sovrano e rappresentante politico.
In questo contesto bisogna sottolineare, fra le gravi incongruenze imposte o accettate dai vincitori, che la Cecoslovacchia, a differenza dell’Ungheria, riuscì a farsi considerare Stato di nuova costituzione, la cui popolazione era stata vessata dall’organizzazione politica precedente il conflitto, pur avendo costituito all’inizio della guerra parte integrante dei territori appartenenti all’impero asburgico, i cui abitanti avevano combattuto lealmente a sostegno degli imperi centrali fino al termine del conflitto. Questo fu possibile grazie alla proclamazione d’indipendenza effettuata, a guerra in pratica terminata, il 28 ottobre 1918 a Praga, peraltro una delle tradizionali capitali dell’impero asburgico. Sorte analoga ebbero i croati e anche gli italiani di Trento e Trieste, di Gorizia e dell’intera Istria, come i tirolesi di Bolzano, che si trovarono dalla parte dei vincitori a seguito dello spostamento dei confini, pur avendo partecipato alla guerra schierati dalla parte degli sconfitti. Tutti loro furono esonerati dal pagamento dei danni di guerra, che aumentarono in proporzione a carico di quanti rimasero tedeschi, austriaci e ungheresi.
L’ignoranza della complessità della geopolitica europea da parte di Woodrow Wilson e il rabbioso desiderio di vendetta di quanti avevano pagato la vittoria a un prezzo molto elevato crearono in Europa discriminazioni e ingiustizie assurde. Lo spostamento di un confine divaricava destini che si erano sviluppati in parallelo per secoli.
Anche i protagonisti degli accordi di pace che vennero stipulati prima a Parigi e poi in altre località negli anni successivi andarono cambiando via via che il tempo trascorreva, seppure non si giunse alla situazione paradossale che si era creata in Vestfalia nel 1648. In quella circostanza, al momento della firma della pace che pose fine alla Guerra dei Trent’anni, erano ormai scomparsi quelli che avevano iniziato le trattative nel 1643.
Con l’eccezione di Woodrow Wilson, i politici che rappresentarono le quattro grandi potenze vincitrici alla Conferenza di Parigi vissero a lungo, ma la loro carriera politica ebbe presto termine. La personalità politicamente più longeva fu il primo ministro britannico David Lloyd George: lasciò la carica il 19 ottobre 1922, vedremo in seguito in quali circostanze. L’11 luglio 1921 aveva compiuto il suo capolavoro politico stipulando l’accordo di tregua che pose fine alla guerra insurrezionale in corso in Irlanda concedendo l’indipendenza al nuovo Stato dell’EIRE, anch’esso sorto, per una via parallela, dal crogiuolo della Grande guerra. Si giunse allora alla soluzione di un altro problema che a Parigi era stato ignorato in modo assoluto.
Vittorio Emanuele Orlando si dimise dalla carica di primo ministro italiano il 23 giugno del 1919, pochi giorni prima della firma del trattato di pace con la Germania a Versailles, per essere sostituito da Francesco Saverio Nitti. Al posto di Sidney Sonnino, fra i maggiori responsabili dell’entrata in guerra dell’Italia e ministro degli Esteri per l’intera durata del conflitto, nel nuovo governo ritornò uno dei predecessori, Tommaso Tittoni, che rimase in carica per tre soli giorni per passare quindi alla guida della delegazione italiana alla Conferenza di pace, ruolo che mantenne fino al 25 novembre, quando si dimise a sua volta. Nel frattempo era stato sostituito al ministero prima da un interim di Nitti e poi da Vittorio Scialoja. La situazione interna italiana si andava sempre più deteriorando e sarebbe approdata al primo governo Mussolini il 31 ottobre 1922, a seguito della Marcia su Roma effettuata dai fascisti il 28 ottobre.
Georges Clemenceau, primo ministro francese della vittoria e della Conferenza di Parigi, abbandonò la politica il 18 gennaio 1920, dopo essere stato sconfitto nella corsa alla presidenza della Repubblica francese, alla quale immaginava di giungere in pratica per acclamazione. Riteneva di avere maturato il diritto alla carica per i meriti guadagnati nel corso della guerra e poi della Conferenza di pace e non condusse nessuna campagna per acquisire consensi: nella designazione del candidato del partito repubblicano venne battuto per 408 voti a 389 da Paul Deschanel, che fu eletto al suo posto dall’Assemblea nazionale.
Quanto a Thomas Woodrow Wilson, lasciò la capitale francese la sera stessa della firma del trattato di pace con la Germania e del Covenant, obbiettivo principale che si era proposto a Parigi. Negli Stati Uniti lo attendevano grandi delusioni, dato che il suo operato alla Conferenza di pace non era stato apprezzato dalla maggioranza congressuale. Nessuno dei trattati firmati dal presidente in Europa ottenne la ratifica del Senato degli Stati Uniti, necessaria in base alla Costituzione per gli accordi internazionali, a cominciare dal Covenant istitutivo della Società delle Nazioni, della quale gli USA non fecero mai parte. Nel 1921 gli Stati Uniti stipularono accordi di pace bilaterali con l’Austria, il 24 agosto a Vienna, con la Germania, il 25 agosto a Berlino e con l’Ungheria, il 29 agosto a Budapest. In essi si indicavano esplicitamente gli articoli dei trattati parigini da considerarsi recepiti. Gli altri si intendevano non accettati. Il repubblicano Warren Harding era entrato alla Casa Bianca come ventinovesimo presidente degli Stati Uniti il 4 marzo di quell’anno.
Le elezioni presidenziali si erano tenute alla scadenza naturale nonostante Woodrow Wilson fosse stato colpito il 25 settembre 1919 da un primo e il 2 ottobre da un secondo e più grave ictus che lo resero quasi completamente inabile. La circostanza venne tenuta nascosta dai collaboratori, che continuarono a governare per suo conto, come del resto i biografi sostengono avessero fatto per l’intera durata della presidenza. Erano tempi nei quali i media risultavano meno pervasivi di oggi e l’informazione si dimostrava di conseguenza meno accurata.
La presenza giapponese a Parigi fu meno incisiva, più discreta di quella delle grandi potenze europee e degli Stati Uniti. Il primo ministro nipponico non si recò mai nella capitale francese. Questo consentì ai rappresentanti degli Stati atlantici di procedere a una sorta di riduzione di ruolo, se non proprio di emarginazione, dei delegati del governo di Tokyo attraverso un escamotage formale. Al Giappone era stato riconosciuto lo status di grande potenza, insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Italia, con il conseguente diritto di partecipare alle riunioni ristrette, nel corso delle quali venivano presi gli accordi più importanti. Quasi subito, mentre il livello decisionale di tali riunioni si rivelava essere quello definitivo, trasformandole da occasione di discussione in sede di ratifica, i giapponesi ne vennero estromessi, adducendo a giustificazione il fatto che a capo della delegazione nipponica non ci fosse il primo ministro del paese. Vi si trovava invece la elegante figura del principe Saionji Kinmochi, che era stato ministro degli Esteri e aveva guidato per tre volte il governo nipponico, ma aveva lasciato la carica nel dicembre 1912. Il ruolo politico che ricopriva era sfuggente per gli occidentali. Saionji faceva parte del ceto dirigente che orientava le scelte del governo, fuori dalla mischia degli allineamenti ideologici e di partito caratteristici delle democrazie occidentali.
Giovanissimo, negli anni Settanta dell’Ottocento il principe aveva vissuto e studiato a Parigi. Sarebbe morto a novantun anni, nel 1940, senza sapere dell’attacco di Pearl Harbour agli Stati Uniti e della partecipazione giapponese alla Seconda guerra mondiale. Nella sua vita politica l’esperienza della Conferenza di pace non costituì uno dei capitoli di maggior rilievo.
Qui può risultare utile una brevissima digressione, relativa alla posizione del Giappone nel contesto parigino, dovuta a un insieme di circostanze che andavano dalla distanza fisica e culturale del paese dall’Europa alla marginalità delle dimensioni dell’intervento effettuato nella guerra. Nel corso dell’intero conflitto le forze armate nipponiche avevano dovuto sopportare meno di cinquecento caduti, parecchi dei quali per incidenti. Esisteva inoltre una profonda divergenza rispetto alle altre delegazioni riguardo alla natura degli interessi che il governo di Tokyo intendeva difendere in occasione della Conferenza di pace.
A livello normativo e di affermazioni di principio la maggior preoccupazione nipponica era rivolta alla conquista di una pari dignità razziale per i propri cittadini, discriminati fuori dall’Asia e limitati nelle opportunità di emigrazione in tutti i paesi anglofoni, dagli Stati Uniti al Canada, al Sudafrica, alla Nuova Zelanda e all’Australia. Sul piano territoriale, individuato come secondario, il Giappone intendeva vedere riconosciuta l’appropriazione, in buona parte già realizzata, di larga parte dei possedimenti tedeschi in Estremo Oriente: gli arcipelaghi del Pacifico a nord dell’equatore e il protettorato sulla provincia cinese dello Shandong. La Nuova Guinea sarebbe andata all’Australia, le Samoa e Nauru alla Nuova Zelanda alle quali sono rimaste collegate fino a oggi in forme diverse.
Alle richieste giapponesi, avanzate in più occasioni, di inserire un esplicito rifiuto di ogni forma di razzismo nel trattato istitutivo della Società delle Nazioni, Woodrow Wilson non fornì alcun appoggio. Si comportò in questo modo per ragioni che eccedevano la sua scarsa sensibilità personale nei confronti delle tematiche relative all’eguaglianza fra gli esseri umani. Si ricorda che quando entrò in carica come presidente degli Stati Uniti consentì che norme segregazioniste entrassero in vigore nelle istituzioni federali. Non solo una parte considerevole dell’opinione pubblica statunitense, concentrata negli Stati del Sud dell’Unione, era contraria a impegnarsi in una iniziativa di condanna del razzismo. I rappresentanti dei paesi a guida anglosassone di quello che si preparava a divenire il Commonwealth, istituito formalmente nel 1926, erano assolutamente contrari all’inserimento nel Covenant della Società delle Nazioni di una dichiarazione di rigetto delle discriminazioni razziali, da affiancare a quelle relative a differenze economiche e religiose, in qualunque termine venisse formulato.
Ancora l’impero britannico non si era trasformato, ma il Commonwealth non costituito ufficialmente era già funzionante nella prassi diplomatica che riconosceva un potere reale ai rappresentanti dei governi periferici. Questo avveniva proprio a seguito del contributo fornito alla vittoria alleata nel corso della Grande guerra dai possedimenti britannici, con in testa Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia. Le loro legislazioni razziste sarebbero sopravvissute ben oltre la Seconda guerra mondiale. Per ricostruire la mentalità corrente all’epoca della Conferenza parigina è utile ricordare che la questione del genere non venne posta in nessuna occasione: la partecipazione delle donne alla vita politica costituiva ancora un’eccezione dovuta a eventi dinastici.
Riguardo alla condanna delle discriminazioni razziali, Woodrow Wilson accolse in toto le richieste di escluderla dal Covenant formulate dagli alleati anglosassoni pur di ottenere la loro adesione al progetto di costituzione della Società delle Nazioni. A giudizio di alcuni studiosi la posizione assunta in quella circostanza dal presidente, con le ricadute che essa ebbe nelle politiche migratorie del sovraffollato paese del Sol Levante, costituì un passaggio importante nel processo di allontanamento del Giappone dagli Stati Uniti, a cui fino ad allora il paese aveva guardato come a un modello, che nel 1941 sarebbe sfociato nella Guerra del Pacifico. Senza possibili sbocchi migratori in direzione degli Stati Uniti, dove ai pochi orientali ammessi era proibito per legge sposare donne bianche, e dell’Australia, nella quale era loro inibita ogni forma di accesso, l’unica possibilità per i giapponesi era costituita dalla Cina, verso la quale Tokyo indirizzò una politica imperialistica sempre più aggressiva.
La compensazione concessa al Giappone per il rifiuto di far assumere alla Società delle Nazioni un atteggiamento antirazzista fin dal momento dell’istituzione fu la cessione della penisola cinese dello Shandong, già protettorato tedesco, con oltre cinque milioni di abitanti, contro ogni rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. In questo modo brutale si indicava al Giappone una via di espansione in Asia che sarebbe stata percorsa con ferocia determinata, producendo tra l’altro un grave deterioramento nella politica interna nipponica. Il contemporaneo rifiuto opposto dal presidente americano alla attribuzione di Fiume, cittadina di cinquantamila abitanti con popolazione mista italo-slovena, all’Italia, produsse la motivata impressione di una politica wilsoniana priva di coerenza di fondo e pronta a ogni sorta di accomodamento.
Lo spettro più inquietante fra quanti si aggiravano nei saloni e negli uffici parigini nel 1919 era quello della Russia, che si stava indirizzando verso la trasformazione in Unione Sovietica. La gestazione della Rivoluzione d’Ottobre era stata lunga. La sconfitta nella guerra russo-giapponese del 1904-05, e la successiva rivoluzione avevano minato il prestigio dello zar Nicola II, che aveva immaginato di recuperare autorità sul piano interno attraverso una vigorosa politica espansionista sviluppata a occidente, verso i Balcani e le popolazioni di religione ortodossa che li abitavano. Esse erano ancora in parte sottoposte al potere sultaniale, musulmano, o a quello asburgico, cattolico, con i quali il rinnovato attivismo zarista entrava di necessità in contrasto.
Tale attivismo stimolò i nazionalismi greco, serbo, bulgaro e rumeno, divenendo una delle cause scatenanti delle guerre balcaniche del 1912-13 e provocando direttamente lo scoppio della Prima guerra mondiale. Il suo inizio può essere fatto coincidere con la decisione dello zar di ordinare la mobilitazione dell’esercito russo il 29 luglio 1914, in risposta alla dichiarazione di guerra austro-ungarica alla Serbia. Essa era stata concepita da Vienna come operazione locale, mirata a ridimensionare le ambizioni espansionistiche di uno Stato uscito dalle guerre balcaniche più che raddoppiato nel territorio e nella popolazione. L’intervento dello zar causò a catena la mobilitazione di tutti gli altri eserciti europei e quindi l’allargamento delle ostilità all’intero continente: un conflitto immaginato come circoscritto assunse allora la dimensione di un confronto fra le maggiori potenze mondiali.
La lunga serie di rovesci subiti dalle truppe russe nel corso della guerra costrinse infine Nicola II all’abdicazione, il 15 marzo 1917. Risulta utile ricordare che la dichiarazione di guerra statunitense alla Germania è del 6 aprile dello stesso anno, successiva di appena tre settimane alla crisi avvenuta a Pietrogrado. Come detto, la capitale russa era stata ribattezzata così dopo lo scoppio delle ostilità per togliere dal nome originale, San Pietroburgo, la forma tedesca del suffisso. Dalla caduta dello zar in avanti, le diplomazie alleate prodigarono i loro sforzi nell’obbiettivo di impedire a ogni costo l’uscita della Russia dalla guerra. Per ottenere questo risultato non esitarono a ricorrere a qualsiasi mezzo, compresi il ricatto e la corruzione dei membri del governo in carica. Il sostanziale successo dell’attività alleata distrusse ogni credibilità dei governi democratici succeduti allo zar e in particolare di quello presieduto a partire dal 21 luglio 1917 da Aleksandr Kerenskij. Su sollecitazione anglo-francese, nelle vesti di ministro della Guerra del precedente gabinetto, egli aveva lanciato all’inizio del mese una sconsiderata offensiva contro tedeschi e austro-ungarici in Galizia, che si risolse in un grave rovescio e privò Pietrogrado del sostegno dell’esercito. In questo modo si aprì la strada per la salita al potere del piccolo ma determinato partito rivoluzionario bolscevico. Il suo maggior dirigente, Lenin, era stato rimpatriato dai tedeschi dalla Svizzera nell’aprile del 1917, dopo diciassette anni di esilio, proprio con l’intento di fomentare disordini in un paese nemico.
Il discredito del governo Kerenskij era tale da lasciare spazio per una serie continua di tentativi insurrezionali da parte dei bolscevichi. Al quarto, effettuato nella notte fra il 6 e il 7 novembre 1917, il colpo di Stato ebbe infine successo. Prese il nome di Rivoluzione d’Ottobre dato che il calendario giuliano, ancora in uso nella Russia ortodossa, indicava la data del 24-25 di quel mese. L’intelligenza politica di Lenin gli fece comprendere la necessità della pace, a qualunque condizione. Essa venne firmata il 3 marzo dell’anno successivo a Brest-Litovsk, in Bielorussia: veniva così posto termine alla guerra fra Russia e imperi centrali. I conflitti contro Polonia e Lituania sarebbero ripresi dopo l’armistizio del novembre 1918.
Si continuò intanto a combattere dentro la Russia, fra Armata Rossa e generali bianchi, con l’intervento di contingenti inviati dalle potenze alleate con le scuse più diverse, di solito a sostegno dei secondi. Inoltre numerosi reparti composti da ex prigionieri di guerra, ancora inquadrati militarmente e riequipaggiati, provenienti soprattutto da territori dell’impero austro-ungarico e composti da cechi, polacchi e trentini, cercavano di aprirsi con le armi la via del rientro in patria.
Come sarebbe accaduto di nuovo nel 1989, il collasso del potere centrale in Russia produsse la separazione di numerose realtà periferiche, che proclamarono l’indipendenza, primi fra tutti i paesi baltici. La definizione dei nuovi confini venne effettuata attraverso prove di forza, anche molto violente, come la guerra russo-polacca, decisa dalla battaglia combattuta dal 13 al 25 agosto 1920 alle porte di Varsavia, definita dai polacchi «Miracolo della Vistola» per le dimensioni del successo conseguito in condizioni disperate. Un ruolo significativo nella regione baltica venne svolto dai Freikorps, unità paramilitari composte da soldati tedeschi smobilitati inquadrati in nuove formazioni combattenti che si opposero all’Armata Rossa. In seguito questi reparti intervennero nella repressione dei moti filosovietici in Germania, a Monaco e Berlino.
La situazione politica della regione baltica si stabilizzò solo nell’ottobre del 1921, con il trattato di Riga, attraverso il quale vennero fissati i confini nordoccidentali della Russia e degli Stati confinanti. Nell’autunno del 1939 l’Unione Sovietica di Stalin riconquistò alla ...