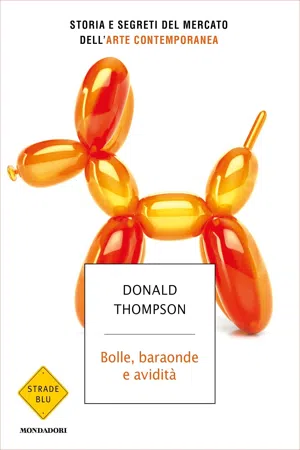La fascia più esclusiva del mercato dell’arte contemporanea, così solida e rassicurante, sembrerebbe essere il posto in cui le controversie si risolvono velocemente e senza strepiti, davanti a un buon bicchiere di vino e con la garanzia di assoluta discrezione, soprattutto mediatica. Non va sempre così. Alcuni conflitti vengono risolti attraverso costose cause di dominio pubblico. Arrotondando per difetto, soltanto nella città di New York almeno sessanta avvocati e civilisti sono sempre impegnati in cause legate al settore artistico, che riguardano transazioni, controversie, questioni di tasse, o la ricerca di status legali e culturali. Se sessanta avvocati fatturano con i loro team più di un milione di dollari ciascuno ogni anno, l’ammontare delle spese totali sostenute in una sola città per dibattere cause e risolvere vertenze supera il valore delle vendite annuali d’arte effettuate in Canada.
Questo capitolo si concentra su due transazioni e due battaglie legali e racconta dei differenti standard che si applicano in quell’universo parallelo che è il mercato dell’arte contemporanea. Entrambe le battaglie hanno coinvolto gli stessi protagonisti: il collezionista newyorkese Ronald Perelman e il mercante d’arte Larry Gagosian. Ciascun caso offriva visioni divergenti del mercato dell’arte da parte di personaggi abbastanza facoltosi da indire azioni giudiziarie e abbastanza famosi da attrarre l’attenzione dei media. I risultati delle due dispute hanno confermato esattamente ciò che il mondo dell’arte contemporanea si aspettava.
Una precisazione: per un breve periodo ho lavorato come consulente di uno dei protagonisti in uno dei due casi. Le informazioni derivano esclusivamente dalle dichiarazioni pubbliche delle parti, dai fascicoli, dalle deliberazioni della corte e dai commenti dei media.
Ronald Perelman è amministratore delegato e unico proprietario della holding MacAndrews & Forbes, che annovera tra le aziende del suo portafoglio Revlon, Flavors e Scientific Games. Nel 2014 Perelman occupava il cinquantaquattresimo posto della classifica di Bloomberg delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio netto stimato di 15,2 miliardi di dollari. Perelman colleziona opere d’arte. Secondo il «New York Times», la sua collezione vale più di un miliardo di dollari e include opere di Andy Warhol, Cy Twombly e Roy Lichtenstein. Alcune di queste decorano il suo ufficio, altre sono appese alle pareti della sua residenza di Manhattan e della proprietà di East Hampton, altre ancora si trovano sul suo yacht di quasi ottanta metri.
Benché io (e gran parte dei media) identifichi Perelman come l’acquirente di opere d’arte coinvolto nelle transazioni descritte qui di seguito, l’effettivo compratore è stato MAFG Art Fund, una società a responsabilità limitata utilizzata dal gruppo societario MacAndrews per investire e commerciare nel settore artistico. Il fondo ha un curatore, e il fondo e Perelman sono tra i protagonisti del mondo dell’arte a livelli molto alti.
Nel 2012 e poi nel 2014 Perelman dichiarò di voler rivelare quello che lui definiva il lato «sporco» del comprare e vendere arte di fascia alta, e che lo avrebbe fatto portando in tribunale il suo gallerista di fiducia, Larry Gagosian. Nella prima causa, risalente al settembre 2012 – che mi piace chiamare «causa Popeye» –, Perelman accusava Gagosian di aver nascosto informazioni essenziali e manipolato i prezzi in riferimento all’acquisto della scultura in granito Popeye di Jeff Koons (si tratta di un’altra versione del pezzo esposto nella retrospettiva al Whitney). Più avanti, nella «causa Paphos», Perelman accusò Gagosian di averlo truffato in uno scambio di dipinti.
Nel primo procedimento Perelman raccontò che lui e Gagosian erano stati amici e compagni d’affari per molti anni. Avevano frequentato le rispettive case, partecipato agli stessi eventi sociali e investito insieme nel ristorante Blue Parrot a East Hampton, nell’area metropolitana di New York. Perelman dichiarò che Gagosian era stato per lui un consulente d’arte e un mentore: nell’arco di più di trent’anni aveva acquistato o venduto duecento opere d’arte tramite il gallerista, e ne aveva trattate sul mercato cinquanta in «operazioni di scambio». Disse che aveva riposto completa fiducia in Gagosian per via del loro rapporto duraturo, «della sua incomparabile conoscenza del mondo dell’arte e della posizione prominente che rivestiva nel settore».1 Il valore delle commissioni incassate con quel volume di transazioni suggerisce che qualsiasi intermediario dovrebbe farsi in quattro per tenersi stretta la benevolenza del proprio cliente.
Larry Gagosian, l’amico di lunga data, è il principale mercante d’arte al mondo per influenza, numero di gallerie e vendite annuali. Possiede spazi espositivi a New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Roma, Ginevra, Atene e Hong Kong. Rappresenta settantaquattro artisti e «lavora con» ulteriori ventinove (ciò vuol dire che li condivide con altri mercanti d’arte). Le sue gallerie hanno un volume di vendite annue attestato attorno a 1,1 miliardi di dollari, tre milioni per ogni giorno lavorativo. Risponde di circa il 2 per cento del mercato internazionale dedicato all’arte contemporanea e del 10 per cento di quello di fascia alta.
Centrale nelle posizioni assunte da Perelman nella «causa Popeye» è il presupposto che il brand Gagosian associato a quello di un artista induca un costante aumento dei prezzi. A parte questo, non è chiaro che forme potrebbe assumere il potere di Gagosian quando vi è in ballo un collezionista esperto e facoltoso come Perelman. Per un mercante, il potere consiste nella capacità di ignorare un collezionista desideroso di comprare un’opera, oppure nell’inserirlo in fondo a una lista d’attesa per l’acquisto dell’opera di un artista molto conteso. Nessuna delle due opzioni ha qualche probabilità di essere applicata quando si ha a che fare con un collezionista del calibro di Perelman.
Nella prima denuncia, risalente al maggio 2010, Perelman sosteneva che il suo fondo si era impegnato a pagare quattro milioni di dollari a Gagosian (in cinque rate da ottocentomila dollari) per la scultura di granito di Koons. Questa doveva essere creata in tre versioni, e Perelman si sarebbe aggiudicato la numero due. La data di consegna stimata – ma non garantita – era dicembre 2011. Come tutte le sculture recenti di Koons, anche questa era stata venduta prima dell’effettiva realizzazione. L’artista aveva conferito a Gagosian il diritto di vendita della versione numero uno e alla Sonnabend Gallery di New York quello della numero due. Il nome dell’intermediario per la versione numero tre non era stato reso noto: forse era un agente.
Fu poi rivelato che, al tempo del contratto di acquisto con Perelman, Gagosian aveva già venduto la versione assegnatagli da Koons e che due settimane e mezzo dopo aveva acquistato la versione destinata a Sonnabend. I termini di pagamento della vendita a Gagosian furono resi pubblici nei fascicoli giudiziari, ed erano identici a quelli contenuti nell’accordo tra Perelman e Gagosian: quattro milioni di dollari da pagare in cinque rate da ottocentomila dollari.
Nel gennaio 2012, otto mesi dopo il contratto di vendita di Popeye, Gagosian rivelò a Perelman un nuovo dettaglio del suo accordo con Koons. Il mercante aveva pattuito di rimborsare all’artista il 70 per cento del profitto proveniente da un’eventuale rivendita della scultura a terzi, se tale rivendita fosse avvenuta a un prezzo superiore rispetto a quello originale. La clausola aveva una validità di due anni dalla firma del contratto con Koons. Per ulteriori cinque anni nel caso di una rivendita da parte di Gagosian a Koons, doveva essere versato il 50 per cento del profitto.
Anche il contratto di acquisto con Sonnabend includeva la condizione del rimborso del 70 per cento sulla rivendita, una clausola vincolante per Gagosian. L’accordo con la galleria autorizzava inoltre Koons a modificare la data di completamento della scultura «per motivi imputabili a ritardi di produzione o altre ragioni».
Perelman afferma che, quando venne a sapere che Koons non avrebbe rispettato la data di consegna prevista, decise di scambiare la scultura con un dipinto. Sostenne che, una volta completata l’opera, il valore di Popeye sarebbe stato come minimo di dodici milioni di dollari. Questa stima si scoprì essere inferiore almeno del 50 per cento. Perelman chiese a Gagosian un credito tra i quattro e i dodici milioni di dollari in cambio della scultura a cui rinunciava, a copertura del periodo in cui ne era stato proprietario. Per farla breve, Perelman voleva speculare sulla scultura per trarne un profitto nel periodo in cui Koons ci stava ancora lavorando.
Gagosian rispose a Perelman che non era molto conveniente per lui fare un passo indietro circa i diritti di Popeye fintanto che il contratto sulla spartizione dei profitti fosse rimasto in vigore. Il collezionista ribatté che Gagosian sapeva che lui trattava le opere d’arte come forme di investimento, e si sarebbe dovuto aspettare questo tentativo di speculazione. Aggiunse inoltre che Gagosian era la fonte favorita per il reperimento delle opere di Koons, che le vendite tramite altri canali portavano a prezzi più bassi e che gli accordi sulle provvigioni gli impedivano (a Perelman) di ottenere il miglior prezzo possibile sulla rivendita.
Dichiarò inoltre che Gagosian aveva utilizzato la formula della ripartizione degli utili per giustificare un valore di permuta per Popeye di «soli» 4,25 milioni di dollari. Il gallerista rivendette l’opzione a un ignoto acquirente per 4,5 milioni di dollari, ne versò 4,25 a Perelman e presumibilmente inoltrò a Koons trecentocinquantamila dollari (cioè il 70 per cento di profitto su mezzo milione) o centosettantacinquemila dollari (il 70 per cento di duecentocinquantamila).
Barbara Kapnick, giudice della Corte suprema di New York, deliberò che mentre Perelman poteva anche aver ipotizzato la rivendita di Popeye, niente nella vendita originale lasciava presagire la necessità di un possibile coinvolgimento di Gagosian. «In sostanza, l’azione da parte del querelante per inadempimento contrattuale afferma che “con il senno di poi, [egli] sembra essere incappato in un cattivo affare”» concluse Kapnick.2
La battaglia legale più pubblicizzata fu però la seconda, avente per oggetto un dipinto azzurro di Cy Twombly, Leaving Paphos Ringed with Waves (1) (2009). Secondo i fascicoli dei processi, questo capitolo della saga ebbe inizio nell’aprile 2011, quando Perelman si recò nella galleria di Gagosian di Madison Avenue e chiese informazioni sull’opera. Il gallerista rispose che era disponibile per otto milioni di dollari. Di solito, la prima offerta a un cliente storico è soggetta a negoziazione, quindi Perelman ribatté proponendo sei milioni.
Una settimana dopo Perelman fece un’offerta più alta. Il mercante rispose che il dipinto era stato venduto, ma non indicò né l’acquirente né il prezzo. Aggiunse che, se Perelman voleva l’opera, questa sarebbe stata disponibile per 11,5 milioni di dollari. Quattro mesi dopo Perelman offrì 10,5 milioni. Dopo aver ottenuto il via libera dal nuovo proprietario, Gagosian accettò.
Si scoprì poi che gli acquirenti erano stati i Mugrabi, una famiglia di collezionisti e intermediari privati di New York con un imponente giro d’affari. Avevano acquistato l’opera attraverso una società con sede alle Isole Cayman. Pare che lo avessero ottenuto per 7,25 milioni di dollari, da pagare in parte in contanti e in parte rinunciando alla loro quota di opere d’arte in comproprietà con Gagosian. Il prezzo pagato da Perelman rivelava che i Mugrabi e Gagosian si erano spartiti 3,25 milioni di dollari tra utili e commissioni.
Perelman sostenne che la vendita ai Mugrabi era stata una montatura, volta a far lievitare il prezzo: «Il prezzo schizzato alle stelle, il fulmineo susseguirsi degli eventi e la mancanza della tradizionale fattura di vendita, tutto sembra sollevare dubbi sulla correttezza e la buona fede della transazione».3 Gli avvocati di Gagosian replicarono che l’acquisto dei Mugrabi era stata una «libera transazione»4 peraltro testimoniata da fatture e documenti. Perelman aggiunse che Gagosian aveva dichiarato che il prezzo di 11,5 milioni di dollari era giustificato dalle vendite recenti, ma non aveva fornito alcun dato di mercato.
Gli avvocati di Perelman citarono in giudizio Gagosian e i tre rappresentanti della famiglia Mugrabi, Jose, David e Alberto. Tutti fecero la loro deposizione. Gli avvocati citarono in giudizio anche le case d’aste Sotheby’s, Christie’s e Phillips, ma nessuno dei loro rappresentanti fu interpellato. Gli investigatori dello studio legale di Perelman interrogarono altri mercanti d’arte e alcuni degli artisti trattati da Gagosian. Il «New York Times» stimò che Perelman avesse speso tre milioni di dollari tra avvocati e indagini.
A prescindere da quale parte stessero – se con Perelman, Gagosian o nessuno dei due – molti mercanti, collezionisti e media del settore furono incuriositi dai procedimenti legali. Alcuni speravano che, se i fascicoli fossero stati resi pubblici, avrebbero fornito informazioni su contratti e condizioni che caratterizzano la fascia alta del mercato.
Inoltre, chi seguiva il caso sperava anche che si sarebbe chiarito fino a che punto il presupposto giuridico del dovere di buona fede venga davvero applicato ai contratti per le opere d’arte più prestigiose. Ma questo non fu mai chiarito. Buona fede vuol dire che nessun contraente intraprende azioni volte a danneggiare i benefici della controparte, garantiti dal contratto: per esempio, la sottoscrizione di un contratto tra Gagosian e Sonnabend che potrebbe limitare il prezzo di rivendita di Perelman. Il tribunale che deliberò su Leaving Paphos Ringed with Waves (1) si occupò solo dell’ipotesi di frode. Non fu reso pubblico nessun documento confidenziale.
Nel febbraio 2013 Barbara Kapnick fece cadere cinque delle sei accuse del caso, incluse le pratiche economiche ingannevoli e la violazione dell’obbligo fiduciario, sostenendo che Perelman aveva più di vent’anni di esperienza negli investimenti in arte: i suoi consulenti erano «uomini d’affari navigati che avevano siglato libere transazioni negoziate». Con questi precedenti, la loro «pretesa soggettiva» di affidarsi alla competenza di Gagosian non faceva sussistere un rapporto di fiducia.5
Kapnick consentì che venisse portata avanti una sola richiesta di risarcimento, relativa al fatto che Gagosian avesse alterato il valore delle opere vendute a Perelman. La giudice sostenne che l’affermazione che il mercante e la sua galleria avevano una conoscenza «superiore e unica» del mondo dell’arte era sufficiente per far passare in tribunale la denuncia di frode.
Nel dicembre 2014 una corte d’appello composta da cinque giudici fece cadere anche l’ipotesi della frode e precluse qualsiasi processo. La sentenza stabiliva che le parti avevano negoziato liberamente e non avevano reciproci obblighi fiduciari. Ma, più importante per le future transazioni in ambito artistico, il giudice associato David Friedman scrisse nella sentenza: «Ai sensi delle leggi applicabili, questi sofisticati querelanti non possono dimostrare di essere ragionevolmente affidabili perché non hanno agito con la dovuta due diligence. Non hanno chiesto ai convenuti: “Fateci vedere i vostri dati relativi al mercato dell’arte”».6 MAFG Art Fund presentò domanda di ricorso presso la più alta corte di New York per appellarsi a quella sentenza. Nel marzo 2015 la mozione per consentire l’appello fu negata senza spiegazioni, affermando che la corte non trovava errori nella decisione del giudice Friedman.
L’esito del «caso Paphos» è applicabile sia alle vendite d’arte a prezzi medi sia alle cifre di Gagosian. A quanto pare, un mercante d’arte non può essere ritenuto colpevole per una dichiarazione sul valore di un’opera d’arte, indipendentemente dalla sua mancanza di accuratezza, fino a quando sussiste la due diligence. Per gran parte degli artisti, le informazioni relative ai prezzi possono essere dedotte dalle vendite precedenti, online oppure dall...