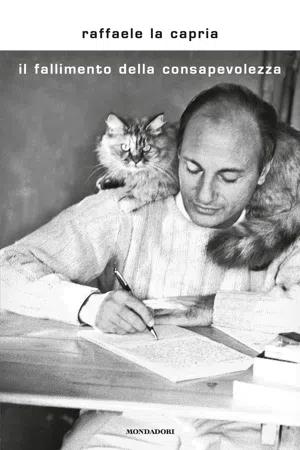Io sono nato nel 1922 a Napoli, in una città che ha molti volti e che recita sé stessa; dove è ambigua, come in ogni recita, la linea di demarcazione tra vero e falso; sono vissuto inoltre in un clima di falsa coscienza diffusa, come quello del fascismo. Sono stato segnato da questi dati geografici e storiografici, da questa mia falsa partenza e, come scrittore e come persona, ho cercato in ogni modo di aiutare “la mosca ad uscire dalla bottiglia”, cioè la mia immaginazione a liberarsi da questi condizionamenti, per sentirmi uno scrittore il più possibile libero, nonostante l’ambiente culturale e politico che mi circondava.
La letteratura fu per me una specie di ancora di salvezza, cercavo in essa la possibilità di arrivare a quella consapevolezza che non trovavo nella città e neppure nel Paese in cui vivevo. E non la trovavo perché la mia è stata un’epoca senza maestri. Delle menti più elevate di quel periodo, Benedetto Croce e Arturo Labriola, quando ho cominciato a frequentare il liceo nemmeno avevo sentito parlare. Chi si era permesso di renderli pubblici, chi aveva osato trasmettere il loro messaggio ai suoi studenti, era già stato allontanato dalla sua attività di docente, e nessuna cattedra gli sarebbe più toccata.
A dispetto di questo silenzio, Croce divenne comunque un punto di riferimento. Veniva tenuto in disparte dalla cultura ufficiale e il suo pensiero non era materia d’insegnamento, così come non erano materia d’insegnamento – anzi, erano del tutto sconosciuti – Antonio Gramsci e Gaetano Salvemini, ma si arrivava a certi autori attraverso qualche compagno più colto e intellettualmente più preparato. Per molti di noi Croce fu un primo maestro, quello che ci insegnò una verità molto importante per stabilire le distanze dal fascismo: e cioè che “la concezione della Storia come Storia della libertà ha come suo completamento pratico la libertà come ideale morale” (proprio con queste parole iniziava la sua Storia d’Europa).
Anche per ciò che riguarda la letteratura Croce fu un maestro perché grazie al suo insegnamento fummo poi anche in grado di accedere a quegli autori che lui stesso, per sua formazione, non amava e che noi invece imparammo ad amare, come Rimbaud, Verlaine, Baudelaire e i decadenti, e poi Proust, Joyce, Musil e i grandi del Novecento.
Croce ci diede la possibilità di entrare nel mondo della modernità armati degli insegnamenti morali, intellettuali, civili, politici, che lui ci aveva dato e che erano un buon approccio verso ogni tipo di letteratura.
E ci inculcò il concetto che attraverso la conoscenza della letteratura si poteva intraprendere il cammino verso una libertà spirituale e intellettuale che allora, durante il periodo fascista, ci era negata.
Questo implicava che ciascuno cercasse una libertà propria, una libertà che per molti versi bisognava inventarsi. Anni dopo volli dare al giovanotto che ero un nome, Candido. Candido era un protagonista e uno spettatore medio, vibrante ma pressoché impotente, di quell’atmosfera culturale in cui il fascismo si insinuava con la sua goffaggine e le sue inquietudini, diffondendovi tutta la sua retorica e imponendo ai giornali uno strano impasto di silenzio e menzogne. In questo clima, Candido si convinse che la letteratura sarebbe stata la chiave interpretativa del suo mondo, il sistema per comprendere finalmente chi era e in che universo viveva.
Candido sul finire degli anni Trenta si sarebbe tuttavia trovato di fronte a un bivio della propria vita e della propria etica. Accattare i fascismi, schierarsi alla fine dalla parte di chi offendeva l’uomo, il suo mondo, oppure scegliere le armi, usarle contro chi di queste offese si nutriva e viveva.
Assisteva intanto al fermento della lingua di quell’epoca. C’era un italiano letterario in cui il regionalismo e il lessico dei dialetti erano penetrati fino a invadere il senso e la forma; c’era un italiano letterario fatto di poesia, di chiara derivazione dannunziana, in cui prosa e versi si mescolavano in un garbuglio che impediva di distinguerli; c’era infine un italiano letterario ermetico, in cui si celebrava il trionfo del non dire, un linguaggio di pura sospensione metafisica.
La narrativa italiana era allora, ed è stata sempre, molto legata ai confini di una città, di una regione: scrittori come Brancati, Pratolini, Rea, Pavese e lo stesso Gadda fanno parte di una realtà regionale, anche se poi attraverso la rappresentazione di questo mondo sono stati capaci di arrivare all’universalità, dando espressione a una letteratura che può ben figurare nel contesto europeo. In fondo anche questo germe si muoveva inizialmente in un clima tutt’altro che favorevole, al fascismo non poteva andare giù l’Italia delle regioni e dei cortili, preferiva propagandare un Paese unico e unito, ben compatto e uniforme nella sua geografia umana e culturale.
E poi c’erano le parole, quelle che segnavano i concetti profondi dello spirito del tempo. Ricordo la diffusione dell’angoscia, esprimeva un disagio che negli anni successivi si sarebbe definito “alienazione”. Tra noi compagni del G.U.F. (la Gioventù Universitaria Fascista) l’angoscia si faceva viva piuttosto spesso, la sua legittimazione letteraria ce la forniva Kierkegaard, col suo Il concetto dell’angoscia, che citavamo e sentivamo citare, e che probabilmente era stata la lettura di pochi o di nessuno.
A un tratto apparve anche la crisi, la crisi dei valori, la crisi di una certa cultura, crisi politica e crisi religiosa, e la crisi soggettiva di chiunque avesse l’esigenza di fornire una certa complessità alla propria personalità; a qualcuno bastava assentarsi dal gruppo per qualche giorno perché la diagnosi di tutti noi fosse: “È in crisi”.
La possibilità di concepire la narrativa in chiave più ampia, come espressione di una cultura occidentale, per noi che iniziavamo a Napoli in quegli anni fu senza dubbio favorita dallo studio di Croce che ci insegnò, con la sua opera, a superare i confini locali e a cercare valori poetici universali, pur rimanendo fedeli alla nostra identità napoletana.
Per fare un esempio, il passaggio dal dialetto alla lingua fu particolarmente importante per noi perché a Napoli la tradizione dialettale è più forte che altrove e ha un suo pubblico consolidato. I suoi autori erano Viviani, Di Giacomo, De Filippo...
E non è che li ripudiassimo, ma furono i libri di Croce per noi gli unici spiragli aperti sul mondo, in una Italia in cui il clima generale era di chiusura. Allora tutta la letteratura e l’arte moderna erano bollate dal fascismo come arte degenerata. Tra l’altro la nostra opposizione al regime importante e alla cultura ufficiale avveniva proprio all’interno delle organizzazioni fasciste come il G.U.F., perché erano questi gli unici contesti in cui potevamo confrontare le nostre idee. E questo era possibile anche perché chi doveva controllarci non aveva gli strumenti per farlo.
Nel 1945, subito dopo la guerra, un gruppo di giovani di cui facevano parte Francesco Rosi, Giuseppe Patroni Griffi, Anna Maria Ortese, Luigi Compagnone, Antonio Ghirelli, Maurizio Barendson e altri, raccolti intorno a Pasquale Prunas, sentì il desiderio di fondare una rivista in cui manifestare le proprie idee. Nacque così “Sud”, giornale di cultura, in cui fin dal primo numero, cercammo di superare l’isolamento culturale subìto e vissuto per anni, dichiarando che “Sud” per noi voleva dire una parte dell’Europa.
Avevamo tenute molte idee chiuse dentro di noi ed era venuto il momento di manifestarle. C’era allora in Italia una vera e propria rinascita intellettuale, si sentiva in tutto il Paese come un desiderio di ricominciare a vivere.
In uno dei primi articoli di “Sud” scrivemmo: “La nostra nascita anagrafica si è perduta nel buio che ci ha preceduti... nasciamo da una morte con l’ansia di essere finalmente vivi...”.
Con questa rivista cercammo una nostra identità culturale che riuscisse a mantenere una sua autonomia anche dall’ideologia comunista, che era molto forte negli ambienti intellettuali, e non solo a Napoli.
Questo creò dei conflitti, all’interno del gruppo (perché alcuni di noi erano comunisti) e all’esterno, sulle scelte culturali fatte da “Sud”: per esempio le polemiche sull’esistenzialismo di Sartre, giudicata dai comunisti una ideologia borghese.
Per noi, a Napoli, “Sud” fu l’apertura verso l’Europa. Ci accostammo ad autori come Eliot, Spencer, traducemmo Dylan Thomas, Isherwood e tanti altri, e anche i più importanti autori americani.
Fu preziosa in quegli anni la collaborazione di William Weaver, che si trovava a Napoli con le truppe d’occupazione americane. Bill veniva dall’Università di Princeton e fu lui che ci fece conoscere Francis Scott Fitzgerald, Carson McCullers, Thomas Wolfe e tanti altri scrittori inglesi e americani. Con il suo aiuto migliorai il mio inglese e mi avventurai nella lettura dell’Ulisse di Joyce, dell’Urlo e il furore di Faulkner, e da queste esperienze nacque il mio desiderio di adeguare il realismo tradizionale della nostra narrativa alle scoperte strutturali del romanzo novecentesco.
In questi autori avevo trovato infatti qualcosa di assolutamente nuovo rispetto alla narrativa italiana: la costruzione del romanzo secondo una strategia compositiva. Nelle loro opere veniva superato il modo di narrare naturalistico che privilegiava il punto di vista di un unico osservatore, dello scrittore che si pone al centro della narrazione e tutto sa della sua storia e dei suoi personaggi. Scoprivo la possibilità di raccontare una storia da un punto di vista plurimo, da angolazioni diverse e attraverso la voce di più personaggi. Anche il tempo del racconto non seguiva più un ordine cronologico, ma era un tempo sincronico in cui gli avvenimenti sono tutti contemporaneamente presenti. Così come avviene, di solito, nella mente di una persona: passato, presente e futuro si incrociano e si sovrappongono di continuo.
Questo tipo di struttura informava tutte le parti del racconto, anzi, queste acquistavano un determinato significato proprio perché inserite in un particolare disegno narrativo.
Ricordo ancora la grande emozione che provai allora nel leggere L’urlo e il furore di Faulkner, oppure Fiesta di Hemingway o La signora Dalloway di Virginia Woolf, opere del Novecento che noi in Italia, durante il fascismo, non avevamo letto e che rappresentavano un’importante novità dal punto di vista formale.
In questi romanzi scoprivamo inoltre una nuova prospettiva nella rappresentazione della realtà – vista come una lente d’ingrandimento – attraverso la dilatazione del linguaggio.
Le influenze di queste letture sono riconoscibili certamente anche in quello che ho scritto io. Con il mio primo libro Un giorno d’impazienza (1952) cominciai a lavorare in questa direzione. Volevo scrivere una storia in cui la struttura fosse più importante degli avvenimenti che raccontavo. Volevo rappresentare il circolo vizioso di una coscienza che si avviluppa su sé stessa e non riesce a cogliere la realtà che la circonda.
Era una storia apparentemente comune, apparteneva al vissuto di molti giovani della mia età: l’incontro con una ragazza che provoca il tentativo di uscire da sé stessi, dalla propria opprimente interiorità.
L’esperienza emotiva e sentimentale del protagonista non era perciò semplicemente un’esperienza d’amore, ma qualcosa di diverso: era il tentativo di andare incontro alla realtà; e anche se la rappresentazione di questa realtà avveniva nel mio libro ancora secondo uno schema neorealista, si vedeva però già chiaramente il segno di una ricerca, nel senso che ho detto, in tutta l’organizzazione e la disposizione delle varie parti del racconto.
Il protagonista si analizza, avvolge nelle proprie riflessioni anche gli aspetti naturalistici della narrazione fino a stravolgerli, e il libro finisce quasi con le stesse parole con cui è cominciato, proprio per dare l’idea del circolo vizioso in cui il personaggio si sente chiuso. Tutto questo si riflette nel linguaggio, poiché le frasi sono come tanti percorsi che a loro volta si avvolgono su sé stessi, creando una specie di spirale dell’inconcludenza. Questo rende così, strutturalmente, la condizione del personaggio e la sua incapacità di afferrare la realtà.
Col tempo ho sostituito il tema della inafferrabilità del reale col tentativo di afferrare la realtà di una città anch’essa inafferrabile come Napoli, per cercare di renderla più accessibile, liberandola dalle sovrastrutture dei luoghi comuni che la nascondono, e di chiarirne la natura.
È stata una scelta dettata anche da una volontà di partecipazione civile, specie per quanto riguarda il mio libro L’occhio di Napoli (1994). Ma in tutti i libri che ho scritto c’è sempre questo dissidio, questo “poetico litigio”, tra me e la città, e il desiderio di svelarne l’anima nascosta, di ripensarla in modo da renderla presentabile, non con un maquillage superficiale, ma con una riscoperta della sua identità.
Io ho sempre voluto parlare di Napoli e non “esserne parlato”. Napoli è il tema di Ferito a morte (1961). In quel libro volevo dire dello spreco del tempo a Napoli, di quella terribile dissipazione per cui un giorno o dieci anni sono esattamente la stessa cosa, scorrono esattamente alla stessa maniera, e all’improvviso, quando tutto è già accaduto, ci sembra che “la vita è quello che ci accade quando non ce ne accorgiamo”.
Questa è la “ferita mortale” che attraversa l’intera giornata del protagonista, una giornata che in realtà ripercorre dieci anni per cui alla fine del racconto si chiudono insieme un giorno e un decennio.
Quella bella giornata senza una nube nel cielo è attraversata da un’ombra, perché lì dove l’esistenza non è una costruzione della coscienza l’individuo scompare e vince la Natura (“la Natura vince la Storia”).
Dove non c’è giudizio non ci può essere memoria e dove non c’è memoria non c’è neppure il presente.
Per dire tutto questo in un romanzo, per parlare di questa ferita che genera l’impossibilità di un progetto organico dell’esistenza e l’incapacità di uscire dal qui e ora, dovevo mandare avanti quel lavoro sulla costruzione narrativa già messa a punto con Un giorno d’impazienza. Per me imporre un ordine, una forma alla narrazione di tipo naturalistico, non era una scelta estetica, ma funzionale a ciò che volevo dire e che non avrei potuto dire al di fuori di questa struttura.
Il discorso sul tempo che gira su sé stesso riguarda non solo gli individui, ma anche le città e la mia città: è questo il tema dominante dell’Armonia perduta, scritto venticinque anni dopo Ferito a morte.
Ci sono città, soprattutto le città del Mediterraneo, il cui processo storico a un certo punto si blocca e in qualche modo sopravvivono a sé stesse. Parlo non solo di Napoli, ma anche di Venezia, Palermo, Costantinopoli, Alessandria, città che hanno voltato le spalle alla modernità e sono perciò molto differenti da Parigi, Londra, New York, dove ogni momento storico ha avuto giorno per giorno il suo naturale sviluppo.
Chi nasce in città come queste deve compiere personalmente quel processo storico che si è bloccato a suo tempo, e deve da solo portarlo avanti sino ai nostri giorni, per restituire alla città una continuità con il presente.
Nel caso di Napoli, quel blocco lo feci risalire al 1799, all’epoca della Rivoluzione napoletana. Molte cose accadute dopo quella dat...