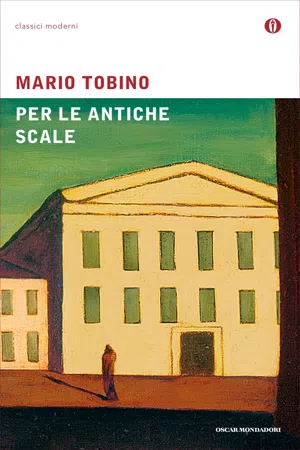I
Il dottor Anselmo abitava in manicomio. Mangiava alla mensa; aveva una stanza. Lo stipendio era gramo. Tutto era ristretto.
Solo chi c’è passato sa come fu il dopoguerra in Italia – quello della seconda guerra mondiale – per uno che durante la dittatura italiana aveva vivamente sperato: da ogni parte scenari che cadevano, trionfo della materia, il denaro e la carne più dominanti di prima. La nuova lussuria invogliare le masse alla completa servitù.
Anselmo si era ritirato; faceva vita di ospedale, di manicomio.
Giorno dopo giorno, in quelle ore, si era trovato ad occuparsi semplicemente dell’Istituto dove lavorava. Diverse volte nella giornata si soffermava in portineria per ragioni pratiche come la posta, il telefono, il parente di un malato che chiedeva informazioni; più spesso – specie verso sera – per chiacchierare col portiere D’Inzeo, ormai prossimo alla pensione, con Achille, il tecnico di Laboratorio, anche lui veterano.
Nei nebbiosi pomeriggi invernali le conversazioni si fecero sempre più fitte, confidenziali. E ogni volta, fatalmente, succedeva che il centro del discorso fosse il Bonaccorsi, il dottor Bonaccorsi, lui aveva guidato, dominato gli anni precedenti. Nell’ospedale si muoveva la sua leggenda.
Infatti anche gli altri infermieri ne parlavano con fervore e come ancora vivesse, lo si potesse incontrare da un momento all’altro per le corsie, tra i malati, nella sua camera-ufficio impregnata di acido fenico, e innanzitutto, attraverso il finestrone, lo si potesse intravedere nel Laboratorio, suo regno per più di trentacinque anni.
Anselmo un giorno tentò di collocare nel tempo il Bonaccorsi e domandò:
«È molto che è andato in pensione?»
Achille contò con le dita e: «Nove anni. Perbacco, come passano!».
«E… quando è morto?»
«Due inverni fa, il 16 dicembre.»
Anselmo si accorse che quei due vecchi infermieri, coi quali così spesso parlava, solo ora si azzardavano – e in parte – a parlare con libertà sul dottor Bonaccorsi; quasi anche a loro sembrava di non esser proprio sicuri che non apparisse per i viali del manicomio, attraversasse in fretta il giardinetto davanti alla direzione.
Achille, che del Bonaccorsi era stato la vittima e il beneficiato, era quello che dava i dati più sicuri, di prima mano, testimonianza diretta.
Il portiere D’Inzeo comprovava, aggiungeva il suo tono a quella musica, e con una acutezza particolare, di chi ha osservato da lontano ma con più calma e attenzione, meno disturbato dalla vicinanza fisica.
Achille, il tecnico di Laboratorio, era stato dominato tutta la vita dal Bonaccorsi, dalla sua figura.
Negli ultimi anni però, quando il dottore era già in pensione, il ritratto gli si era offuscato, intinto di amaro. Achille aveva creduto di essere il suo beniamino, una eccezione tra tutti gli infermieri, e invece no, aveva battuto la testa nell’incontrario.
Quando il dottor Bonaccorsi andò in pensione – in uno dei quattro appartamenti della palazzina davanti al fiume – i nuovi dirigenti, per quel doveroso omaggio che tutti spontaneamente avevano per lui, incaricarono un infermiere di portargli ogni mese le riviste di psichiatria che mano-mano uscivano. Lo stesso infermiere doveva ritirarle, il mese trascorso, e portare le nuove.
Quando l’infermiere bussava alla porta, era la sorella del Bonaccorsi ad aprire. Il dottore non si faceva vedere, non si presentava, rannicchiato dietro la porta della sua stanza.
Se c’erano nuove istruzioni il Bonaccorsi le trasmetteva attraverso l’uscio alla sorella, e questa all’infermiere.
Achille ardeva dalla voglia di rivederlo almeno una volta, parlare con lui una volta almeno ancora, il suo maestro, dedicate a lui le sue ore più belle.
Benché il Bonaccorsi avesse dichiarato che mai più avrebbe ricevuto persona, Achille sperava, era sicuro, che per lui ci sarebbe stata l’eccezione.
La sorella aprì. Appena il Bonaccorsi capì che invece del solito infermiere era venuto Achille, parlò ancora meno, da dietro la porta. Invano Achille si effondeva, chiedeva notizie sulla sua salute, che tutti lo ricordavano, il manicomio senza di lui un deserto.
Nulla. Di là, dietro la porta, non arrivò più neppure un mugolio. Achille si ritrovò sulla strada quasi in pianto.
Fu anche per questa sofferta amarezza che Achille prese sempre più a parlare con confidenza sul Bonaccorsi, a rispondere ad Anselmo che si insinuava con ogni sorta di domande.
E così accadde che in quei lunghi dopopranzi di portineria, Anselmo lentamente – una confidenza dopo l’altra, un episodio da Achille, una notizia da D’Inzeo – riuscì a carpire presso che tutto di quel tempo leggendario, del Bonaccorsi e degli altri.
II
Bonaccorsi era biondo, alto, gli occhi celesti, vigoroso, un che di longobardo; aveva una barbetta a punta che soleva in certi momenti stringere nel pugno. Un uomo attivissimo, brulicante di progetti, di azioni, di immediatezze. Numerosi medici della vicina città ancora se ne ricordano con gratitudine e ne parlano con eccitazione.
Quando Bonaccorsi sapeva che a Lucca c’era uno studente di medicina avido di apprendere, lo invitava, gli mandava un infermiere con un biglietto, che finiva: “Venga a studiare con me. L’aspetto”. In questi casi era di estrema umiltà.
Lo studente arrivava con entusiasmo.
Il Bonaccorsi proponeva:
«Se ci mettessimo al cervello? Lo ripassiamo insieme. Che voglia ho di rivedermelo tutto! Oppure vogliamo trattare il cuore? È anch’esso ben misterioso! Cosa preferisce?»
L’argomento era scelto, e allora:
«Dovremmo cominciare di buon’ora perché poi ho da curare il Laboratorio. Venga domattina alle cinque. Andremo avanti per alcuni mesi, non trascureremo nulla.»
Così ogni mattina lo studente arrivava al manicomio; il Bonaccorsi era già in piedi, festoso per la prossima attività. I libri disposti, preparati sul piccolo tavolino della camera-studio.
Il Bonaccorsi per due e tre ore illustrava l’anatomia, la fisiologia, la patologia, faceva una lezione a tu per tu, sommamente proficua. E se udiva di un altro o più studenti volenterosi anche questi erano invitati, accolti, spronati alla bellezza e serietà del sapere. Alle cinque del mattino – e d’estate ancora prima – nella cameretta del Bonaccorsi cominciavano a correre i nomi delle diverse branche della medicina.
Questo per gli studenti. Un’altra sua donazione, ed assai più importante, era per i medici, per gli alienisti, per chi aveva iniziato la carriera psichiatrica sia in un manicomio che in una clinica.
Il Bonaccorsi donava i lavori scientifici, i lavori di psichiatria, neurologia, istologia.
Per i medici dello stesso ospedale ripetutamente accadeva così. Un giorno il Bonaccorsi incontrava uno di questi e, come distrattamente:
«Ho scoperto un caso interessante. Ci potresti fare un lavoro.»
Il medico rizzava le orecchie, acchiappava la fortuna; tutti sapevano cosa voleva dire quell’invito. I lavori servivano per i concorsi.
«Il caso è questo. Vai nel tale reparto. Studialo, butta giù le tue riflessioni. Mi raccomando la bibliografia.»
Il medico faceva qualche mossa, usava un po’ di finzione, simulava di aver sudato. E ritornava dal Bonaccorsi con due o tre paginette.
«Bene. Gli darò un’occhiata. Poi te le ripasso.»
Il Bonaccorsi sbrigava tutto, era assetato di attività, trovava appagamento nel portare a termine ogni faccenda. Appena quelle smilze paginette erano in mano sua, le trescava con letizia e animosità. Era un fiume di memoria, di associazioni di immagini, possedeva le notizie più fresche, internazionali, moderne. Scriveva con quella sua calligrafia rapida, in fuga. Più andava avanti, più il lavoro si arricchiva, altre idee nascevano; molto spesso la parte scritta veniva accresciuta, corredata, comprovata da preparati istologici, da microfotografie.
In pochi giorni quelle grame paginette consegnate dal timido dottore si erano trasformate in un poderoso lavoro psichiatrico, degno della rivista più qualificata.
Si trattava di batterlo a macchina; lavoro anche questo per il Bonaccorsi piacevole. La macchina da scrivere in quei primi decenni del secolo non era uno strumento comune, e lui si dilettava dei nuovi congegni.
L’iter, il viaggio era per concludersi: il medico beneficiato simulava l’ultimo sudore.
Il Bonaccorsi lo chiamava e con graziosa umiltà lo avvertiva che si era permesso alcune correzioni; sperava fosse d’accordo. Non lo lasciava commentare.
«Ed ora la pubblicazione. Guarda la fortuna! Proprio l’altro giorno mi ha scritto il vecchio amico, il direttore della “Rivista di Freniatria”, senza dubbio la più bella d’Italia. Vogliamo mandarlo a lui? Lo spedisco io. Facciamo fare ad Achille un bel pacchetto, ché le microfotografie non si sciupino.»
Il medico ringraziava, si inchinava. Il Bonaccorsi troncava i convenevoli.
Quella faccenda era finita, gli ce ne voleva un’altra. (E scioccamente delle volte accadde, presso qualche medico dalla testa leggera, che siccome il Bonaccorsi continuava con i doni, con i lavori psichiatrici regalati da cima a fondo, qualche volta accadde che i medici leggeri di testa credettero che i lavori si facessero così, anche negli altri ospedali, che dappertutto ci fosse – chissà per quale arcano – un Bonaccorsi.)
Per i medici di ospedali forestieri invece c’erano prima degli approcci per lettera. Molti sapevano e ne approfittavano. Il Bonaccorsi per costoro era ancor più alacre, perché erano il contatto col mondo, volevano dire la conoscenza di altri ospedali, diversi indirizzi scientifici, le idee che circolavano in altri istituti.
In questi lavori per medici forestieri metteva maggiore impegno. Il Laboratorio – con lui stesso e il tecnico Achille – entrava in piena funzione: dimostrare maestria, la padronanza dei metodi più moderni e difficili; in quei mesi per Achille non esisteva l’orario.
Il Bonaccorsi era prodigo, era felice di donare agli altri il suo lavoro. C’era però un occasionale episodio che aveva favorito, c’era un segreto che in parte spiegava quel comportamento, quella febbre che lo prendeva a vergare lavori di psichiatria, che poi andavano sotto altri nomi.
Aveva cominciato lo studio della psichiatria con tumulto, gli pullulavano le congetture, in certi momenti si sentiva sicuro che avrebbe scoperto, quello un campo ignoto, adatto per lui, qualche parte ne avrebbe illuminato.
Volle il caso che in quello stesso ospedale c’erano tre medici: Sfameni, il direttore dell’Istituto, il vice-direttore Rospigliosi, e un certo professor Saccomanni, anonimo quant’altri mai ma profondamente buono. Questi tre medici erano disposti alla scienza, desiderosi di collaborare e insieme docili, modesti di fantasia. Il Bonaccorsi li affascinò. Lui era semplicemente primario, ma nella ricerca le gerarchie non esistono.
Cominciarono a lavorare insieme; quel che lui diceva era legge, pendevano dalle sue labbra, credevano alle sue idee, ammiravano la sua inesauribilità.
Il Bonaccorsi era anche bello di fisico, un che di nordico, simile a certi tedeschi, olandesi, svedesi; i suoi occhi celesti a volte sembravano aver rifranto i ghiacciai, conosciuto i folletti, le amazzoni bionde...