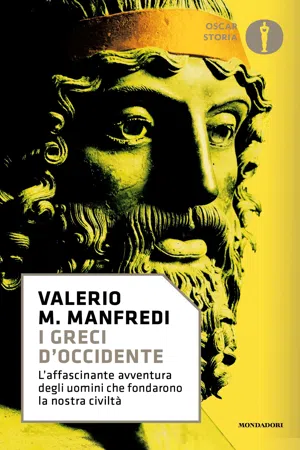Sulla scia dei Fenici, i primi coloni greci attivi in Occidente sono gli Eubei, provenienti dalle città di Calcide ed Eretria. Su questo punto concordano fonti letterarie e documentazione archeologica. Quest’ultima ci dice anche qualcosa di più: che i colonizzatori euboici seguono rotte già percorse dai loro mercanti, come testimoniano le tipiche coppe a semicerchi penduli che ne rivelano la presenza a Veio in Etruria e a Villasmundo in Sicilia già in età precoloniale, grosso modo intorno alla metà dell’VIII secolo, epoca in cui vengono creati i loro primi insediamenti emporici e fondaci commerciali, su entrambe le rotte mediterranee che conducono a Gibilterra. Sia, cioè, lungo la rotta meridionale che dall’Eubea poggia su Creta per poi raggiungere la costa africana e quindi costeggiarla verso Occidente; sia lungo la rotta settentrionale che dall’Eubea nell’Egeo conduce a Corcira (Corfù) nello Ionio per poi attraversare il canale di Otranto, puntare allo stretto di Messina, guadagnare le acque del Tirreno e quindi costeggiare l’Italia, la Francia e la Spagna fino a pervenire, a Gibilterra, presso le mitiche Colonne di Ercole.
In Africa l’attività commerciale degli Eubei darà vita sulla costa ad alcune colonie fra le più arcaiche della Tunisia, che però saranno presto bloccate nel loro sviluppo dalla sorgente potenza di Cartagine, che le sottomette politicamente o le ingloba nel proprio sistema economico. Quindi solo sulla rotta settentrionale si svilupperà una vera e propria colonizzazione euboica destinata a resistere nei secoli. Qui, sulle coste dell’Italia e della Sicilia, sorgeranno le colonie di Pitecusa (Ischia), di Cuma, di Reggio, di Zancle (Messina) e di Nasso, a loro volta metropoli di ulteriori subcolonie. E qui, nelle aree delle loro fondazioni occidentali, gli Eubei localizzano le avventure dell’Odissea così care all’immaginario collettivo di ogni popolo navigatore: nel golfo di Napoli, dove fondano Pitecusa e Cuma, ubicano il mondo degli Inferi e gli scogli delle Sirene; nello stretto di Messina, dove fondano Reggio e Zancle, i gorghi di Scilla e Cariddi, nella Sicilia orientale, dove fondano Nasso, i pascoli dei buoi del Sole e la terra dei Ciclopi, e via di seguito.
Abbiamo detto come gli Eubei, su entrambe le rotte del Mediterraneo, navighino in direzione di Gibilterra. Qui infatti, sulle coste dell’Atlantico, presso Cadice, sorgeva il ricchissimo emporio di Tartesso, già frequentato dai Fenici e noto anche alla Bibbia. Emporio donde i Greci, come si è detto, potevano importare ampi quantitativi di argento, abbondantissimo, nonché ambra o stagno o altri prodotti grezzi della metallurgia che giungevano fin là, via mare, dall’Europa del Nord: in particolare dalle isole britanniche o dai paesi baltici. Ma anche l’Etruria, prossima alle colonie euboiche fondate in area campana, costituiva un obiettivo primario per le importazioni greche: in questa regione, attraverso lunghe vie carovaniere terrestri, che si snodavano dall’Europa centrale, affluivano ulteriori metalli e materie preziose. Inoltre i giacimenti di ferro presenti nell’isola d’Elba costituivano di per sé un ricchissimo incentivo per qualsiasi mercante proveniente dall’area egea. Cosa che spiega perché tanto precocemente, già all’alba delle prime esplorazioni greche nel Tirreno, il poeta Esiodo, nella Teogonia (1011-1016), tramandi una leggenda che riconnette strettamente la saga di Ulisse all’area etrusco-laziale attraverso la discendenza che all’eroe sarebbe venuta dalla sua unione con Circe:
Circe, figlia del Sole, stirpe di Iperione, unitasi in amore con Odisseo, dal cuore che sopporta, generò Agrio e Latino, irreprensibile e forte. … Questi regnavano molto lontano, nel mezzo di isole sacre, su tutti gli illustri Tirreni.
Agrio e Latino sono i primi mitici re di Alba Longa e di Lavinio, e i Tirreni, sui quali essi regnano, sono gli interlocutori commerciali dei primi mercanti greci che, già da età remotissima, per importare metalli o prodotti greggi della siderurgia, raggiungono l’Etruria, diretti in particolare all’Elba e alle isole dell’arcipelago toscano. Probabilmente proprio le «isole sacre» che Esiodo circonfonde di un alone di mistero. Dunque anche i figli di Ulisse e di Circe ci indicano una delle mete primarie dei commerci greci nei mari di Occidente! Ma questa è una leggenda che presuppone che il suo primo divulgatore ubichi la reggia della maga Circe in area prossima al mondo etrusco-laziale: cioè presso il promontorio del Circeo. Il che ci rivela la sua identità: è di stirpe euboica poiché – come abbiamo detto – proprio agli Eubei si deve la prima ambientazione occidentale della geografia dell’Odissea.
Pitecusa
I versi di Esiodo che abbiamo riferito si datano fra i secoli VIII e VII, grosso modo nella medesima epoca che vede il potenziarsi e il fiorire dell’emporio commerciale di Pitecusa. All’isola, già intorno alla metà dell’VIII secolo, approdano i primi coloni euboici per stanziarvisi in forma stabile, come testimonia l’ampia e diffusa documentazione archeologica. Coloni che Strabone, in età romana, nella sua Geografia (V, 247-248), ci dice provenienti dalle città di Calcide e di Eretria. La testimonianza, ricca di particolari, è degna della massima attenzione:
Subito dopo Pompei c’è Sorrento, città della Campania dove si trova l’Athenaion, che alcuni chiamano promontorio delle Sirene: sulla punta del promontorio c’è un tempio di Athena, fondato da Ulisse. Di lì all’isola di Capri c’è un breve tratto di mare. Doppiando il promontorio, ci sono alcune isolette deserte e rocciose, che chiamano Sirene … Davanti a Capo Miseno c’è l’isola di Procida, che è un frammento staccatosi da Pitecussa. Pitecussa fu colonizzata da Eretriesi e Calcidesi, ma costoro, benché vivessero nella prosperità grazie alla fertilità della terra e alle sue miniere d’oro, abbandonarono l’isola in seguito a lotte e poi anche perché cacciati da terremoti, da eruzioni di fuoco, di mare e di acque bollenti … Deriva da tali fenomeni anche il mito secondo cui Tifone giacerebbe sotto quest’isola; quando egli si agita farebbe venire su le fiamme e le acque e talvolta anche piccole isole con getti d’acqua bollente.
Sembra questa una testimonianza del tutto superficiale, ma, a saperla leggere, ci disvela dati documentari decisivi. Pitecusa è dunque popolata da coloni provenienti, congiuntamente, dalle città euboiche di Calcide e di Eretria. Ciò significa che tale colonizzazione è da situare in età anteriore alla guerra lelantea che, sul suolo dell’Eubea, intorno alla metà dell’VIII secolo, contrappone frontalmente le città di Calcide ed Eretria in un lungo ed estenuante conflitto destinato a concludersi con la distruzione di quest’ultima città e con il logoramento della sua rivale. Solo prima dello scontro le due metropoli potevano infatti agire in coppia: cioè prima della metà dell’VIII secolo, che è appunto la data cui, per la colonizzazione di Pitecusa, riconduce la testimonianza archeologica.
La fondazione nel lontano Occidente costituisce non solo un ottimo trampolino di lancio per avventure commerciali in area tirrenica, ma – come precisa Strabone – assicura ai nuovi coloni grande prosperità sia per la fertilità della terra, sia per la presenza di miniere d’oro. Le miniere sono, probabilmente, frutto di una leggenda che però testimonia come nell’immaginario collettivo degli antichi navigatori l’isola fosse associata a un’idea di grande e sconfinata ricchezza. Ricchezza che – assicura sempre Strabone – non impedisce ai coloni di emigrare verso altri lidi quando l’isola è scossa da forti rivolgimenti tellurici e contemporaneamente dilaniata da profonde lotte fratricide fra Calcidesi ed Eretriesi.
Ma la nostra testimonianza, pertinente alle prime memorie euboiche presenti nel golfo di Napoli, è inoltre preziosa perché conferma l’esistenza di leggende relative a Tifeo e a Ulisse, rispettivamente nell’isola di Ischia e nell’area del vicino promontorio di Sorrento.
Il ricordo di Tifeo, schiacciato sotto l’isola di Pitecusa, si ricollega alla saga della Gigantomachia, divulgatissima proprio presso gli Eubei, che traspongono dalla Calcidica alla regione del golfo di Napoli l’ubicazione dei Campi Flegrei dove Zeus avrebbe trionfato sui suoi smisurati, quanto sconsiderati, rivali. Il corpo di uno di essi, Tifeo, è appunto sepolto per sempre sotto l’isola di Pitecusa: la quale, proprio per questo, e per scherno, è definita «isola delle Scimmie» con una falsa etimologia che irride il rivale di Zeus.
Il ricordo di Ulisse, presso il promontorio di Sorrento, si ricollega alla presenza degli scogli delle Sirene, confermandoci ancora una volta la stretta correlazione esistente fra la colonizzazione euboica e l’ambientazione occidentale della geografia dell’Odissea. Ma i più antichi coloni di Pitecusa, cioè i primi Eubei stanziati in Occidente, conoscevano davvero i poemi omerici? Conoscevano gli eroi dell’Iliade e dell’Odissea, immaginandosi di ripercorrere le rotte medesime che essi avrebbero seguito, reduci da Troia, nei loro difficili, e talora mancati, ritorni? Oggi una straordinaria scoperta archeologica ci consente di rispondere affermativamente a queste domande, attestando che i poemi omerici erano già profondamente radicati nella coscienza dei primi coloni euboici sbarcati a Pitecusa. Nell’isola, infatti, in una tomba databile all’VIII secolo, un’iscrizione graffita su una tazza ceramica di produzione rodia reca una sfida, o una comparazione, fra il contenuto della tazza e quello della celebre coppa di Nestore descritta nell’Iliade. L’epigrafe, che è di gran lunga la più arcaica fra quelle rinvenute in area occidentale, presenta un testo già evoluto sia per alfabeto sia per stilemi formali (Supplementum Epigraphicum Graecum, XIV, 604):
La coppa di Nestore era certo piacevole a bersi, ma chi beve da questa coppa subito sarà preso dal desiderio di Afrodite dalla bella corona.
Il morto che viene inumato con la sua bella tazza (probabilmente uno dei primi coloni) istituisce dunque un paragone fra questa e la coppa di Nestore; l’una, ricolma di vino, è solo piacevole a bersi, ma l’altra, la sua, se ricolma di altri beveraggi, ha il dono di essere afrodisiaca. Orbene, tale iscrizione mostra appunto che i poemi omerici erano ben noti presso i primi coloni euboici dell’Occidente, e fin nelle loro più minute suggestioni. L’archeologia, nel caso di Pitecusa, ci consente non solo di confermare il dato della tradizione letteraria, ma anche, inaspettatamente, di riscoprire lo spessore culturale dei coloni.
Cuma
Gli Eubei stanziati a Pitecusa avranno guardato con interesse alla limitrofa terraferma, dove ben presto altri concittadini, sopraggiunti dalla madrepatria e attratti dal loro richiamo, fondano la colonia di Cuma. Ne siamo nuovamente informati da Strabone (V, 243):
Dopo queste città viene Cuma, fondazione assai antica dei Calcidesi e dei Cumani: è la più antica di tutte le colonie di Sicilia e di Italia. Ippocle di Cuma e Megastene di Calcide, che erano a capo della spedizione coloniale, si erano messi d’accordo fra loro che la città fosse colonia dei Calcidesi, ma portasse il nome di Cuma: per questo anche ora è chiamata Cuma pur avendola, come sembra, colonizzata i Calcidesi. La città … era prospera e così la pianura chiamata Flegrea, dove viene localizzata la leggenda dei Giganti.
Fra gli Eubei solo i Calcidesi partecipano alla fondazione di Cuma. L’assenza di Eretriesi denuncia che siamo già in un’età nella quale le metropoli dell’Eubea si fronteggiano nella guerra lelantea. Ciò è indizio di come la nuova colonia, per quanto arcaica, si dati in un’età leggermente posteriore a quella della fondazione di Pitecusa: quindi immediatamente dopo la metà dell’VIII secolo, fra il 750 e il 725 a.C., a stare alle risultanze di più dati fra loro convergenti. Il che ben si armonizza con il quadro storico offertoci dalla coeva documentazione archeologica. Strabone definisce sì Cuma «la più antica di tutte le colonie di Sicilia e di Italia»; ma egli intende parlare solo delle colonie che hanno avuto un loro divenire storico, e quindi prescinde qui dal ricordo di Pitecusa che – seppure più antica – non ha avuto lunga vita essendo stata abbandonata dai suoi abitanti.
La presenza di due fondatori, Ippocle e Megastene, tradisce, per Cuma, un apporto coloniario legato a due gruppi etnici. I quali appunto, come precisa Strabone, sono costituiti da elementi di stirpe, rispettivamente, cumana e calcidese. Ma quali sono gli elementi cumani? E provengono da Cuma d’Asia, nell’Eolide, ovvero da un’altra Cuma, assai meno nota, situata nell’isola di Eubea? La prima posizione è sostenuta da Eforo, che, seppure storico affidabile, potrebbe esserne stato incentivato da motivi di campanile perché appunto nativo di Cuma in Asia; la seconda si ispira al buon senso e trae conforto dalla nutrita serie di autori latini che, per la Cuma campana, ricordano solo la sua origine calcidese.
Comunque sia, fra i nuovi coloni si dovranno ascrivere anche elementi pitecusani, che certo avranno fatto da battistrada ai compatrioti in arrivo dalle lontane metropoli dell’Egeo. Così giustamente sottolinea Livio (Ab urbe condita, VIII, 22, 5-6), che però in forma arbitraria unifica le distinte spedizioni coloniarie che portano gli Eubei a stanziarsi prima a Pitecusa, donde occupano la limitrofa Enaria (Procida), e solo successivamente a Cuma, a sua volta metropoli delle due città di Napoli, la vecchia (Paleapolis) e la nuova (Neapolis):
Palepoli sorgeva poco lontana dal posto in cui è ora Napoli: erano due città abitate da popolazione di uguale stirpe, oriunde da Cuma; ed i Cumani provengono da Calcide dell’Eubea. Con l’aiuto della flotta che li aveva lì portati dalla patria avevano acquistato molta potenza lungo le coste del mare da essi occupate, sbarcando prima nelle isole di Enaria e di Pitecusa, donde poi erano passati sulla terraferma.
Livio, storico di Roma, appartiene agli autori latini che rivendicano, per Cuma, solo un’origine calcidese. Probabilmente egli ha ragione nel ricordarci come la fondazione di Cuma abbia quale premessa obbligata quella di Pitecusa, ma poi sbaglia nell’attribuire a un medesimo gruppo di coloni provenienti dall’Eubea la deduzione tanto dell’una quanto dell’altra città. Il suo interesse tuttavia è rivolto ad altro: a offrire al lettore, con notazione unitaria, il quadro avvolgente di uno sviluppo rettilineo della presenza greca nelle acque del golfo di Napoli. Egli inoltre ci dice che gli Eubei, che fonderanno Cuma, «avevano acquistato molta potenza lungo le coste del mare». E ciò significa – al di là di facili eufemismi – che essi esercitavano un controllo sulle rotte costiere praticando la pirateria; attività, come sappiamo, mai disgiunta, o disgiunta del tutto, nel mondo greco arcaico, dalla consuetudine della navigazione e del commercio. Peraltro – come diremo – anche lo storico Tucidide conosce pirati cumani che infestano i mari e gli stretti occidentali proprio all’alba della colonizzazione euboica.
Ma, anche se originariamente – e disinvoltamente – mercanti e pirati, a Cuma questo popolo di avventurieri del mare si trasforma ben presto in un popolo di agricoltori. Come accennato nel primo capitolo, regioni della Grecia metropolitana stavano infatti attraversando una profonda crisi sociale che rivelava come esse fossero ormai troppo anguste per i rispettivi abitanti. Non che mancasse la terra, ma questa era malamente distribuita e di fatto accentrata nelle mani di un chiuso latifondo che strozzava la piccola proprietà contadina. Gli appartenenti ai ceti più deboli erano così costretti a emigrare tentando l’avventura della colonizzazione. Ecco perché Cuma nasce sì come base commerciale, ma acquista poi tutti i caratteri della colonia di popolamento; cioè della colonia in grado di offrire, a successive ondate di coloni, quelle fertili aree coltivabili delle quali essi più non possono disporre nella madrepatria.
Quella che la tradizione ci indica come la più antica città greca in Occidente ha dunque il duplice ruolo di colonia commerciale e di base agricola. Ma, data la sua posizione geografica, di più settentrionale fra tutte le fondazioni greche dell’Italia tirrenica, diviene, culturalmente, anche un’importantissima città di frontiera con il mondo etrusco-latino. Roma, in particolare, tramite Cuma, assimila nella propria la cultura greca, ricevendone continui arricchimenti, o condizionamenti, nel modello di vita: dall’introduzione dell’alfabeto alla genesi della lingua letteraria, dall’importazione di nuove divinità alla definizione di nuove forme di culto, dall’acquisizione di usi, costumi, tecnologie alla scelta di pratiche mediche. Ma il circolo delle eredità non si esaurisce qui, né è solo circoscritto al mondo antico. Se al giorno d’oggi noi chiamiamo Greci gli Elleni è perché i Romani li denominavano Graii. Ma, se i Romani così li definivano, è proprio perché gli Elleni di Cuma si dovevano autodefinire Graikoi. Nome di fatto distintivo solo di poche genti marittime della Beozia e della limitrofa costa dell’Eubea, ma che i Romani per errore recepirono come universale trasmettendolo fino a noi.
Nasso e Leontini
Come la città di Cuma è la più antica colonia greca di Italia, così Nasso lo è della Sicilia. Ed essa pure è fondata dagli Eubei di Calcide nella seconda metà dell’VIII secolo, probabilmente nell’anno 734.
La città sorgeva ai piedi dell’odierna Taormina, sulla piccola penisola di Schisò, in un sito che costituiva il pri...