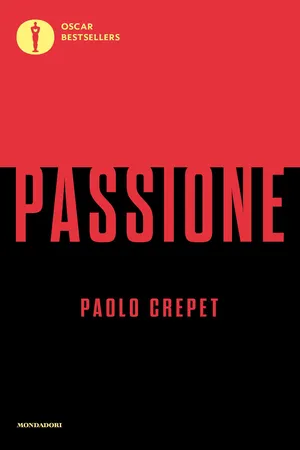L’appuntamento con Salvatorea è alla fermata del tram in piazzale Roma, a Venezia. Scendo dall’auto che mi ha portato lì, il grande slargo è ingombro di comitive di turisti, pullman, vigili, taxisti. Non l’ho mai incontrato prima, so che è giovane e che è accompagnato dal suo editore. Mi guardo attorno, sotto la pensilina vedo le sagome di due persone che sembrano in attesa, forse è lui. Ci salutiamo. Percepisco una sorta di timore imbarazzato. Scelgo di parlare poco, qualche domanda a Jacopo, l’editore, mentre ci avviamo verso la sede della casa editrice, poco oltre i grandi silos di auto, in direzione del Tronchetto.
Entriamo, un grande tavolo, una tazza di caffè, un po’ d’acqua, i microfoni per la registrazione. Ci guardiamo, sorrido. Salvatore è già un po’ più rilassato, anche se forse diffida ancora, teme o, semplicemente, aspetta.
«Ti do del tu… potresti essere mio nipote. L’idea di parlare con te mi è venuta perché sto scrivendo un libro sulla passione… Una parola che credo non sia estranea al lavoro di scrittura e, soprattutto, alla tua scelta di vita. È da qui che vorrei cominciare. Tu hai vent’anni, vent’anni difficili. Una persona che fa il mio lavoro cerca di intuire qualcosa dei nodi delle esistenze: nodi molto precoci, i tuoi, interni ed esterni, immagino… Siccome penso che a quell’età, e anche dopo, non ci sia nulla d’individuale, e che tutto abbia a che fare con il contesto familiare e sociale – più familiare che sociale, direi, perché quando si è ancora bambini la famiglia è la società e viceversa – credo che da lì sia iniziato il… come definiresti la relazione con i tuoi?»
«Una simbiosi negata, rotta, quella con mia madre. Lei è stata molto protettiva nei miei confronti, soprattutto nei primi cinque anni di vita, poi è venuta a mancare, nel senso che è caduta in depressione per questioni non solo sue.»
«Quindi ti è venuta a mancare… prima il suo accudimento intenso, poi un distacco doloroso perché non rispondeva più alle tue aspettative… È andata così?»
«Sì, in realtà la sua depressione è difficile da descrivere perché è diventata praticamente un vegetale, nel senso che dovevamo imboccarla, lavarla… aveva paura che i telefoni andassero a fuoco…»
«Quindi, qualcosa di più di una depressione, quella che si chiama psicosi depressiva, un quadro molto più complesso come saprai, da cui non è uscita…»
«Sì, ci sono stati vari tentativi, ci sono stati periodi, brevi, in cui stava bene, poi andava di nuovo in depressione. Infine c’è stato il ricovero, cioè il miracolo: quindici giorni in una clinica. Lei diceva di essere rinata.»
«Nel senso che lei ha deciso che era rinata.»
«Non è che l’ha deciso, lei diceva che era rinata.»
«Secondo te, è stato così?»
«In quindici giorni non si può rinascere. Penso che si sia sentita al sicuro, perché è impossibile che i medicinali in quindici giorni facciano rinascere una persona, la portino a stare bene, no?»
«Credo che la psichiatria sia per certi versi abbastanza immatura dal punto di vista scientifico e per altri molto prossima all’arte, quindi a qualcosa di imprevedibile. Non siamo molto lontani da quello che stavi raccontando, perché quei quindici giorni possono essere stati in qualche modo un imponderabile, visto che né tu né io crediamo nei riti voodoo o nei guaritori… Tu mi dici: quindici giorni di farmaci non possono aver compiuto un miracolo, io però sono laico…»
«Anch’io arranco nel buio, so bene di non aver sicurezze.»
«In ogni caso, in una clinica è stata ricoverata, il ritorno a casa c’è stato. Cosa è successo, secondo te, quando è tornata a casa?»
«Non ricordo nulla di quel periodo, se non frammenti di cose… Avevo dai cinque ai nove, dieci anni… ho rimosso quel periodo.»
«C’è un motivo per cui a un certo punto hai smesso di voler capire e hai in qualche modo anestetizzato una parte della tua mente… nel senso che ha smesso di funzionare: non vedeva più, non ascoltava più, non sentiva più… la vita andava avanti ma tu ti eri messo da parte. È lì che è iniziata la tua strada parallela.»
«Dopo il primo ricovero, pensavo di essere guarito perché mia madre mi diceva: se tu verrai ricoverato, ti accadrà la stessa cosa, rinascerai giusto… Così quando sono uscito… era il 2015 e avevo diciassette anni…»
«E dai dieci ai diciassette cosa è successo?»
«Bruttissimo periodo: medie, quindi bullismo… a scuola erano sicuri che io fossi omosessuale, soprattutto in prima media, e quando dicono la differenza tra le elementari e le medie si sente… io a livello di studio non l’ho sentita, non più di tanto, ma a livello sociale… una differenza abissale, penso che già dal primo giorno ho capito che non sarebbe stato un bel periodo.»
«Perché iniziava il giudizio… Tua madre non ti giudicava?»
«Mia madre no.»
«Tua madre non ti ha mai chiesto della tua omosessualità?»
«No. Ne abbiamo parlato qualche anno più tardi, le ho detto: “Mamma, ma tu lo sapevi che ero omosessuale, lo sapevano tutti”, e lei mi ha risposto: “Sì, lo sapevo, ma c’era una parte di me che sperava che tu non lo fossi; speravo, perché il mondo è cattivo con questi individui e quindi non volevo che tu passassi questo tipo di problemi”. In quel periodo nessuno lo sapeva perché non l’ho mai detto a nessuno.»
«Tranne a te stesso… Quando l’hai saputo?»
«È da quando avevo cinque anni che lo so, guardavo gli altri bambini e… sapevo che c’era qualcosa di diverso.»
«In te o in loro?»
«In me.»
«E quindi pensavi di essere sbagliato?»
«No, da bambino no, era una cosa normale per me, mi sentivo diverso ma non pensavo che fosse così brutto essere diversi, no, poi però è iniziata l’adolescenza, le medie e lì ho capito che c’era qualcosa di sbagliato.»
«Sbagliato o spietato?»
«Sbagliato, spietato anche, sì… Ho sentito spietatezza da parte degli altri, e anche da parte di Dio. Credevo moltissimo, giravo sempre con la Bibbia… Lo facevo per gli altri, così capivano che credevo in Dio e che ero una brava persona, però mi piaceva l’idea di avere al mio fianco qualcuno di superiore, qualcuno di grande.»
«La prima media, il bullismo… La strada che si inclina verso il basso…»
«Sì, poi nell’estate tra la seconda e la terza media è successo che ho realizzato di essere omosessuale, l’ho capito veramente e volevo suicidarmi, buttarmi dal balcone, ho scritto addirittura delle lettere indirizzate ai miei parenti in cui davo la colpa a ciascuno di loro per non essermi stati accanto, ma non l’ho mai fatto.»
«Ne avevi scritto una anche a tua madre?»
«Sì, anche a lei.»
«La lettera più atroce è stata quella a tua madre o a tuo padre?»
«A mio padre.»
«C’è qualcosa di quelle lettere che scriveresti ancora adesso?»
«Forse sì.»
«Quando è iniziato il rancore verso di lui, verso i tuoi?»
«Sempre stato.»
«Per non aver capito…»
«Si vedeva che soffrivo, stavo sempre in camera sul letto. Dato che sapevano, perché sapevano, avrei voluto che venissero e mi dicessero: “Lo sappiamo, va tutto bene, siamo dalla tua parte, puoi stare tranquillo”. Invece no. Poi c’è stato il giorno in cui i miei compagni sono stati violenti fisicamente verso di me, è successo in prima media.»
«E ti hanno picchiato?»
«Sì. Inizialmente una persona, poi se ne sono aggiunte altre.»
«Ti hanno fatto male?»
«Sì.»
«Più fisicamente o moralmente?»
«Tutte e due. Stavo uscendo dalla scuola e c’è una lunga discesa che porta a uno spiazzo e un ragazzo mi è venuto da dietro con una penna in mano e ha iniziato a darmi dei colpi, sono caduto, però gli altri continuavano a camminare e non si fermavano, mi hanno calpestato, poi mi sono alzato, sono arrivato fino allo spiazzo, mi hanno raggiunto altre persone, mi hanno buttato a terra, mi sono alzato ancora, la gente mi guardava, compresi i genitori. Volevo prendere il bus, poi ho pensato che non era il caso e ho chiamato mio padre e gli ho chiesto di venirmi a prendere. Lui mi ha portato dalla preside che ha detto che dovevo imparare a farmi le ossa.»
«E tuo padre era d’accordo?»
«Sì, era d’accordo, voleva farmi fare boxe, ma ho detto di no....