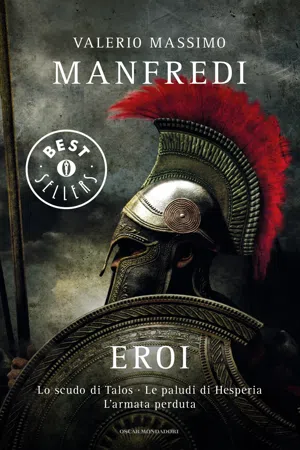ABIRA è la voce narrante del romanzo.
ABISAG, ragazzina che soccorre Abira.
AGASÌAS di Stinfalo, comandante di una delle grandi unità dell’esercito greco.
AGHÌAS di Arcadia, comandante di una delle grandi unità dell’esercito greco.
ANAXIBIOS, ammiraglio spartano di stanza a Bisanzio.
ARIEO, comandante del contingente asiatico dell’esercito di Ciro.
ARISTONIMO di Metidrio, soldato greco, uno dei più valorosi dell’esercito.
ARKAGORAS, ufficiale greco.
ARTASERSE, il Gran Re, fratello di Ciro e Imperatore dei Persiani.
CALLIMACO, soldato greco.
CIRO, secondogenito del Re di Persia, governatore di Lidia.
DEMETRIO, giovanissimo soldato greco.
DEUXIPPO, soldato greco.
DURGAT, prigioniera persiana, un tempo al servizio della Regina Parisatis.
EPIKRATES, ufficiale greco.
EUPITO, tanagrino, luogotenente di Proxenos.
EURILOCO di Lusi, giovanissimo soldato greco.
GLUS, cavaliere alle dipendenze di Arieo.
KLEANOR di Arcadia, comandante di una delle grandi unità dell’esercito dei Diecimila.
KLEARCHOS, comandante spartano del corpo di spedizione dei mercenari.
KLEONIMOS di Metidrio, soldato greco fra i più valorosi.
KTESIAS, medico greco di Artaserse.
LICIO di Siracusa, comandante di cavalleria insieme a Xeno.
LYSTRA, giovane prostituta al seguito dell’esercito.
MASABATE, eunuco persiano.
MELISSA, concubina di Ciro.
MENON di Tessaglia, comandante di una delle grandi unità.
MERMAH, ragazzina che soccorre Abira.
MITRIDATE, generale persiano.
NEON di Asine, ufficiale del battaglione di Socrate e aiutante di campo di Sophos.
NETO (Sophainetos) di Stinfalo, ufficiale greco.
NICARCO di Arcadia, giovane soldato greco.
PARISATIS, Regina di Persia, madre di Artaserse e Ciro.
PHALINOS, messo del Gran Re.
PROXENOS di Beozia, comandante di una delle grandi unità, amico di Xeno.
SEUTE, re barbaro di Tracia.
SOCRATE di Achaia, comandante di una delle grandi unità.
SOPHOS (Cheirisophos), unico ufficiale regolare d’alto grado dell’esercito spartano.
TIMÀS (Timasion) di Dardania, comandante di una delle grandi unità.
TIRBAZ (Tiribazo), satrapo degli Armeni e “occhio del Gran Re”.
TISSAFERNE, cognato di Artaserse e generale del suo esercito.
XANTHI (Xantikles) di Achaia, comandante di una delle grandi unità.
XENO (Xenophon), giovane guerriero ateniese, si arruola nell’esercito mercenario di Ciro per scrivere il diario della spedizione.
Il vento.
Soffia senza sosta attraverso le strettoie del monte Amano come dalla gola di un drago e si abbatte sulla nostra pianura con violenza disseccando l’erba e i campi. Per tutta l’estate.
Spesso per la maggior parte della primavera e dell’autunno.
Se non fosse per il ruscello che scende dai contrafforti del Tauro non crescerebbe nulla da queste parti. Solo stoppie per magri armenti di capre.
Il vento ha una sua voce, continuamente modulata. A volte è un lungo lamento che sembra non doversi placare mai; altre volte un sibilo che s’insinua di notte nelle crepe dei muri, nelle fessure tra i battenti delle porte e gli stipiti, avvolgendo ogni cosa con una foschia sottile e arrossando gli occhi e inaridendo le fauci anche quando si dorme.
A volte è un rombo che porta con sé l’eco del tuono sui monti e lo schioccare delle tende nomadi nel deserto. Un suono che ti penetra e fa vibrare ogni fibra del tuo corpo. I vecchi dicono che quando il vento romba a quel modo qualcosa di straordinario sta per accadere.
Ci sono cinque villaggi nella nostra terra: Naim, Beth Qadà, Ain Ras, Sula Him e Sheeb Mlech. In tutto vi abitano poche centinaia di persone e ognuno di essi sorge su un piccolo rialzo del terreno costituito dai resti di altri villaggi dissolti dal tempo, costruiti e poi abbandonati e di nuovo ricostruiti uno sull’altro nello stesso posto, con lo stesso fango seccato al sole. Ma gli amministratori del Gran Re li chiamano “I Villaggi di Parisatis” dal nome della Regina Madre.
Li chiamano anche “I Villaggi della Cintura” perché tutto il nostro lavoro, tutto quello che produciamo e riusciamo a vendere, tolto quanto ci serve per sopravvivere, è destinato ad acquistare ogni anno una nuova, preziosa cintura per la veste della Sovrana. Alla fine dell’estate arriva un persiano riccamente vestito scortato da numerose guardie del corpo a prelevare i guadagni che i nostri genitori hanno racimolato in un anno di durissimo lavoro. Ci lascia esposti al rischio della fame e alla certezza della miseria soltanto per comprare un’altra cintura a una donna che ne ha già a decine e sicuramente non ha bisogno di averne una in più. E ci dice anche che per noi è un onore e che ne dovremmo essere fieri. Non a tutti è dato di provvedere a un capo di vestiario per un membro così importante della casa reale.
Ho provato più volte a immaginarla, quella casa, ma non ci riesco, tali e tante sono le storie che circolano su quella dimora iperbolica. C’è chi dice che è a Susa, altri dicono che si trova a Persepoli, altri ancora a Pasargade sul grande altopiano. Forse si trova in tutti quei luoghi contemporaneamente, forse in nessuno. O forse sorge in un luogo a eguale distanza da tutte quelle città.
Io vivo in una casa con due stanze, una per dormire, una per consumare i pasti. Il pavimento è in terra battuta ed è forse per questo che tutto ciò che mangiamo sa di polvere; il tetto è fatto di tronchi di palma e di paglia. Quando andiamo al pozzo ad attingere acqua, le mie amiche e io, ci fermiamo a chiacchierare, a fantasticare, a costo di buscarle quando torniamo troppo tardi.
Spesso sogniamo a occhi aperti di vedere arrivare un giovane bello, nobile, amabile, che ci porti via da questo luogo dove ogni giorno è uguale all’altro, anche se sappiamo bene che ciò non potrà mai accadere. Ma sono contenta ugualmente: mi piace essere al mondo, lavorare, andare al pozzo con le mie amiche. Sognare non costa nulla e per un po’ è come vivere un’altra vita: quella che tutte avremmo voluto e che non abbiamo né avremo mai.
Un giorno, mentre andavamo al pozzo, la forza del vento ci investì facendoci vacillare e piegare in avanti per reggerne la spinta potente. Lo conoscevamo: era il vento che romba!
Tutto fu immerso nella foschia per qualche tempo, una caligine densa che oscurava ogni cosa. Il disco del sole era l’unica cosa che si distingueva con chiarezza, ma il suo colore aveva una insolita tonalità rosata. Sembrava sospeso nel nulla, su una landa senza confine né forme definite, su un paese di spettri.
E apparve in quella nebbia una forma indistinta che sembrava muoversi fluttuando nell’aria.
Un fantasma.
Uno degli spiriti che al tramonto escono di sottoterra per addentrarsi nella notte appena il sole si nasconde oltre l’orizzonte.
– Guardate – dissi alle mie amiche.
La figura si delineava, ma il volto restava invisibile. Alle nostre spalle sentivamo i rumori della sera: i contadini che tornavano dai campi, i pastori che spingevano le greggi verso gli ovili, le madri che chiamavano i bambini. Poi, a un tratto, si fece silenzio. Il vento che romba tacque, la caligine lentamente si dissolse. Alla nostra sinistra apparve il gruppo di dodici palme che contornava il pozzo, alla destra la collina di Ain Ras.
Al centro lei.
Si poteva distinguere ormai con contorni netti: la sua figura, il volto incorniciato da lunghi capelli scuri. Una donna giovane, molto bella.
– Guardate! – ripetei. Come se quella immagine non fosse già al centro dell’attenzione di ognuno. La figura esile procedeva lentamente quasi sentisse il peso degli sguardi gravare sempre di più su di lei a ogni passo che l’avvicinava al limitare di Beth Qadà.
Ci voltammo e vedemmo che molti uomini si erano radunati all’ingresso del villaggio facendo muro all’approssimarsi della donna. Vi fu chi gridò qualcosa: parole terribili, cariche di una violenza che non avevamo mai conosciuto. Accorsero anche le donne e una di loro urlò: – Vattene! Va’ via finché sei in tempo! – ma lei non udì o non volle ascoltare. Continuò per la sua strada. Ora anche il peso di quell’odio gravava su di lei e l’opprimeva, ne appesantiva il passo.
Un uomo raccolse da terra una pietra e la scagliò. Fallì il bersaglio di poco. Altri raccolsero pietre e le lanciarono contro la donna che vacillò. Una pietra la colpì al braccio sinistro e, subito dopo, un’altra al ginocchio destro la fece cadere. Si rialzò a stento. Con lo sguardo cercava invano tra quella folla feroce un viso amico.
Gridai anch’io: – Lasciatela stare! Non fatele del male!
Ma nessuno mi ascoltò. Il lancio di pietre si trasformò in una gragnuola. La donna cadde in ginocchio.
Benché non la conoscessi, benché non sapessi nulla di lei, vedevo in quel suo resistere sotto una grandine di pietre qualcosa di miracoloso, un evento che mai si era manifestato in quell’angolo dimenticato dell’Impero del Gran Re.
La lapidazione continuò finché la donna non diede più segno di vita. Poi gli uomini si voltarono e rientrarono al villaggio. Pensavo che presto si sarebbero seduti a tavola e avrebbero spezzato il pane per i loro figli e mangiato il cibo preparato dalle loro mogli. Uccidere a sassate, da lontano, non macchia le mani di sangue.
Mia madre doveva essere fra quella folla perché mi sentii chiamare: – Vieni qui, stupida, muoviti!
Eravamo tutte impietrite per quello che avevamo visto: una cosa che non saremmo state nemmeno capaci di immaginare. Fui la prima a riscuotermi e mi avviai verso casa. Vincendo il ribrezzo passai non molto distante dal corpo di quella sconosciuta, abbastanza vicina da vedere un rivolo di sangue che usciva da sotto le pietre e tingeva la polvere di rosso. Potei vedere la sua mano destra e ambedue i piedi, anch’essi insanguinati, poi distolsi lo sguardo e mi allontanai in fretta, piangendo.
Mia madre mi accolse con due ceffoni e per poco non lasciai cadere la brocca dell’acqua. Non c’era motivo per picchiarmi, ma immaginai che volesse sfogare la tensione e l’angoscia che aveva provato nel veder uccidere a colpi di pietre una persona che non aveva fatto male a nessuno.
– Chi era quella donna? – chiesi senza badare al dolore.
– Non lo so – rispose mia madre. – E stai zitta. Capii che stava mentendo; non feci altre domande e mi diedi da fare per preparare la cena. Mio padre entrò mentre mettevo in tavola: mangiò a testa bassa con la faccia sulla scodella e senza proferire parola. Poi passò nell’altra stanza e subito dopo udimmo il suo respiro pesante. Mia madre lo raggiunse appena venne il tempo di accendere la lucerna e io chiesi di poter restare ancora alzata al buio. Non disse nulla.
Passò parecchio tempo. L’ultimo chiarore della sera si spense e scese la notte, una notte di luna nuova. Mi ero seduta vicino alla finestra che tenevo socchiusa per vedere le stelle. Si udivano abbaiare i cani: forse sentivano l’odore del sangue o la presenza di quel corpo sconosciuto che giaceva là fuori coperto di sassi. Mi chiedevo se il giorno dopo l’avrebbero seppellita o se l’avrebbero lasciata a marcire sotto le pietre.
Il vento invece taceva, come se quel delitto avesse ammutolito anche lui, e tutti dormivano ormai a Beth Qadà. Ma io no. Non avrei mai potuto cedere al sonno perché sentivo che lo spirito di quella donna vagava inquieto per le strade del villaggio assopito cercando qualcuno da affliggere con il suo stesso tormento. Incapace di reggere l’angoscia che mi assaliva nel buio della mia casa e incapace di addormentarmi sulla stuoia stesa in un angolo della cucina, alla fine uscii e la vista dell’immensa volta del cielo stellato mi diede un po’ di pace. Trassi un lungo respiro e mi sedetti in terra accanto al muro ancora tiepido e lì restai con gli occhi spalancati nell’oscurità ad aspettare che il battito del mio cuore si calmasse.
Mi accorsi dopo qualche tempo di non essere l’unica a non poter prendere sonno nel villaggio: un’ombra mi passò a poca distanza, silenziosa, ma l’andatura era inconfondibile e riconobbi una delle mie amiche.
La chiamai: – Abisag.
– Sei tu?… Mi hai fatto morire di spavento.
– Dove vai?
– Non riesco a dormire.
– Nemmeno io.
– Vado a vedere quella donna.
– È morta.
– Perché allora i cani continuano ad abbaiare?
– Non lo so.
– Perché sentono che è viva e hanno paura.
– Forse temono che il suo spirito li tormenti.
– I cani non hanno paura dei morti. Solo gli uomini. Io vado a vedere.
– Aspetta, vengo anch’io.
Ci incamminammo assieme consapevoli che se le nostre famiglie lo avessero scoperto ci avrebbero massacrato di botte. Strada facendo, arrivate vicino alla casa di Mermah, l’altra nostra amica, la chiamammo a bassa voce da sotto la finestra e battemmo ...