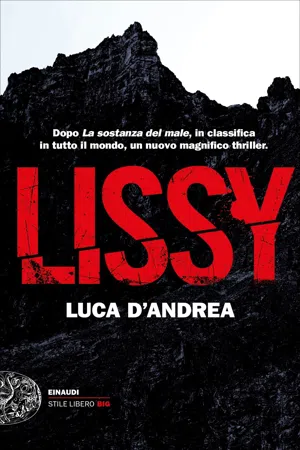Due colpi leggeri e quelle parole: Mordi, mordi, rosicchia, la mia casetta chi rosicchia?1
Marlene, ventidue anni, un metro e sessanta o poco piú, occhi blu malinconia, un neo alla fine del sorriso, indubbiamente bella e indubbiamente spaventata, si guardò riflessa nell’acciaio della cassaforte e si diede della stupida. Metallo, non il marzapane della fiaba. E nessuna strega nei paraggi.
È la paura, si disse, solo quella.
Sciolse le spalle, fermò il respiro, come suo padre prima di premere il grilletto del fucile, svuotò i polmoni e tornò a concentrarsi. Le streghe non esistevano. Le fiabe mentivano. Solo la vita contava, e Marlene si preparava a cambiare la sua per sempre.
La combinazione era facile da ricordare. Uno. Tre. Due. Poi un quattro. Un colpo di polso, ancora quattro ed era fatta. Cosí semplice che le mani di Marlene fecero tutto da sole.
Afferrò la maniglia d’acciaio, l’abbassò e strinse i denti.
Un tesoro.
Mazzi di banconote accatastati come legna per la Stube. Una pistola, una scatola di munizioni e un sacchetto di velluto. Da sotto la scatola spuntava un quaderno che valeva piú di tutto quel denaro moltiplicato per cento. C’erano sangue e forse anche un paio di ergastoli custoditi fra le sue pagine sgualcite: un’interminabile lista di creditori e debitori, amici e amici degli amici vergati nella scrittura piccola, sottile e inclinata di Herr Wegener. Marlene non lo degnò di una seconda occhiata. Non le interessavano la pistola, i proiettili e i fasci di banconote. Il sacchetto di velluto, invece, le fece sudare le mani. Ne conosceva il contenuto, ne conosceva il potere, e ne era terrorizzata.
Non era un semplice furto, il suo.
Chiamiamo le cose con il loro nome.
Quello che la giovane donna con il cuore in gola stava facendo era: tradimento. Marlene Taufer in Wegener, legittima consorte di Robert Wegener. L’uomo di fronte al quale tutti si toglievano il cappello: quarantadue anni passati a costruire una carriera fatta di intimidazioni, contrabbando, agguati e omicidi. Nessuno scherzava con un uomo come Wegener. Nessuno osava neppure usare il suo nome di battesimo. Per tutti Robert Wegener era Herr Wegener.
Anche per lei.
Marlene. Sua moglie.
Datti una mossa.
Il tempo stringe.
Eppure, forse proprio a causa dell’incalzare delle lancette, nell’arco di una parentesi fra un tic e un tac dell’orologio, quando Marlene aprí l’involucro di velluto, la favola prese di nuovo il sopravvento sulla realtà e lo sguardo della giovane donna incrociò quello blu, profondo e terribile, di creature minuscole e appuntite.
Coboldi.
Lo trovò persino ovvio. I coboldi amavano il metallo, il freddo e la morte: cassaforte, pistola, denaro e quaderno.
Un nido perfetto.
I coboldi reagirono con ferocia all’intrusione. Rapirono la luce della stanza, la imprigionarono nei loro occhietti crudeli e la trasformarono in un distillato d’odio cosí selvaggio che per poco a Marlene non sfuggí il sacchetto dalle dita.
Questo la fece tornare al presente. Alla cassaforte spalancata. Alla villa sul Passirio.
Cioè alla realtà.
Il sacchetto di velluto era colmo di zaffiri. Carbonio pressato che, per uno scherzo della fisica, aveva imparato a brillare come una stella. Tutta, o quasi, la fortuna di Herr Wegener stretta in pugno. Ma niente strega e niente coboldi. Perché, si disse ancora Marlene, le streghe non esistevano, i coboldi nemmeno, invece quelle pietre preziose non solo erano reali, ma erano anche la chiave per la sua nuova vita. Purché la smettesse di perdere tempo e se la filasse.
Senza piú dare retta al mondo delle favole, e senza pensare alla catena di conseguenze che aveva appena messo in moto, Marlene sigillò il sacchetto, lo nascose nella tasca interna della giacca imbottita, serrò la cassaforte, la occultò dietro il quadro, raddrizzò la schiena, diede un colpetto a un ciuffo che minacciava di finirle negli occhi e si lasciò alle spalle la camera da letto.
Percorse il corridoio, una rampa di scale, il salone, l’atrio con troppi specchi, la gradinata esterna. La notte l’accolse con un vento sottile che spirava da nord.
Non si fermò.
Mise in moto la Fiat 130 grigia e partí. La villa che svaniva nel retrovisore. Lo scorrere dei lampioni. La fede d’oro gettata fuori dal finestrino senza un ripensamento. La città addormentata. Lo sfasciacarrozze. Una breve sosta e, grazie a una busta gonfia di denaro, la Fiat 130 divenne una Mercedes W114 color panna con targa pulita, documenti in regola, pneumatici nuovi di zecca e serbatoio pieno.
Non un saluto e via verso ovest.
A parte i primi fiocchi di neve, tutto procedeva secondo i piani.
Almeno fino al posto di blocco a qualche chilometro da Malles. Un’autentica fregatura.
In fondo alla serie di curve che aveva appena infilato Marlene intravide una camionetta a lampeggianti spenti e un paio di carabinieri con l’aria di chi sta morendo di freddo. O di sonno. O forse di chi, sornione, aspetta qualcuno o qualcosa.
Herr Wegener aveva occhi e orecchie ovunque. Anche fra le divise.
Quindi: tentare la sorte o cambiare itinerario?
Non fosse stato per l’ansia e la paura Marlene avrebbe potuto tenere il suo piano al riparo dagli imprevisti. Ma ansia, paura e la neve sempre piú fitta la indussero a pigiare il freno, fare inversione e imboccare una strada secondaria, innescando una nuova serie di eventi.
La strada secondaria la portò a un’altra, piú stretta e tortuosa, che attraversava un paesino immerso nel sonno fino a un bivio (destra o sinistra? Testa o croce?) e ancora piú avanti, con la neve che si accumulava in strati.
E quando l’auto iniziò a sbandare, la ragazza con il neo alla fine del sorriso decise comunque di proseguire con un occhio alla carreggiata sempre piú in salita e uno alla cartina su cui, neppure a dirlo, quel passaggio (maledetti loro e le loro mappe piene di errori) non era segnato.
Non era vero.
La cartina era imprecisa, forse, come tutte del resto, ma sbagliata? Era il 1974, e nel 1974 l’uomo aveva già lasciato la sua impronta sulla polvere della luna: non era possibile che una cartina sbagliasse. Marlene avrebbe dovuto semplicemente accostare, tirare il freno a mano, accendere la luce dell’abitacolo, dare un paio di respiri profondi e controllare meglio. Le cose sarebbero andate in maniera diversa.
Ma Marlene non si fermò.
All’ansia si era aggiunta l’incredulità di chi si scopre perduto.
Dài gas, ma adagio, si disse, e vai avanti. Prima o poi la strada porterà da qualche parte. Un paese, un rifugio, una piazzola. Si sarebbe accontentata anche solo di uno slargo abbastanza ampio da consentirle di fare manovra e tornare indietro per sfidare il posto di blocco: tutto, pur di interrompere quella nuova, inesorabile sequenza di avvenimenti e riprendere il controllo del proprio destino.
E invece no.
Forse la neve, forse gli occhi che non riuscivano a staccarsi dalla cartina, ma all’improvviso Marlene sentí la Mercedes perdere aderenza, strappare a sinistra, compiere un testacoda e volare.
Fu spaventoso.
Il buio spazzato dai fanali. La neve scura che vorticava a sciami. Le fauci del precipizio. I tronchi degli alberi, immobili e perfettamente a fuoco in ogni dettaglio.
L’urto.
Violento.
Un tuono di dolore soffocato dagli strepiti delle lamiere squarciate. Un lamento infernale, questa volta sí, troppo simile al cigolio della porta della strega.
Marlene urlò il nome di Dio.
E mentre la montagna, nera e senza nome, incombeva su di lei, il suo grido si trasformò in un rantolo. Ma fu l’amore l’ultima cosa che invocò. L’amore che l’aveva spinta a tradire l’uomo piú pericoloso che avesse mai conosciuto. L’amore che aveva un nome.
– Klaus.
L’ultima parola di Marlene prima del buio.