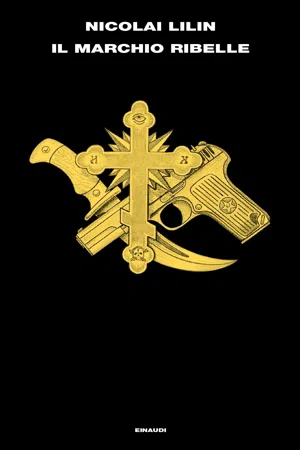Questa che sto per raccontare è una storia a cui tengo molto. È quella di «Randagio», amico fidato, e della prima volta in cui sono stato coinvolto in un omicidio.
Tutto è cominciato per via dei Fratellini. I ragazzi appartenenti a questa banda minorile provenivano dalla classe sociale che una volta forniva alla patria comunista gli aspiranti eroi, giovani che – forgiati dall’ideologia sovietica dall’asilo fino alla scuola – sviluppavano il giusto equilibrio tra fede cieca e ignoranza che permetteva ai potenti del Cremlino di giocare con le loro vite come un bambino viziato gioca con i soldatini.
La gran parte di questi ragazzi era appassionata di sport da combattimento, a scuola risultavano mediocri, preferendo l’educazione militare e passando piú tempo in palestra che sui libri. Verso i dieci anni entravano a far parte della Dosaaf, l’organizzazione governativa che in Urss svolgeva il ruolo di collegamento tra la popolazione e il ministero della Difesa. Grazie a questa organizzazione si poteva frequentare una marea di corsi gratuiti di sport paramilitari e di arte della guerra che attiravano molti bambini maschi e anche qualche femmina. Tra i membri della Dosaaf – una vera e propria casta – c’era un forte senso di appartenenza, che trasmetteva dalla piú tenera età il messaggio che ai militari fosse concesso quello che agli altri cittadini era severamente proibito. Un chiaro simbolo era il permesso accordato ai frequentatori della Dosaaf di sostituire la giacca blu dell’uniforme da scolaro con quella militare. Molti ragazzi volevano guadagnare la giacca militare per distinguersi dalla massa degli altri bambini, per aver diritto a uno statuto speciale.
Però per entrare a far parte di quell’organizzazione bisognava obbedire alle regole del governo, tra le quali rientrava anche collaborare con la polizia, non avere pregiudicati tra i famigliari ed era assolutamente vietato consumare alcol e tabacco. Ovviamente nei quartieri periferici, dove la delinquenza di strada la faceva da padrona, non c’erano ragazzi con queste caratteristiche, mentre abbondavano nei quartieri dove alloggiavano i militari e le famiglie sovietiche di fascia media.
Durante il periodo sovietico questi gruppi di bambini-soldato erano sostenuti economicamente, passavano l’estate nelle colonie piú belle del Paese, partecipavano a svariate escursioni, erano esentati dall’obbligo di lavorare nei campi o nei giardini delle fattorie collettive (in Urss accadeva spesso che le scuole mandassero per un paio di settimane i bambini in campagna ad aiutare i contadini delle fattorie statali). Organizzavano parate, gareggiavano in vari tornei e gestivano il gioco militare piú diffuso in tutta l’Urss, al quale erano obbligati a partecipare tutti i bambini, che si chiamava Zarnica, cioè «Lampo lontano». Il loro comportamento era rude e sprezzante, si atteggiavano a superiori e spesso maltrattavano i coetanei piú deboli o quelli meno fortunati di loro.
Con il crollo dell’Urss l’esercito sovietico si è trasformato in una burletta. Rimasti senza guida, spogliati dei loro privilegi e soprattutto senza piú le prospettive del futuro degno e glorioso che l’ideologia comunista aveva inculcato nelle loro teste, i bambini-soldato hanno presto capito che sarebbe stato piú utile applicare gli insegnamenti ottenuti con l’addestramento paramilitare alla vita criminale e, con invidiabili entusiasmo e determinazione, hanno cominciato a conquistarsi la loro fetta di territorio in ogni città del Paese. Ecco allora nascere le prime organizzazioni criminali conosciute come Fratellini.
Io ne ho conosciuti parecchi, di ragazzi cosí. Attingevano al concetto di criminalità russa della «fratellanza», però ne rispettavano solo quelle regole che piacevano e facevano comodo a loro, spesso infrangendo le altre. Per esempio continuavano a collaborare con la polizia, in alcuni casi contribuendo alla fusione tra la criminalità organizzata e la polizia nella Russia post-sovietica, specialmente a livello locale. Noi ragazzi di strada che ci consideravamo «dipendenti» dei banditi che lottavano per la libertà assoluta contro uno Stato-tiranno, non potevamo ritenere quei fenomeni altro che infami. Per questo con loro eravamo in uno stato di costante guerra.
A dirla tutta, tra di loro i Fratellini si comportavano con ben poco senso di fratellanza: avevano conservato quello spirito di sfrenato carrierismo che vigeva nell’esercito sovietico, dove pur di scalare un gradino era visto come lecito passare sul cadavere dei propri simili. Chiamavano il processo «selezione naturale» credendo nella ragione del piú forte. Per questo motivo all’interno dei loro gruppi c’era una costante lotta per il ruolo di leader.
Il leader decideva tutto. Poteva dare qualsiasi ordine gli venisse in mente e gli altri dovevano obbedire ciecamente. Inoltre ogni banda di Fratellini e ogni suo componente venivano chiamati con il nome del leader. Se ad esempio il capo si chiamava Kirilov, la sua banda veniva chiamata «Kirilovcy», cioè «di Kirilov». Di conseguenza ciascun membro doveva aggiungere al proprio nome «Kirilovec», a indicare la sua appartenenza e dipendenza dal leader. La stessa usanza c’era stata in Russia solo quando i padroni obbligavano i servi della gleba a trasformare i cognomi in base ai loro nomi o al luogo dove erano dislocati.
I Fratellini usavano tatuarsi i simboli di appartenenza che indicavano la loro lealtà nei confronti della propria banda e soprattutto sottolineavano l’obbedienza al capo, copiando in questo le bande di adulti cui facevano riferimento. I loro tatuaggi avevano una funzione simile a quella delle toppe dei militari; la stessa immagine, composta da simboli che rimandavano alla figura del capobanda, veniva replicata su tutti gli appartenenti alla banda.
Una delle bande piú famose di Fratellini, di cui ho già parlato, proveniva dagli Urali e si chiamava «Elefanti» perché il soprannome del loro leader era appunto «Elefante». Tutti gli appartenenti si tatuavano il simbolo dell’elefante, però per non dare nell’occhio e ingannare la polizia usavano tatuare la raffigurazione del dio indú Ganesh. Se qualcuno vedeva un giovane con quel tatuaggio poteva pensare che si trattasse di un appassionato di mitologia indú, senza necessariamente sospettare di aver di fronte un criminale. Nessuno si sarebbe domandato perché Ganesh sulla pelle di alcuni è rappresentato con una foglia di cannabis tra le zampe e nei tatuaggi di qualcun altro ha invece un coltello, oppure un’ascia o ancora dei dollari.
In realtà in questo modo i membri comunicavano il loro ruolo: chi era addetto allo spaccio di droga, chi ad azioni violente, pestaggi e omicidi, oppure incaricato di mantenere la disciplina nella banda (e, in caso, di occuparsi della punizione fisica o dell’esecuzione di un membro) e infine chi era responsabile di lavorare con il denaro, contarlo, trasportarlo oppure conservarlo e proteggerlo. Ogni banda di Fratellini aveva sviluppato il proprio modo di comunicare tramite i tatuaggi, e ciò era utile soprattutto quando piú bande si univano nelle grandi confraternite criminali, perché i tatuaggi aiutavano chi non si conosceva a individuare il proprio simile e a scoprirne la posizione gerarchica, l’incarico e la specializzazione criminale.
I Fratellini avevano il culto del fisico ed erano innamorati di se stessi, seguivano una sorta di filosofia basata su un misto fra un timido nichilismo e un narcisismo allo stadio avanzato. Amavano i vestiti sportivi che spesso diventavano la loro divisa. Per esempio, ogni banda indossava tute, cappellini e scarpe sportive di un solo marchio e spesso di un solo colore.
A Bender i Fratellini erano molto temuti, e tristemente famosi per i giri loschi legati al pizzo e alla gestione della prostituzione. Se c’era da intimidire qualche commerciante che non voleva pagare, i Fratellini ricevevano dagli adulti l’incarico di bruciargli la macchina, picchiarlo o aggredire i suoi figli mentre tornavano a casa da scuola.
In uno dei quartieri vicini al nostro c’era una grande banda di Fratellini conosciuta come «Vas´ki» perché il loro capo si chiamava Vasëk. Erano tanti, si spostavano solo in gruppo e nelle risse erano un nemico temibile perché grazie allo sport avevano un’ottima resistenza. Senza alcun dubbio si potevano permettere di atteggiarsi da padroni in qualsiasi parte della città. Gli unici che potevano tenergli testa erano un’altra banda di Fratellini di un quartiere un po’ piú lontano che si chiamava «Petrovcy», fedeli seguaci di un imbecille sadico e crudele di nome Pëtr. Tra i due gruppi non correva buon sangue, perché i rispettivi leader covavano un vecchio rancore nato nell’ambiente sportivo. Erano entrambi lottatori e si allenavano nella stessa palestra di combat-sambo, una disciplina sovietica sviluppata a partire dagli anni Venti del secolo passato per addestrare esercito e polizia al combattimento senza armi.
Vasëk aveva vinto un campionato regionale a cui Pëtr non era stato ammesso perché qualche giorno prima aveva picchiato nello spogliatoio un compagno di palestra. Pëtr non era d’accordo con la punizione disciplinare e sosteneva che Vasëk avesse convinto il loro compagno a provocarlo per avere la possibilità di essere l’unico rappresentante della scuola. Dopo che si sono diffuse queste dicerie, il loro maestro di lotta aveva deciso di porre fine al conflitto tra i due alunni e aveva proposto uno scontro leale per stabilire chi fosse il piú forte. Durante il combattimento Vasëk ha messo in difficoltà Pëtr, che si è visto costretto a usare un trucco proibito: gli ha infilato un dito nell’occhio. Allora il maestro lo ha cacciato dalla scuola. Da quel momento si è dedicato al bodybuilding: maneggiando manubri si concentrava sull’odio nei confronti del suo nemico.
Una volta l’anno, ai primi di maggio, diversi gruppi di Fratellini si radunavano nella vecchia colonia sul fiume, appena fuori Bender, dove trascorrevano insieme qualche giorno come ai tempi dell’Unione Sovietica, dedicandosi allo sport e progettando le loro attività.
Nel maggio del ’96 tra i due capi è scoppiato un litigio che si è trasformato in una rissa alla quale hanno partecipato piú di cento ragazzi delle varie bande. Durante la rissa Vasëk è stato ferito con un coltello e spinto da alcuni seguaci di Pëtr nel fiume. Tutti hanno pensato che fosse morto annegato.
Qualche chilometro piú giú stava pescando con la sua barca un mio amico, un ragazzo del nostro quartiere che tutti chiamavamo Randagio. Tirando su la rete, ha notato nel fiume Vasëk che stava annegando e lo ha tratto in salvo. Mollata la rete, Randagio ha acceso il motore della barca e ha portato il ferito nel nostro quartiere da dove un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale. Con un unico gesto Randagio ha salvato una vita umana e si è guadagnato l’inimicizia di un’intera banda di Fratellini.
All’epoca Randagio aveva qualche anno piú di me, stava per diventare maggiorenne. Era una persona semplice e molto leale, sempre pacato, mai arrogante, però possedeva uno spirito ironico e un po’ spavaldo, sapeva come tirare fuori una battuta divertente in un momento difficile.
Nelle risse si buttava in prima fila, anche se fisicamente non era molto robusto. Anzi. Lo ricordo magro, un po’ piú alto della media, con le braccia lunghe e la faccia sempre storta in qualche smorfia. Possedeva il brio di un attore, sapeva imitare le voci e i gesti delle persone, spesso ci intratteneva improvvisando piccoli spettacoli comici, prendendo in giro la gente del vicinato, oppure gli insegnanti e talvolta anche le persone famose, come cantanti, attori o politici.
La sua vita in realtà non era molto divertente e noi ragazzi ci sorprendevamo a chiederci da dove riuscisse a tirar fuori quello spirito scherzoso che ci illuminava come un piccolo sole tutto nostro. Randagio era nato in una famiglia molto povera, il padre era un buono a nulla, il tipico ubriacone disperato della periferia sovietica che un giorno si era impiccato perché era stato costretto dalla legge ad andare in ospedale per disintossicarsi. La madre, una donna distrutta dalla fatica, lavorava come venditrice di pesce al mercato con le braccia immerse nell’acqua fino al gomito estate e inverno. Alla fine si era presa una brutta polmonite che l’aveva portata alla tomba in pochi mesi nonostante gli sforzi dei medici.
Randagio era rimasto solo a dodici anni, non aveva nessuno e i servizi sociali avevano cercato di portarlo in orfanotrofio, però lui non voleva lasciare casa sua e nell’agitazione che era seguita aveva accoltellato a una gamba un assistente sociale. La gente del quartiere lo aveva aiutato a nascondersi; per quasi un’estate intera aveva vissuto a casa di uno dei nostri anziani, però poi non aveva piú avuto la pazienza di aspettare, aveva cominciato a uscire ed era stato arrestato e portato in carcere minorile per aggressione ai danni di un dipendente dello Stato. Aveva fatto due anni e mezzo di carcere e, dopo essere stato rilasciato, era stato mandato in un orfanotrofio, dal quale era fuggito per tornare nel nostro quartiere. Da quel momento aveva abitato nella rimessa per le barche di uno dei nostri anziani, che aveva trasformato in casa sua: si occupava principalmente di pesca e di furto della frutta nei giardini statali. Non poteva frequentare la scuola perché sarebbe stato riconosciuto e riportato in orfanotrofio, però in compenso leggeva molti libri che io, come anche altri ragazzi del quartiere, gli fornivo in abbondanza.
Spesso mi fermavo con lui sul vecchio molo di legno che si trovava davanti al deposito delle barche abbandonato da tempo e trasformato da noi ragazzini in una specie di area di ritrovo a ridosso del quartiere. Ci sedevamo sulla superficie quasi bollente, che il sole aveva scaldato per tutta la giornata, immergevamo i piedi nella corrente fresca, e osservavamo come il gigantesco disco rosso lentamente sparisse dal cielo nascondendosi dietro gli alberi, lasciando sull’acqua una lunga e sottile scia purpurea, come se stesse cercando di aggrapparsi a questo mondo, di vincere ancora un altro attimo alla notte.
Ficcavamo nelle fessure tra le vecchie assi le canne da pesca, lasciando i galleggianti a mollo nella speranza che qualche pesce abboccasse prima dell’arrivo della notte. Randagio tirava fuori dalle tasche della sua vecchia e povera giacca un pezzettino di legno e con il suo coltello a scatto pazientemente intagliava delle figurine che poi regalava a tutti. In quei momenti di quiete si vedeva che era una persona felice, che si trovava nel luogo al quale era legato e viveva una vita da uomo libero, come chiunque vorrebbe.
A volte parlavamo e lui raccontava qualcosa delle sue esperienze in carcere, oppure in orfanotrofio o ancora di quando vagava per il Paese dopo essere fuggito, cercando la via di casa. Nonostante la giovane età, ad ascoltarlo mi sembrava di percepire quella sorta di nostalgia per il passato della quale sono impregnate le parole dei vecchi.
Passavo molto tempo con gli anziani del mio quartiere, e quando raccontavano qualsiasi storia, brutta o bella che fosse, sembrava provassero un sentimento di attaccamento profondo al passato. Era come se fossero stati pronti in ogni momento a tornare indietro, a rivivere tutte quelle storie che tiravano fuori dalla memoria come si fa coi vecchi vestiti tenuti dentro l’armadio.
Una volta un amico di mio nonno mi ha detto a questo proposito: «Quando ti sembra che io provi nostalgia per ciò che ti racconto, in realtà semplicemente mi sto commuovendo perché ricordo gli anni della mia gioventú, ed essendo vecchio sono sempre piú consapevole che non tornerà mai piú!»
Qualcosa di simile vedevo in Randagio, quasi lui alla sua età avesse già raggiunto una consapevo...